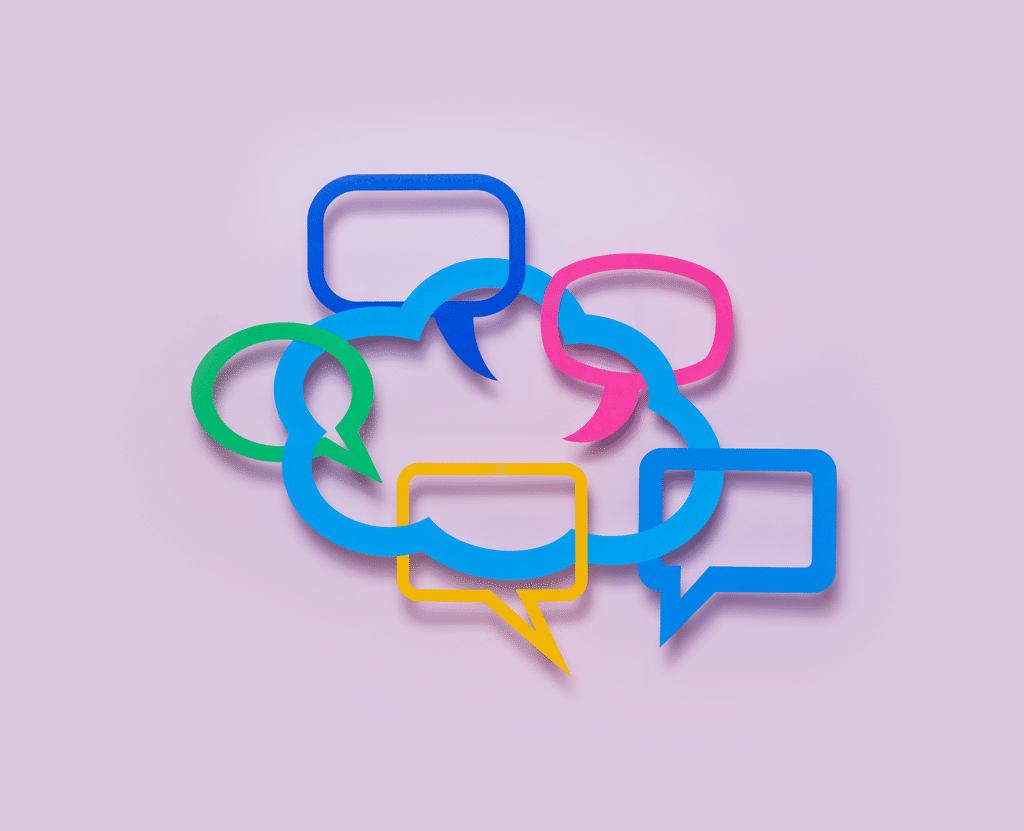Primo caso. C’è il cortesissimo architetto milanese che, sconfortato, mi scrive: “Penso che l’uso del termine caregiver abbia superato ogni livello dapprima immaginabile”.
Ed è vero che caregiver, di recente molto usato perché la cura familiare è diventata oggetto di una legge, non si può né leggere né sentire.
È anche vero che l’algida definizione burocratese “prestatore volontario di cura”, che appare nell’articolo 3 della legge, non è tanto meglio (tra l’altro: “Macché prestatore volontario!” – chiosano le associazioni dei familiari delle persone con disabilità – “spesso non si tratta di scelta, ma di necessità imposta dalla carenza di servizi territoriali”).
In apertura del suo telegiornale, la sera del 27 novembre Enrico Mentana commenta: “È stato varato un piano di aiuto per chi si prende cura delle persone gravemente inferme in casa. Si usa un termine terrificante, inglese, caregiver, ma cercheremo di non usarlo mai. Questa è una promessa che vi facciamo perché non è difficile dire un aiuto, un’indennità, una sovvenzione per chi cura le persone inferme. Lo possiamo dire molto più chiaramente in italiano”. Difficile non essere d’accordo.
Un altro termine astruso, whistleblower (letteralmente: chi soffia nel fischietto) è al centro della legge di salvaguardia dalle punizioni aziendali per quei dipendenti che denunciano irregolarità. La legge è stata approvata poche settimane fa. Già un anno prima il gruppo Incipit dell’Accademia della crusca aveva proposto di impiegare “allertatore civico”.
Le parole che abbiamo già
Per quanto riguarda i caregiver, tra l’altro, non è che ci manchino parole per definire la funzione. Per esempio curante, il termine che il cortesissimo architetto suggerisce al termine del suo scritto, o curante familiare, o familiare curante, già potrebbero andar bene. Il fatto è che, a furia di attivare immediatamente il curioso automatismo che ci spinge a cercare nuove parole altrove, ci dimentichiamo di averle già, le parole giuste.
Secondo caso. C’è l’infuriato signore che mi invia un messaggio con oggetto RABBIA e poi, tutto in maiuscole, inveisce contro il ristorante dove ha ordinato una pizza napoletana, per vedersi recapitare “questo”.
Il “questo” sono le due foto che l’infuriato signore si prende la briga di scattare e di allegare, e che vedete qui sotto.
Vabbè, lo capisco: nel progetto della confezione c’è un’intenzione ironica e la voglia di risultare simpatici. Ma, come diceva Oscar Wilde, che di ironia qualcosa sapeva, “le cose peggiori sono sempre fatte con le migliori intenzioni”. E dai, non è che scrivere “preparata al momento” sia così antipatico, banale e fuori moda, no?
Poi ci sarebbero alcune altre cosucce di cui tener conto.
Affermazioni generiche e insulse
In primo luogo, a una persona di madrelingua inglese un testo così non appare simpatico, ma sbagliato. E può apparire irritante agli italiani che l’inglese lo sanno bene. In secondo luogo, un testo così risulta proprio incongruo adesso che la pizza napoletana è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco. In terzo luogo: che senso ha fare un’affermazione forte sulla qualità del prodotto, e contemporaneamente scherzarci sopra?
Va detto che i signori della pizza “super italian” non sono soli. Nel modernissimo Food district (è proprio scritto così) di Porta Nuova, a Milano, c’è perfino una Italian bakery, che vanta la sua italianità, essendo in Italia, in inglese. Peccato che in tutto il resto del globo (tranne che in Italia, evidentemente) la lingua del cibo sia ormai da anni l’italiano. E che, grazie a questo fatto, l’italiano sia la seconda lingua più usata nelle insegne commerciali del mondo.
Anche l’inglese meriterebbe di essere usato quando serve e possibilmente con perizia
Terzo caso. C’è il giovane e brillante professionista che mi tira in ballo su Facebook scrivendo: “Ogni volta che sento in radio la pubblicità del CityLife di Milano, il moderno ‘shopping district che unisce food, fashion ed entertainment’ mi chiedo: prenderemo mai coscienza del fatto che non sappiamo l’inglese e che continuare a usarlo a sproposito è controproducente, oltre che estremamente triste?”.
E sorvoliamo sulle pronunce radiofoniche sommarie. E sul fatto che spesso l’inglese mascheri affermazioni generiche e insulse, che in italiano apparirebbero per quel che sono, e che in inglese suonano così attraenti solo perché funzionano da puro accessorio sonoro.
Dovremmo almeno renderci conto che, a parlare inglese un po’ a capocchia, si fanno anche dei begli erroroni. Succede con il recente slogan “every day, every pay “(letteralmente: ogni giorno, ogni paga, invece che ogni giorno, ogni pagamento , payment) puntualmente commentato da Licia Corbolante.
Nessuna bacchetta magica
I tre diversi messaggi che ho riunito in questo articolo mi sono arrivati a distanza di pochissimi giorni l’uno dall’altro, a testimoniare un fastidio diffuso per un impiego tanto decorativo quanto incongruo dell’inglese: un prezzemolo verbale da aggiungere a qualsiasi testo. E invece, povera lingua anche lui, l’inglese meriterebbe di essere usato quando serve e possibilmente con perizia: scelta assai più faticosa, però.
Infine: anche se da qualche anno ragiono su questi temi (l’articolo intitolato 300 parole da dire in italiano è del 2014) e se periodicamente ci torno, non ho una bacchetta magica per cambiare le cose, e scrivere a me serve a poco (e no, anche se gli esempi da fare sarebbero mille, nelle prossime settimane non pubblicherò un nuovo articolo su questo tema).
Potrebbe servire di più, invece, manifestare il proprio disappunto scrivendo all’azienda o all’istituzione che sta usando l’inglese a sproposito e senza motivo: chi prende questa decisione lo fa anche perché immagina che la scelta sia apprezzata. Se scopre che non è vero, magari ne tiene conto.
Bisogna però sempre scrivere, se si decide di farlo, con tutta l’indispensabile cortesia: altrimenti, in qualsiasi lingua si scriva e di qualsiasi lingua di tratti, si passa automaticamente dalla parte del torto.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it