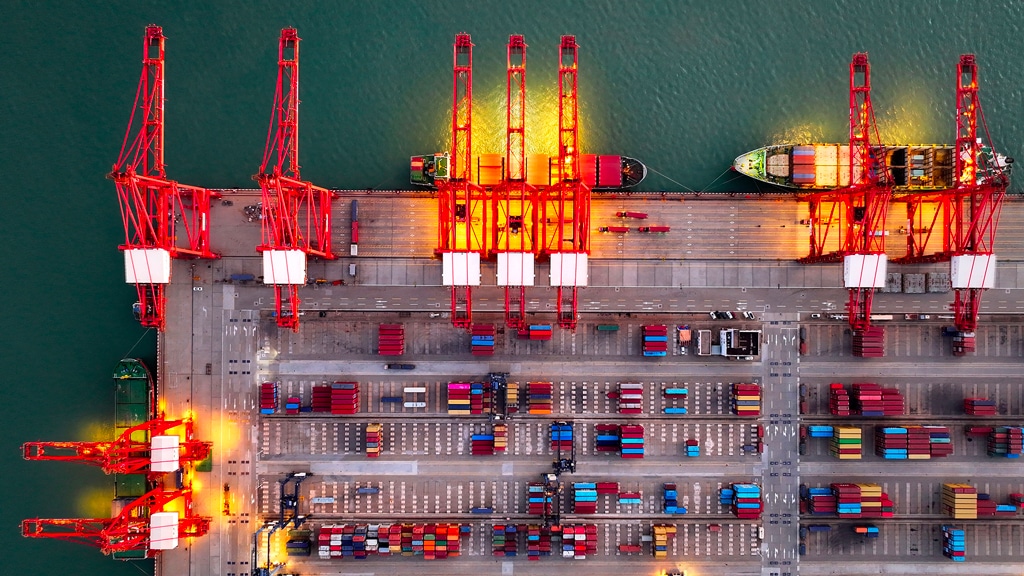Se c’è qualcosa che esemplifica bene il potere della misurazione nella vita contemporanea è il burro di arachidi del National institute of standards and technology (Nist) degli Stati Uniti. Una confezione di tre barattoli da 170 grammi costa 1.069 dollari. Il prezzo esorbitante non è dovuto alla presenza di ingredienti rari né a un processo di produzione complesso, ma al rigore con cui è stato analizzato il contenuto di ogni barattolo. Questo burro di arachidi è stato congelato, riscaldato, essiccato e saponificato per poterlo misurare in base a diversi parametri. Chi ne compra un barattolo può essere certo non solo dell’esatta proporzione di carboidrati, proteine, zuccheri e fibre in ogni suo cucchiaio, ma della prevalenza – fino al milligrammo – di decine di diverse molecole organiche e oligoelementi, dal rame al magnesio, dall’acido docosanoico a quello tetradecanoico. Difficilmente un atomo è sfuggito al controllo del Nist e, di conseguenza, ogni barattolo contiene il burro di arachidi più studiato che esista. Ha anche una consistenza liscia e non granulosa. Il burro di arachidi appartiene a un catalogo di più di 1.300 materiali di riferimento (standard reference materials, o srm), creati dal Nist per soddisfare le esigenze dell’industria e dello stato. È una bibbia della metrologia – la scienza della misurazione – e testimonia l’importanza delle misure invisibili nella nostra vita. Ogni volta che qualcosa dev’essere verificato, certificato o calibrato – dai livelli di emissione di un motore diesel alle proprietà ottiche del vetro destinato ai laser ad alta potenza – il catalogo srm offre gli standard di riferimento per fare i controlli. La maggior parte degli oggetti esaminati è banale: calcestruzzo e ferro per l’industria delle costruzioni; spinaci in scatola e cacao in polvere per quella alimentare. Ma altri sembrano presi dalla dispensa di dio: lingotti di elementi purificati e bombole di gas, disponibili in miscele e combinazioni finemente classificate. Alcuni sono solo stravaganti: liquami delle reti fognarie, grasso di balena e polmone umano radioattivo in polvere, disponibili rispettivamente come srm 2781, 1945 e 4351. Tuttavia, ognuno ha uno scopo. La composizione dei liquami, per esempio, è usata dalle agenzie ambientali per valutare il livello d’inquinamento delle fabbriche. Il grasso standardizzato delle balene aiuta gli scienziati a monitorare l’accumulo di sostanze contaminanti nell’oceano. Il polmone in polvere serve per valutare le conseguenze dell’esposizione umana a materiali radioattivi: è stato ricavato da settanta chilogrammi di polmone umano donati dai dipendenti del Los Alamos national laboratory, dove nacque la bomba atomica. Ogni donatore era stato esposto alle radiazioni e decise di offrire il proprio corpo alla scienza dopo la morte. I polmoni dovevano essere liofilizzati e ridotti in polvere fine per garantire l’omogeneità di ogni campione. Questo rende quasi divertenti alcune serissime note di laboratorio. “Nonostante il processo di sterilizzazione, che garantisce la sicurezza nel maneggiare il materiale, è stato più che inquietante vedere pezzi di tessuto che finivano sulle pareti e su di noi durante la macinazione. Era necessario come minimo un cambio di cravatta e di camice”, ha scritto un ricercatore del Nist. “A un certo punto abbiamo perfino visto un liquido rosso che scorreva lungo il corridoio, con pezzi di tessuto che galleggiavano”.
Calibrazione o convalida
Lo scopo è offrire ai clienti “la verità in bottiglia”, dice Steven Choquette, direttore dell’Office of reference materials (Orm) dell’agenzia. Le persone devono potersi fidare delle misurazioni. “Analizziamo fino all’ultimo atomo”, dice, sottolineando che le quantità assegnate a ogni materiale possono essere ricondotte al sistema metrico che, giustamente, il Nist contribuisce a definire. Se Choquette ha un dubbio su qualche dettaglio, può “attraversare il corridoio e parlarne con i maggiori esperti del mondo”.
Gli srm sono conservati in uno spazio di ottomila metri quadrati, dotato di congelatori e di aree di contenimento per materiali radioattivi e pericolosi. In base all’uso, ogni campione rientra nel campo della calibrazione o in quello di convalida. Convalidare significa impiegare l’srm per garantire la coerenza di determinati test industriali. Prendiamo, per esempio, l’srm 1196a: la sigaretta standard (due stecche da cento costano 446 dollari). Serve per testare l’infiammabilità di tessuti e tappezzerie. Le fiamme innescate dagli oggetti pensati per essere fumati (come le sigarette) sono la principale causa di morte per incendio nelle case degli Stati Uniti, osserva Choquette, e uccidono centinaia di persone ogni anno. Per ridurre questi rischi, la legge fissa vari standard per i tessuti e gli arredi resistenti al fuoco. Ma affinché i test siano coerenti tra i vari produttori, ci dev’essere una sigaretta standardizzata con cui innescare ogni incendio. È l’srm 1196a. Non è diversa da quelle normali, ma la sua omogeneità è stata testata e verificata dal Nist. È questo che garantisce l’agenzia, dice Choquette: l’uniformità. E il risultato può salvare vite umane.
L’altro uso principale degli srm è la calibrazione: il materiale è la base di riferimento per verificare la validità di altri test. Supponiamo che siate un’azienda alimentare e vogliate controllare i valori nutrizionali di un prodotto. Potete comprare macchine che verificano la presenza di determinate molecole e composti, ma come fate a sapere se quei test sono accurati? Li eseguite sugli srm del Nist, il cui contenuto è stato quantificato con precisione, con strumenti più specializzati e costosi. Se i risultati dei vostri test corrispondono alle misurazioni del Nist, potete fidarvi dei vostri macchinari.
Il cubito egiziano
La misurazione come disciplina si è sviluppata per millenni prima di arrivare a raschiare il fondo di un barattolo di burro di arachidi. Seimila anni fa le prime unità standardizzate furono usate dalle civiltà che abitavano le valli dei fiumi. Nell’antico Egitto, per esempio, il cubito corrispondeva alla lunghezza del braccio umano, dal gomito alla punta del dito medio, ed era usato per misurare le piramidi. Nel medioevo il compito di regolamentare le misure per facilitare i commerci era privilegio e onere di chi governava: un mezzo per esercitare il potere sui sudditi che però, se trascurato, poteva anche diventare causa di disordini. Con il passare dei secoli le unità si moltiplicarono: nella Francia del settecento si dice che fossero in uso circa 250mila unità di misura, il che portò allo slogan rivoluzionario, “un re e una legge, un peso e una misura”.
Fu proprio quest’abbondanza a spingere gli studiosi francesi a creare il sistema metrico decimale. Un’unità come il metro – definita in origine come un decimilionesimo della distanza tra l’equatore e il polo nord – aveva lo scopo non solo di semplificare la metrologia, ma anche di incarnare un ideale politico. Il suo valore e la sua autorevolezza non erano legati alla decisione di un re, ma a calcoli scientifici, ed erano quindi, presumibilmente, uguali per tutti. Allora come oggi, le unità di misura sono progettate per garantire uniformità nel tempo, nello spazio e nelle culture, per consentire il controllo a distanza e permettere a sconosciuti di fidarsi gli uni degli altri. Quello che è cambiato dai tempi delle piramidi è che oggi spesso queste unità valgono in tutto il pianeta.
Anche se sono così numerosi, gli standard internazionali come quelli del Nist e dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (Iso) sono per lo più invisibili nella quotidianità. S’intromettono nella nostra vita solo attraverso la burocrazia, in particolare nel campo dell’istruzione e del lavoro. È a scuola che scopriamo per la prima volta cosa significa ridurre in termini di quantità. Lì siamo valutati in base ai numeri, e ci viene detto che in quel modo sarà misurato anche il nostro successo futuro. Quando cominciamo a lavorare, questi test riappaiono sotto forma di indicatori studiati per valutare prestazioni, obiettivi e risultati. All’inizio della mia carriera di giornalista, il mio lavoro era valutato principalmente in base al numero di articoli che scrivevo e alle loro visualizzazioni online. Ai miei colleghi e a me è stato insegnato ad attribuire più importanza alla quantità che alla qualità.
Nel medioevo regolamentare le misure era un mezzo per esercitare il potere
Il principio secondo cui ogni sforzo umano può essere utilmente ridotto a un insieme di statistiche è diventato uno dei paradigmi dominanti del ventunesimo secolo. Lo storico del capitalismo Jerry Z. Muller lo chiama “ossessione metrica”, un concetto onnipresente che pervade non solo il settore privato, ma anche le attività meno quantificabili dello stato, come la sanità e la sicurezza.
Viviamo nell’era della responsabilità misurata, della ricompensa per le prestazioni misurate e dell’importanza di pubblicizzare queste misurazioni attraverso la “trasparenza”, scrive Muller. E anche se, come sottolinea, la misurazione in sé non è una cosa negativa, “una misurazione eccessiva o inappropriata” distorce, devia e distrugge ciò che sosteniamo di valutare.
Le origini di questa ossessione possono essere fatte risalire all’ottocento. La capacità gestionale, in particolare negli Stati Uniti, cominciava a essere considerata una cosa a sé stante più che una competenza appresa lavorando all’interno di un settore. La spinta a razionalizzare il lavoro dei dirigenti finì per intrecciarsi con la trasformazione della produzione industriale. Gli Stati Uniti aprirono la strada a quello che sarebbe stato definito il “sistema di produzione americano”, incentrato sulla standardizzazione, la precisione e l’efficienza. Fino a quel momento, la produzione di beni di consumo era affidata agli artigiani, che fabbricavano tutto a mano. Ma con l’avvento di macchine in grado di stampare, tagliare e modellare molti componenti diversi, la produzione diventò una serie di compiti meccanici assegnati a lavoratori meno qualificati che assemblavano i prodotti. Come osservava nel 1850 un ingegnere britannico in visita alle fabbriche statunitensi, i macchinari erano usati ovunque per sostituire il lavoro manuale: “Se ne fa universalmente e volentieri ricorso”.
All’inizio del novecento questo sistema fu ulteriormente ampliato da due concetti complementari: la gestione scientifica e la produzione di massa. Quest’ultima è rappresentata benissimo dalla casa automobilistica Ford, il cui economico Modello T modificò non solo la pratica industriale ma la stessa cultura statunitense, contribuendo a creare una classe media prosperosa definita dal consumo di massa. Henry Ford affermava che le sue catene di montaggio, in cui gli operai rimanevano fermi mentre il materiale raggiungeva le loro postazioni su nastri trasportatori, erano state ispirate dalla visita di un suo collaboratore a un macello di Chicago. Lì si svolgeva il processo opposto: una “linea di smontaggio” in cui una fila di macellai smembrava le carcasse di maiale, pezzo per pezzo, e ogni individuo si concentrava su un unico compito ripetitivo.
Questa compartimentazione del lavoro portò al concetto di gestione scientifica. Il pioniere fu Frederick Winslow Taylor, un ingegnere ossessionato dall’efficienza, che sosteneva una serie di pratiche di lavoro oggi note come taylorismo. Taylor e i suoi seguaci avevano osservato gli operai e suddiviso il flusso del loro lavoro in parti che potevano essere standardizzate. L’obiettivo, diceva Taylor, era “sviluppare una scienza che sostituisse la vecchia competenza empirica degli operai”. È importante sottolineare che questo richiedeva anche un trasferimento di conoscenze – e un corrispondente spostamento del potere – dagli operai che svolgevano il lavoro ai dirigenti che lo supervisionavano.
Questo tipo di controlli è esercitato non solo nei luoghi di lavoro, ma anche in istituzioni come carceri, caserme e scuole. Il filosofo francese Michel Foucault parlava di “società disciplinare”, un mondo in cui la conformità è applicata attraverso norme rigorosamente definite. I detenuti ricevono uniformi e numeri, gli viene detto quando e dove mangiare e dormire, e vivono nella consapevolezza di essere sorvegliati da guardie invisibili. Alla fine, interiorizzano quest’autorità e controllano il loro comportamento, dice Foucault. La conformità alle norme si ottiene senza una brutalità palese, ma l’obiettivo non è “punire meno, ma punire meglio”. Il lavoro di misurazione e standardizzazione è essenziale per questo tipo di controllo.
In un articolo pubblicato dal New York Times nel 2010 (Internazionale 869), il giornalista esperto di tecnologia Gary Wolf annunciava l’inizio dell’era della quantificazione. L’uso dei dati per prendere decisioni è ormai la norma in quasi tutte le sfere della vita, scriveva. “Il feticismo per i numeri è il tratto distintivo del manager moderno. I dirigenti aziendali che affrontano azionisti ostili si riempiono le tasche di numeri. E la stessa cosa fanno certi politici in campagna elettorale, i medici che consigliano i loro pazienti e i tifosi che attaccano i loro avversari sportivi alla radio”. Gli affari, la politica e la scienza sono tutti guidati dal buon senso di ciò che può essere misurato, scriveva Wolf, e il motivo è ovvio: i numeri funzionano, rendono i problemi “meno coinvolgenti dal punto di vista emotivo e più gestibili intellettualmente”. Solo un settore resisteva al richiamo della quantificazione: “Il confortevole mondo della vita personale”. Ma anche questo, diceva Wolf, sarebbe presto cambiato.
Grazie alle nuove tecnologie – cioè alla capacità di digitalizzare le informazioni, all’ubiquità degli smartphone e alla diffusione di sensori economici – gli esseri umani hanno una capacità di automisurazione senza precedenti. All’inizio del seicento, per comprendere meglio il funzionamento del proprio metabolismo, il medico italiano Santorio Santorio costruì una serie di grandi bilance su cui poteva sedersi. Misurava costantemente il suo peso, in particolare prima e dopo i pasti e la defecazione. Oggi possiamo ottenere un mare d’informazioni simili con il minimo sforzo. Abbiamo applicazioni e gadget per monitorare il sonno, l’esercizio fisico, la dieta e la produttività. Siamo diventati fanatici delle misurazioni invisibili.
Secondo Wolf le potenzialità di queste nuove informazioni sono enormi. “Usiamo i numeri quando vogliamo progettare un’auto, analizzare una reazione chimica, prevedere l’esito di un’elezione”, scriveva. “Perché non usare i numeri su noi stessi?”. Il suo articolo è la cosa più vicina a un manifesto del movimento per la quantificazione del sé: una libera associazione di individui la cui ricerca della “conoscenza di sé attraverso i numeri” mostra fino a che punto abbiamo interiorizzato la logica della misurazione.
Le origini del movimento possono essere fatte risalire agli anni settanta, quando gli appassionati di informatica misero insieme i goffi antenati della tecnologia indossabile di oggi. Ma l’idea è arrivata all’attenzione del pubblico dopo che nel 2007 Wolf e il suo collega Kevin Kelly hanno coniato il termine “sé quantificato” e hanno fondato un’organizzazione non profit per fare proseliti. Le descrizioni del sé quantificato si prestano alla caricatura, creando immagini di Gradgrid digitali che, come il personaggio del romanzo dickensiano Tempi difficili, perseguono ossessivamente una vita ottimizzata mentre la loro anima appassisce. È anche vero che molti sostenitori del sé quantificato non fanno niente per dissipare questa immagine. Si vantano di risparmiare minuti della loro giornata con una rigorosa autosorveglianza, e di scoprire attraverso analisi sofisticate che – sorpresa sorpresa! – un buon sonno e un regolare esercizio fisico migliorano il loro umore. Il sé quantificato è semplicemente una forma di “taylorismo interiore”, scrive l’esperto di tecnologia Evgeny Morozov, e un ulteriore esempio della “moderna ricerca narcisistica di unicità ed eccezionalità”.
I sostenitori del movimento lo difendono presentandolo come la risposta alla “genericità imposta dalla conoscenza ufficiale”. Se la quantificazione ha trasformato il mondo in regole uguali per tutti che non si adattano al singolo individuo, perché non creare un proprio insieme di numeri che rispecchiano di più la realtà? Citano aneddoti di persone che si autocontrollano e i cui disturbi cronici – apnee notturne, allergie, emicranie – hanno resistito alle cure della medicina tradizionale, ma hanno ceduto alla loro abilità nel trovare schemi e modelli. Dopo mesi e anni di automonitoraggio, questi individui hanno scoperto qualche meccanismo della loro vita fino a quel momento ignorato, qualche alimento o abitudine che innescava il loro problema e hanno apportato i cambiamenti necessari per vivere felici e contenti. In questo senso, il sé quantificato sembra un tentativo di riconquistare la dimensione personale della misurazione, resistere alle astrazioni delle statistiche e adattare i calcoli alla nostra vita.
Nel suo articolo del 2010, Wolf scriveva che nel novecento si usava la psicoanalisi per svelare i misteri del sé, facendo affidamento sul linguaggio e su un “umanesimo letterario prolisso”. Questo, però, non è il mondo in cui viviamo oggi, quindi perché affidarsi a metodi obsoleti? La domanda a cui Wolf non risponde mai, tuttavia, è in che modo la precisione dei numeri può sostituire la complessità del linguaggio come strumento per l’autoesplorazione. Viene da sospettare che questa sia una caratteristica dell’essere umano piuttosto che una carenza. Limitando l’ambito dell’autoindagine a ciò che può essere misurato, i professionisti della medicina sono certi di trovare risposte. I pazienti sul divano del terapeuta, invece, devono tornare settimana dopo settimana per affrontare le complessità del linguaggio.
Diecimila passi
Quando penso a cosa significa la misurazione nella società di oggi, a com’è usata e abusata e a come interiorizziamo la sua logica, spesso finisco per concentrarmi su una cifra, diecimila passi, considerata l’obiettivo di attività quotidiana ideale e integrata in innumerevoli app di monitoraggio e programmi di fitness.
Questo numero è presentato con una tale autorità e frequenza da lasciare immaginare che sia il risultato di un’indagine scientifica, la saggezza distillata di numerosi test e prove. Ma non è così. Le sue origini risalgono a una campagna di marketing dell’azienda giapponese Yamasa Clock, che nel 1965 stava promuovendo un contapassi digitale, un gadget nuovo per l’epoca, e aveva bisogno di un nome accattivante per il prodotto. Scelse manpo-kei, diecimila passi. Ma perché quel numero? Perché il kanji per diecimila – e quindi il primo carattere del nome giapponese del prodotto,万歩計 – somiglia a una figura che avanza con sicurezza.
Oggi gli esseri umani hanno capacità di automisurazione senza precedenti
Secondo i ricercatori diecimila passi sono pochi per i bambini e troppi per molti anziani. Tuttavia, è chiaro che fare attività fisica ci fa bene e che chi si pone un obiettivo giornaliero di diecimila passi mostra meno segni di depressione, stress e ansia. Da questo punto di vista, i sostenitori del sé quantificato sembrano avere ragione: se vuoi raggiungere le persone, devi parlare una lingua che capiscono.
A proposito della misurazione nel mondo di oggi, il sociologo tedesco Hartmut Rosa suggerisce che è una caratteristica del particolare desiderio del ventunesimo secolo: strutturare la vita in base all’osservazione empirica, rendendo i nostri interessi e le nostre ambizioni una serie di sfide da superare. “Le montagne devono essere scalate, i test superati, i gradini di una carriera saliti, gli amanti conquistati, i luoghi visitati, i libri letti, i film guardati e così via”, scrive. “Per il soggetto medio tardo-moderno del mondo occidentale ‘sviluppato’, la vita di tutti i giorni ruota sempre di più intorno a una lista di cose da fare che si allunga di continuo e a nient’altro”.
Questa mentalità, aggiunge Rosa, è il risultato di secoli di sviluppo culturale, economico e scientifico, ma è stata “estremizzata” negli ultimi anni dalla digitalizzazione e dalla ferocia della sfrenata competizione capitalistica. La misurazione è stata giustamente accolta come strumento per comprendere e controllare meglio la realtà, ma mentre misuriamo senza sosta, incontriamo i limiti di questa pratica e lottiamo con i suoi effetti inquietanti sulla nostra vita.
Il mio interesse per la storia della metrologia è nato come una curiosità sull’origine di alcune unità di misura. Perché un chilogrammo è un chilogrammo, perché un metro è un metro? Ma queste domande hanno anche una motivazione più profonda: se la misurazione è la modalità con cui interagiamo con il mondo, ha senso chiedersi da dove provengono i sistemi che la compongono e se rispondono a una qualche logica? La risposta che ho trovato è no, non proprio. O meglio, c’è una logica, ma, come per i diecimila passi, è il prodotto tanto di incidenti e casualità quanto di un’attenta riflessione. Il metro è un metro perché secoli fa alcuni studiosi decisero di stabilire un’unità di lunghezza misurando il pianeta su cui viviamo. Si dà il caso che commisero degli errori nei loro calcoli, e quindi il metro sia più corto di circa 0,2 millimetri: una discrepanza minima che da allora si è tuttavia perpetuata. In altre parole: è così perché lo diciamo noi. Le misure, quindi, sono al tempo stesso significative e arbitrarie, guide rigide della nostra vita che, se vogliamo, diventano malleabili. Se non funzionano – se non sono all’altezza – possono essere modificate. ◆ bt
James Vincent è un giornalista britannico. Quest’articolo è estratto e adattato dal libro Beyond measure: the hidden history of measurement (Faber 2022), che sarà pubblicato in Italia da Mondadori.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1480 di Internazionale, a pagina 66. Compra questo numero | Abbonati