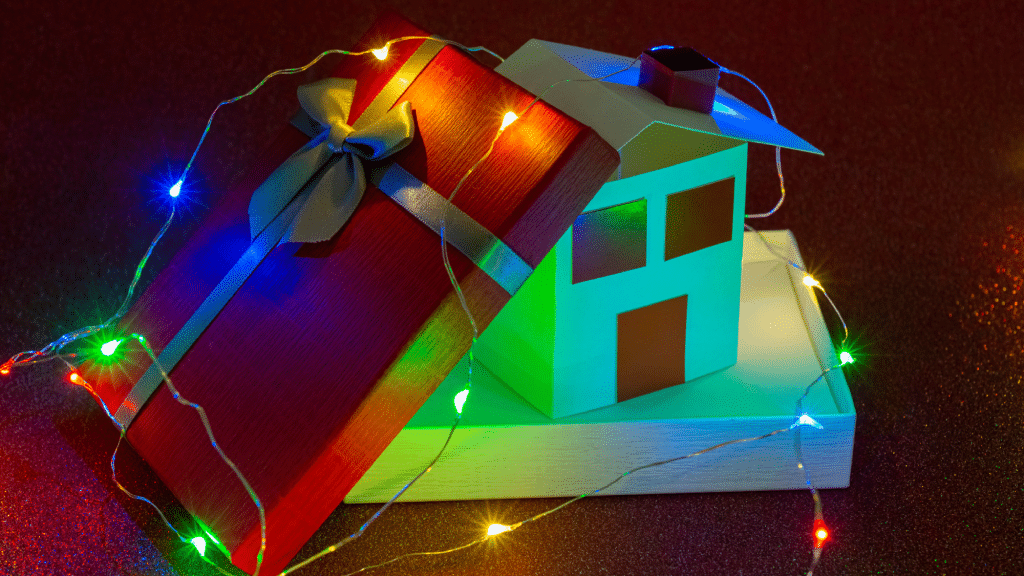“C’è un ampio sentire comune che, soprattutto in rete, si traduce in una forte insofferenza soprattutto verso gli anglicismi, percepiti come un’orda selvaggia e inarrestabile che attenta all’identità della lingua italiana”.
A scriverlo è la Treccani, che sotto il titolo Il Bel Paese dove l’OK suona fa il punto sugli anglicismi raccogliendo diversi interventi in risposta a una notevole serie di quesiti: “Vi sono pericoli reali? È proprio delle lingue e dei linguisti erigere steccati e stabilire confini? Si possono escogitare dei filtri? È sensato farlo? E quale autorità delibererebbe in materia?”.
Le posizioni espresse dagli autori sono differenti tra loro, e nel confronto diventano ancora più interessanti: faccio lo spericolato tentativo di offrirvi una sintesi e un breve commento.
Si definisce “l’osservatore romeno” il romanziere e poeta Mihai Mircea Butcovan. È in Italia dal 1991 e ha pubblicato nella nostra lingua. Racconta di aver assistito a una conferenza fitta di termini come career coaching e ability, education e goal, convention ed exciting, administration e briefing, question e happiness. Urca.
Butcovan si chiede se davvero siamo convinti che “l’esercito di parole inglesi sia liberatore”, ammette che l’inglese è utile ma esorta a farne buon uso e conclude domandandosi se ha ragione Cesare Marchi quando afferma che “siamo dei miliardari che chiedono l’elemosina all’estero”.
Licia Corbolante, traduttrice e linguista, autrice del bellissimo blog Terminologia etc parla dell’uso istituzionale dell’inglesorum. Questo può derivare dalla “maledizione della conoscenza”, come la definisce lo scienziato cognitivo Steven Pinker: il presupposto che “se lo so io, anche gli altri devono saperlo”. Ma c’è anche l’idea (infondata) che l’inglese sia più preciso. E c’è l’inglese farlocco che abbrevia spending review in spending: un nonsenso per un anglofono.
Lo dice anche Machiavelli: insieme a un fenomeno nuovo s’importa anche il termine che lo definisce
Per le istituzioni, la scelta di usare gli anglicismi è spesso frutto di conoscenze linguistiche e culturali superficiali. Il Miur, sottolinea Corbolante, dovrebbe promuovere la formazione di terminologia italiana.
Il linguista Michele Cortelazzo (qui il suo ottimo blog) ricorda che per decenni i linguisti hanno osservato l’introduzione dei forestierismi con distaccata neutralità. I casi erano tutto sommato pochi (il 4 per cento secondo il Gradit).
Poi le cose sono cambiate. Tra il 1990 e il 2003 abbiamo adottato più di 1.400 forestierismi: un terzo di quelli introdotti nel corso dell’intera storia della lingua italiana. C’è l’impressione che il fenomeno sia in ulteriore crescita. Cresce anche l’insofferenza collettiva. E l’abitudine dei politici di usare gli anglicismi sembra, dice Cortelazzo, un espediente per manipolare l’opinione pubblica.
La lingua italiana non corre pericolo
Per questi motivi l’Accademia della Crusca ha costituito il gruppo Incipit. È un servizio a favore della comunità italofona, che può così disporre di alternative a forestierismi diffusi, a volte solo per pigrizia, da potentati economici o culturali.
È diversa la posizione della linguista Roberta D’Alessandro, autrice di un recente messaggio indirizzato alla ministra Giannini “cara ministra, la prego di non vantarsi dei miei risultati”. La battaglia contro gli anglicismi, scrive D’Alessandro, è persa in partenza perché la lingua non si può indirizzare né costringere. L’italiano non corre pericolo: una parola inglese che entra nell’italiano è quasi subito adattata alla sua grammatica e resa italiana.
Gli anglofili lamentano le storpiature italiane dell’inglese, e gli italiofili si lambiccano per trovare alternative italiane anche non perfettamente corrispondenti? Significa che dei nuovi vocaboli inglesi c’è bisogno. Del resto, lo dice anche Machiavelli: insieme a un fenomeno nuovo s’importa anche il termine che lo definisce. Ma, nel momento in cui lo importiamo e lo contaminiamo, quel termine diventa “nostro”.
D’altra parte, se osserviamo la lingua che impiegano alcuni dei romanzieri più letti nel nostro paese, scopriamo che Niccolò Ammaniti, Paolo Giordano, Andrea De Carlo, Edoardo Nesi, Silvia Avallone, Antonio Pennacchi, Francesco Piccolo, Melania Mazzucco, Elena Ferrante, Nicola Lagioia, Fabio Genovesi, Tiziano Scarpa, Giordano Meacci, Antonio Manzini usano termini inglesi poco o niente. Fanno eccezione Alessandro Piperno, Walter Siti, Mauro Covacich e Sandro Veronesi, che comunque dimostrano di usare gli anglicismi in modo consapevole, e con funzioni espressive.
Ne esce, scrive la linguista Valeria Della Valle che ha indagato un’opera di ciascun autore, un quadro confortante: nella produzione letteraria siamo ben lontani dal 12-14 per cento di anglicismi che si ritrovano nel linguaggio giornalistico, con un’impennata di frequenza negli ultimi 3-4 anni.
I prestiti linguistici arricchiscono la lingua che li riceve
Giovanni Iamartino, storico della lingua, ricorda che non esistono lingue che non siano miste e che il purismo linguistico è poco praticabile: perfino il fascismo autarchico, invitando a boicottare i termini inglesi, usa un termine tratto…dall’inglese (to boycott).
Tuttavia, aggiunge Iamartino, sta a tutti i parlanti italiani avere un atteggiamento critico, non preconcetto ma attento a distinguere. “Il prestito lessicale è un dono, ma la bancarotta linguistica è un rischio da evitare”.
Anche il linguista Salvatore Claudio Sgroi sottolinea che i prestiti linguistici arricchiscono la lingua che li riceve: l’idea di usare gli anglicismi non andrebbe rifiutata in nome di un’astratta “fedeltà alla lingua”, nemmeno quando esistono termini italiani corrispondenti: l’alternativa inglese può comunque apparire più prestigiosa, elegante, affascinante.
E poi, aggiunge Sgroi, a decidere gli usi linguistici sono i “centri di potere” (e non già i singoli linguisti, pur brillanti). Il limite, se mai, consiste nel restare comprensibili. L’inglese è culturalmente rilevante e bisogna studiarlo, a scuola e all’università. Ma usare l’inglese come lingua veicolare (in altre parole: insegnare tutto direttamente in inglese) è un “suicidio culturale”.
A scuola bisognerebbe motivare i ragazzi a imparare l’inglese parlandolo, più che facendone studiare le regole sui libri
Ed eccoci alla scuola: Daniele Scarampi insegna lettere alle superiori e si occupa di didattica. Dice che la seduzione degli anglicismi, e anche di quelli inutili, resta forte. Eppure, a scuola, i ragazzi trovano ostico l’inglese, lo studiano in maniera mnemonica, faticano con la pronuncia e restano arroccati nei confini rassicuranti della propria lingua d’appartenenza (a sua volta deficitaria).
È come, racconta Scarampi, se per loro esistessero due lingue inglesi: quella imprigionata nei libri di testo, a cui i ragazzi sono indifferenti, e quella moderna e globale della musica e dello sport, che appare seduttiva ma con termini dal significato a volte intuito, raramente compreso e quasi sempre ignorato. Per cominciare a cambiare le cose, a scuola bisognerebbe motivare i ragazzi a imparare l’inglese parlandolo, più che facendone studiare le regole sui libri.
Farsi capire
Ed ecco gli elementi che mi hanno maggiormente colpita: la sostanziale impronta pragmatica, e non ideologica, di tutti gli interventi. Il fatto curioso che, se proviamo a disporli secondo la sfumatura meno o più benevola verso i forestierismi, a un estremo troviamo un ironico romeno (Butcovan) che vive in Italia, dall’altro una vibrante italiana (D’Alessandro) che vive nei Paesi Bassi.
E ancora. Molti sottolineano che il vero limite è farsi capire, specie quando a parlare sono le istituzioni (Corbolante). C’è l’affermazione (Sgroi) che a decidere gli usi linguistici sia la geografia del potere. E c’è l’appello di molti ad accettare sì contributi stranieri, ma senza esagerare.
A questo proposito, la domanda torna a essere quella posta da Treccani: stiamo esagerando, o no? I due dati numerici che escono dagli interventi sono: 12-14 per cento di anglicismi nel linguaggio giornalistico (Della Valle) e un terzo dei forestierismi della lingua italiana adottati tra il 1990 e il 2003 (Cortelazzo). Che cosa è successo dopo? Qual è la situazione oggi?
Mi capita di frequentare sia ambiti in cui i forestierismi sono oggettivamente rari, sia ambiti in cui girano messaggi che di italiano hanno ormai solo le congiunzioni (signora! Partecipi al meeting sulle best practices del digital endorsement e del celebrity marketing! Light lunch, RSVP). Per questo credo che si dovrebbe trovare il modo di monitorare il fenomeno in maniera tempestiva ed estensiva, magari quantificandolo, settore per settore, con il contributo di tutti.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it