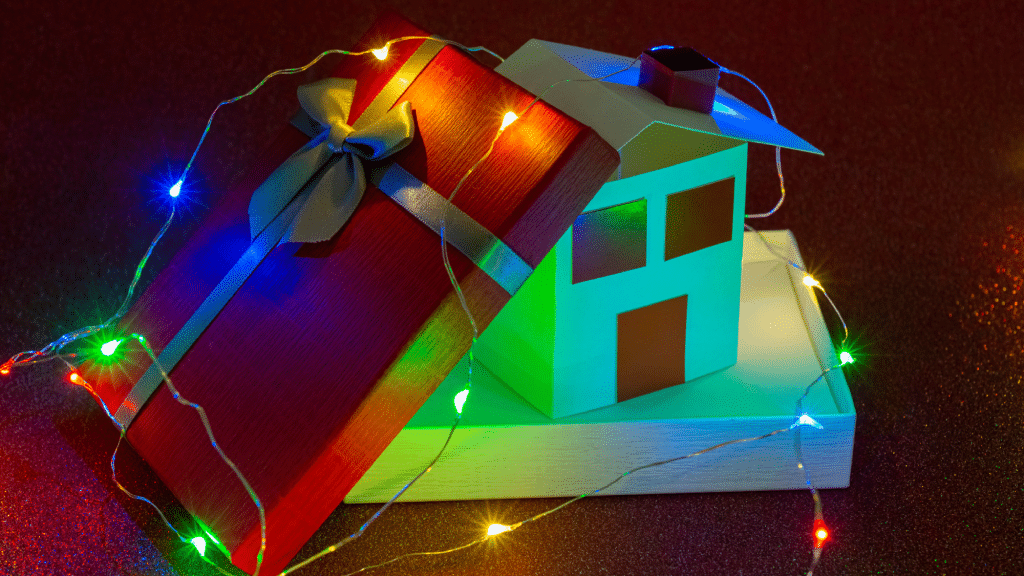Sophie è allegra durante i nostri due primi incontri. Seduta in un caffè all’aperto, parla di tutto e di niente, indecisa se prendere un tè o un succo di frutta. Sorride e parla velocemente. Però continua a stringere forte la borsa, come se fosse l’unica cosa che possiede.
È nel corso del nostro terzo incontro che racconta il suo calvario di schiava domestica in una casa di una “buona famiglia” tunisina. Quel giorno mi ha invitato da lei, un appartamento quasi vuoto dove ha trovato rifugio con altri africani.
Non osavo farle domande. Mi dicevo che mi avrebbe raccontato quello che avrebbe voluto. Storie di bonnes, o domestiche, provenienti dall’Africa subsahariana ridotte in schiavitù in Tunisia ne avevo già sentite. Alcune più drammatiche di altre. Ogni volta c’erano violenze, privazione della libertà e riduzione in schiavitù.
In Tunisia su questo argomento prevale la legge del silenzio. Le vittime della tratta esitano a testimoniare, terrorizzate da possibili rappresaglie e scioccate dopo i maltrattamenti che hanno subito per mesi. Le associazioni non vogliono parlare per non rompere il legame di fiducia costruito con le vittime. Le autorità tunisine non hanno risposto alle nostre richieste. Parlare di un argomento tabù, di persone invisibili, ma di pratiche diffuse, è una faccenda delicata.
Mi avevano promesso un buon lavoro e la possibilità di tornare nel mio paese quando volevo
Ero seduta davanti a questa ragazza e mi chiedevo da dove cominciare. È stata lei a porre fine alle mie esitazioni cominciando a raccontare, ancora una volta, la sua storia. Sophie è stata ingannata fin dalla partenza. “Mi avevano promesso un buon lavoro, ben pagato, ottime condizioni di vita e la possibilità di tornare nel mio paese quando volevo”.
La ragazza doveva venire in Tunisia per lavorare come domestica in una famiglia benestante. Un posto da bonne, la cosa più banale del mondo. Appena arrivata all’aeroporto, scesa dal volo proveniente dalla Costa d’Avorio, la persona venuta a prenderla le sequestra il passaporto. La schiavitù comincia in quel momento.
L’agenzia che non esiste
Nel suo paese il contatto avviene tramite il passaparola. “Sono entrata in contatto con un’agenzia che ha detto di potermi aiutare ad arrivare in Tunisia e avere un buon lavoro”. L’agenzia di cui parla Sophie non esiste. Nessuna struttura legale, nessuna registrazione presso le autorità. Spesso sono persone del posto in contatto con intermediari in Tunisia che sistemano le ragazze in casa dei datori di lavoro. Oppure sono persone che hanno a loro volta lavorato e hanno capito che il sistema era redditizio. E poi ci sono anche dei tunisini espatriati.
“Ho pagato 250mila franchi cfa all’agenzia, più o meno 380 euro. La metà della somma viene data in anticipo per i documenti. Il resto all’aeroporto, al momento della partenza”.
Sebbene nella maggior parte dei casi l’agenzia si occupi di preparare il passaporto del migrante, non c’è in realtà un documento da fornire. La Costa d’Avorio è infatti tra i paesi i cui cittadini non hanno bisogno di visto per andare in Tunisia e possono restare nel paese 90 giorni senza permesso di soggiorno.
Solo in rari casi ci sono dei contratti di lavoro concordati. Spesso sono falsi, e comunque non implicano delle spese per l’agenzia. All’aeroporto di Tunisi, Sophie viene prelevata e condotta in un appartamento con altre ragazze che hanno fatto il viaggio con lei.
La giovane racconta di aver viaggiato con una decina di altre ragazze e di non aver avuto problemi a superare i controlli di frontiera. Le sarebbe bastato presentare una somma di denaro sufficiente a restare per quindici giorni in Tunisia, 150 dinari (70 euro), e far finta di dover partecipare al matrimonio di un’amica.
Una volta arrivata all’appartamento, i datori di lavoro delle ragazze prendono i loro passaporti, un modo per assicurarsi che non fuggano. Poiché per alcune le condizioni di lavoro e di vita sono molto dure, la fuga è l’unica soluzione.
Arrivate a casa del datore di lavoro, la libertà è molto limitata. “Una volta in casa, non hai più il diritto di uscire. A volte stai in una stanza per giorni e sei talmente impegnata a fare le pulizie che non ti accorgi neppure di che tempo fa fuori”.
All’ambasciata del Senegal Oussmane Fall, secondo consigliere politico a Tunisi, conferma questa testimonianza: “Alcune ragazze non escono mai di casa, non sanno dove si trovano”.
Secondo le sue stime, centinaia di giovani donne senegalesi si trovano in condizioni di difficoltà di Tunisia e ogni mese qualche giovane domestica si presenta all’ambasciata. In tre anni ritiene di averne incontrate una cinquantina. “All’inizio è difficile da capire, soprattutto le prime testimonianze… poco a poco si scopre un altro universo”, racconta.
L’ambasciata della Costa d’Avorio, particolarmente toccata da questo problema, non ha risposto alla nostra richiesta di intervista.
Tuttavia le cifre fornite dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia parlano chiaro: su 45 vittime di tratta ricevute dall’ufficio dell’organizzazione dal 2012, 38 erano soggette a schiavitù domestica. E 23 erano donne provenienti dalla Costa d’Avorio.
Lavorare tre anni per recuperare il passaporto
“In Costa d’Avorio non ti avvisano che ti confischeranno il passaporto. E soprattutto ti dicono che se il lavoro non ti piace, puoi andare via. Appena arrivi, il datore di lavoro ti dice che dovrai lavorare tre anni per rimborsare le spese anticipate”, aggiunge Sophie.
Sole e senza rifugio, le giovani non sanno a chi rivolgersi per avere un consiglio. Senza contatti con il mondo esterno, si basano su quello che dicono i datori di lavoro, che non si fanno scrupoli a esercitare pressioni su di loro.
Ousmane Fall spiega che l’ambasciata del Senegal cerca di entrare in contatto con i datori di lavoro per recuperare i passaporti, ma raramente ci riesce: “Alcuni negano di conoscere la ragazza, cambiano numero di telefono, altri ci insultano”.
La testimonianza di Sophie può sembrare irreale, perché il fenomeno, invisibile, non è facile da quantificare. Ma le testimonianze delle associazioni, delle organizzazioni internazionali e di Ousmane Fall confermano il fatto che la schiavitù domestica esiste in Tunisia, per le straniere ma anche, come capita spesso, per le giovani tunisine.
“Ogni volta la stessa storia: le ragazze vengono contattate in Senegal. Spesso le persone si impegnano a comprare loro il biglietto aereo, a pagare le spese per il passaporto, poi vanno a prenderle all’aeroporto di Tunisi e le portano a casa”, racconta Fall.
“Vivi lì e ti riposi solo quando vai a dormire. Non ci sono orari di lavoro. Quando c’è bisogno di te, tu sei lì. Di mattina ti svegli prima di tutti gli altri, per preparare tutto quello che serve: la colazione, la casa in ordine…”, ricorda Sophie.
“Quando la mia padrona usciva, dovevo occuparmi di sua figlia che non lavorava ed era depressa, e passava il tempo chiusa nella sua stanza a chiedermi un caffè dopo l’altro e a fumare sigarette. Quando usciva la figlia era la madre a riposarsi, e io dovevo essere sempre disponibile se una di loro aveva bisogno di me”.
Le associazioni di difesa dei diritti umani ricevono molte testimonianze di giovani domestiche che raccontano di essere vittime di violenze verbali, fisiche e di maltrattamenti. I giorni di permesso sono rari, “la domenica, spesso per andare a messa”. Le ragazze si alzano per prime e vanno a dormire per ultime, spesso sono costrette a mangiare gli avanzi, non ricevono cure mediche se stanno male.
Se decidi di andartene, diranno che hai rubato qualcosa e chiameranno la polizia
Sophie lavorava ormai da quattro mesi quando il suo datore di lavoro si è ammalato e a casa sono venuti degli imam. “Uno degli sceicchi ha chiesto alla mia padrona se mi fosse concesso di riposare. Le ha detto che farmi lavorare sempre senza farmi uscire era haram, proibito, ed è stato così che ho ottenuto un giorno di permesso di tanto in tanto”, ricorda.
Imprigionata e tagliata fuori dal mondo, ha trascorso quattro mesi senza vedere nessuno. Le era proibito anche comunicare con amici e familiari. “Mi nascondevo per comunicare, avevo un piccolo telefono e chiamavo le ragazze con cui avevo fatto il viaggio in aereo, e la mia famiglia”.
Quando ha manifestato il desiderio di lasciare il lavoro, la situazione è peggiorata.
“Se decidi di andartene, diranno che hai rubato qualcosa e chiameranno la polizia. Non hai i documenti, non sai dove trovare aiuto, e hai molta paura”.
Una settimana dopo il suo arrivo, Sophie ha chiesto il passaporto alla sua padrona perché era delusa dalle condizioni di lavoro e voleva già andarsene. La padrona di casa le ha spiegato che secondo il “contratto”, avrebbe dovuto lavorare sei mesi per rimborsare le spese anticipate dal suo datore di lavoro, più tre anni durante i quali sarebbe stata pagata e soltanto a quel punto avrebbe recuperato il suo passaporto.
“Nel giro di sei mesi ho quindi finito di pagare i miei debiti e le ho spiegato che volevo andarmene. A quel punto mi ha detto che non avevo i soldi per pagare la penale. Io però non sapevo neppure di cosa si trattasse”.
Le giovani ragazze che arrivano dall’estero hanno di rado i requisiti legali per restare in territorio tunisino, e siccome i datori di lavoro non le dichiarano, non viene fatta alcuna richiesta di permesso di soggiorno. Trascorsi i tre mesi per i quali non è necessario un visto, le ragazze si ritrovano in condizione irregolare sul territorio tunisino, e iniziano ad accumulare le penali, che raggiungono i cento dinari al mese.
Un circolo infinito di ricatti
Sophie esprime il desiderio di andarsene, pensando che la sua padrona si sarebbe fatta carico del suo biglietto di ritorno. Capisce di dover ancora lavorare per pagare il biglietto e le penali per il soggiorno. Con il suo salario, gli ci sarebbero voluti mesi per raccogliere la somma necessaria. Nonostante sia senza soldi, però, vuole lasciare la casa, anche a costo di vagare per strada.
“Abbiamo litigato e lei mi ha chiusa in una stanza nel seminterrato”.
Due giorni dopo viene liberata e riprende a lavorare. Ma non ce la fa più, e un pomeriggio chiede di nuovo di poter lasciare la casa. La padrona si arrabbia di nuovo, comincia a picchiare la ragazza che cerca di raccogliere le sue cose e di scappare.
“Era inverno, io ero in canottiera, jeans e sandali. Sono uscita in giardino. Lei voleva che tornassi in casa. Mi sono rifiutata. Mi ha detto che se volevo andarmene, me ne sarei dovuta andare così, senza le mie cose e il mio passaporto. Me ne sono andata. Mi sono ritrovata al Belvedere a notte fonda”.
A quel punto riceve una telefonata dalla Costa d’Avorio e viene accolta da membri della comunità subsahariana di Tunisi.
Esasperata dal suo datore di lavoro, la ragazza voleva sporgere denuncia. I suoi amici però l’hanno convinta a non farlo: “Che vai a fare dalla polizia se non hai neanche i documenti?”. Si rivolge alla sua ambasciata, ma nessuno l’aiuta.
Contattata da Inkyfada, l’ambasciata della Costa d’Avorio non ha fornito alcuna risposta.
Se molte ivoriane riescono a entrare in contatto con il mondo esterno o con la loro ambasciata nel giorno di riposo o quando vanno a messa, la situazione è più difficile per le senegalesi, di religione musulmana, che non hanno alcun “pretesto” per uscire di casa.
“Alcune entrano nelle case e non escono più. Solo chiamando giù al paese o qualcuno che conoscono qui riescono a entrare in contatto con l’ambasciata”, spiega Fall.
La solidarietà si organizza a seconda delle diverse situazioni, appena le ragazze hanno lasciato il loro datore di lavoro: “L’ambasciata del Senegal non ha fondi per le attività sociali, facciamo richiesta a Dakar e contiamo sulla solidarietà delle associazioni di senegalesi in Tunisia o sulle confraternite per dare un alloggio alle ragazze”, spiega Fall. Segue, come per tutti gli stranieri che vogliono tornare nel loro paese, la lunga attesa e le peripezie per trovare i soldi necessari a saldare le penali per il soggiorno irregolare.
Una situazione grottesca che spinge i migranti ad avvicinarsi a reti criminali o a cadere nell’illegalità, dal momento che sono loro precluse tutte le situazioni regolari.
Per recuperare il suo passaporto, Sophie ha dovuto lavorare per un mese a casa della sorella della sua prima padrona senza essere pagata. In seguito si è ammalata. “Ho chiamato per avere aiuto, non avevo soldi. Lei mi ha proposto di nuovo di lavorare da lei gratis, e in cambio avrebbe pagato le mie cure”.
Quando finalmente è guarita, ha lasciato quella casa e ha trovato un lavoro ad Ariana. “C’erano due ragazzi, uno ha cercato di violentarmi. E quando ne ho parlato, la madre mi ha chiesto di lasciare la casa. Ancora una volta ho perso il mio posto di lavoro”.
Stanca di lavorare senza essere pagata, non sapendo più cosa fare per raggranellare la somma necessaria a pagare il biglietto aereo, Sophie decide di postare un annuncio su internet per prostituirsi. Troverà aiuto prima.
A proposito della tratta in Tunisia
Sophie è stata vittima di schiavitù domestica, vittima di tratta. Lorena Lando, capomissione all’Oim, spiega: “Arrivano con i loro documenti, alcune non hanno bisogno di visto per 90 giorni, altre hanno un contratto… esiste dunque una strategia, il sistema è ben congegnato, è una procedura organizzata”.
“Alcune ragazze arrivano con falsi contratti, vengono prelevate all’aeroporto, private dei documenti, della libertà, scoprono di dover rimborsare dei debiti e scoprono sul posto un’altra realtà, ecco l’intero processo della tratta: con persone maltrattate, fisicamente e psicologicamente, che lavorano troppo e che non vengono curate quando sono malate”, spiega Imen Naija, principale assistente del progetto Lotta contro la tratta di persone dell’Oim.
Nell’articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne (2000), la tratta è così definita:
L’espressione ‘tratta di persone’ indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.
La Tunisia ha ratificato il protocollo e dal 2009 lavora a un progetto di legge nazionale adottato dal consiglio interministeriale a maggio del 2015 e che adesso aspetta di essere votato dall’assemblea dei rappresentanti del popolo.
Quando nel 2011 l’Oim ha iniziato a parlare di questo fenomeno in Tunisia con uno studio sulla tratta, le autorità tunisine hanno manifestato molto stupore. Secondo Hélène Le Goff, coordinatrice dello studio pubblicato nel 2013, non si trattava di negazione, piuttosto di ignoranza del problema.
Eppure il fenomeno della tratta in Tunisia è già stato esaminato. Ogni anno l’ufficio per il controllo e la lotta contro la tratta di persone al dipartimento di stato degli Stati Uniti stila una classifica dei paesi. Dal 2009, la Tunisia è entrata in questa classifica.
Secondo lo studio, il paese è un luogo di partenza di persone vittime di tratta, ma anche un paese di transito e di destinazione per uomini, donne e bambini vittime di lavori forzati e prostituzione.
Finora in Tunisia il fenomeno delle domestiche migranti non ha ancora avuto una trattazione giuridica. Solo una ragazza ha voluto sporgere denuncia, ma il caso è stato chiuso in via definitiva. La maggior parte delle vittime preferisce tornare a casa e dimenticare, spiega Hélène Le Goff.
Sophie non ha voluto sporgere denuncia. Ha preferito tornare in Costa d’Avorio e riposarsi prima di riprendere la sua vita. Al momento di partire, aveva ancora delle difficoltà a capire cosa le era successo. Con ingenuità mi ha chiesto: “Perché le persone sono così cattive?”.
Questo reportage è stato pubblicato su Inkyfada all’interno del progetto #OpenEurope, un osservatorio sulle migrazioni a cui Internazionale aderisce insieme ad altri giornali. Gli altri partner del progetto sono Mediapart (Francia), Infolibre (Spagna), Correct!v (Germania), Le Courrier des Balkans (Balcani), Hulala (Ungheria), Efimerida ton syntakton (Grecia), VoxEurop, Inkyfada (Tunisia), CaféBabel, BabelMed, Osservatorio Balcani e Caucaso, Migreurop, Resf, Centro Primo Levi, La cimade, Medicins du monde.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it