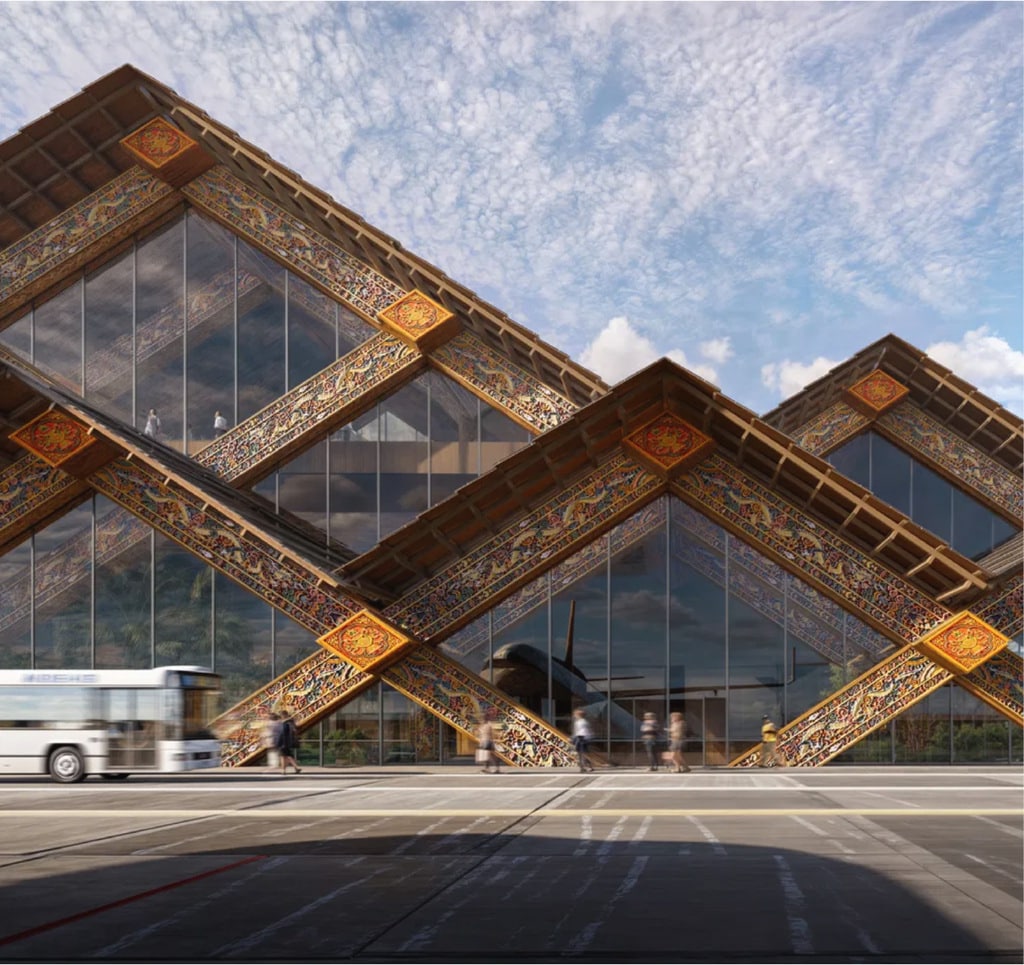Cannes la conosciamo tutti. Ci sono le palme, i divi del cinema, le spiagge, le passerelle, gli hotel di lusso. Quando penso a Cannes il pensiero mi va subito a un fascinoso e abbronzato Cary Grant sedotto con grazia dalla futura principessa di Monaco Grace Kelly. Cannes è il lusso, i paparazzi, le luci della ribalta o una paurosa Meg Ryan che in French kiss cerca di aiutare un ladro imbranato di cui si è innamorata.
Cannes però in questa coda d’estate 2016 per me e per molti è diventata un’altra cosa.
La notizia è rimbalzata in ogni computer del globo. Una donna di 34 anni, musulmana, è stata costretta a spogliarsi davanti ad alcuni agenti. Il suo “peccato” era quello di avere in testa un foulard. Gli agenti stavano di fatto applicando la cosiddetta norma antiburkini voluta dal primo ministro Manuel Valls che tanto ha fatto discutere la Francia e non solo. Quel giorno in Francia sono state multate 18 donne, tutte colpevoli di aver indossato il famigerato burkini o qualcosa di molto simile.
Ora il consiglio di stato francese ha sancito l’incostituzionalità della norma. Sospiro di sollievo? Sì, ma il disagio di aver assistito all’ennesima guerra sul corpo delle donne rimane.
La scelta cancellata
Come ha ben scritto Annie Ernaux in un suo intervento per il festival Gita al faro di Ventotene, c’è “una violenza che riduce le donne ai loro corpi, le essenzializza”. Lo abbiamo visto anche nel nostro paese con la campagna fertility day del ministero della salute italiano. Campagna che colpevolizza le donne non madri e le trascina verso un immaginario (una ragazza preoccupata con la clessidra in mano e con in testa il famigerato orologio biologico) che vede la donna non come essere pensante, ma contenitore a tempo. Quindi la scelta delle donne, in tanti ambiti non solo è silenziata, ma addirittura cancellata.
Ma torniamo un attimo a Cannes. Quando ho visto le foto dell’umiliazione della signora di 34 anni denudata di fatto davanti ai suoi figli mi sono ricordata di una frase di J.P. Sartre che nel suo libro L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica, a proposito della donna ebrea e dello sguardo che il mondo europeo ha posato su di lei, dice che la donna ebrea al livello inconscio è quasi sempre in odor di stupro. La frase si applica a numerose situazioni e non è un caso che la riprenda anche Frantz Fanon, un altro grande del pensiero contemporaneo, amico di Sartre, in L’Algeria si svela, uno dei più migliori saggi sul velo mai scritti, contenuto in Scritti politici. L’anno V della rivoluzione algerina.
Facendo sua la riflessione di Sartre sulla condizione di una donna appartenente a una minoranza e applicandola al caso dell’Algeria postcoloniale in cerca di indipendenza Fanon scrive: “Lo stupro della donna algerina, nel sogno di un europeo, è sempre preceduto dalla lacerazione del velo”. L’amministrazione coloniale “ha stabilito che la donna costituisce il perno della società algerina” per questo “si fa ogni sforzo per assicurarsene il controllo”. Fanon spiega come il francese occupante degli anni sessanta del secolo scorso è ossessionato dal velo, vuole vedere, anzi stanare e possedere quello che non riesce a percepire. Ecco perché a questa “offensiva colonialista del velo, il colonizzato oppone il culto del velo”.
Il risultato di questo non dialogo fa aumentare la diffidenza europea da un lato e le pratiche tradizionali dall’altro. Dai tempi di Fanon e di Sartre ne è passata di storia. Ma la diffidenza tra oriente e occidente non è diminuita. Anzi è aumentata. Facendo del velo ancora (e per l’ennesima volta) il pomo della discordia. Ecco perché mi ha molto colpito la foto di Cannes, poteva essere stata scattata ad Algeri negli anni sessanta invece era il 2016, nella città del red carpet e della Palma d’oro. La stessa ossessione di sempre. Lo stesso dialogo interrotto.
Come un karma che non riusciamo a superare, il punto rimane identico, ieri come oggi, ovvero l’incontro e lo scontro di questi mondi entrambi in bilico.
Per questo quasi istintivamente ho ripreso in mano e riletto un libro fondamentale della letteratura in lingua araba (e fondamentale per capire questo incontro/scontro di civiltà tra oriente e occidente) come La stagione della migrazione a nord (Mawsim al hijrah ila al shamal) di Tayeb Salih. La prima volta che mi sono avvicinata al testo avevo 22 anni e me lo sono ritrovato nella bibliografia di un esame. Non avevo la più pallida idea di chi fosse l’autore. Andai in libreria e mi comprai un’edizione dalla copertina grigio topo targata Sellerio. Oggi invece la nuova edizione, sempre della Sellerio e di un blu smagliante, è molto più bella di quella che avevo io ai tempi.
Lessi il libro in due giorni di lettura matta e disperatissima. Ricordo che ne rimasi scioccata. Non era il libro “arabo” che mi immaginavo. Non avevo letto molti testi arabi a dir la verità. Oltre Le mille e una notte e qualche romanzo di Nagib Mahfuz, devo dire che a 22 anni avevo letto davvero poca roba. D’altronde a scuola nessuno ci insegnava nulla di tutto questo. La visione della scuola che avevo frequentato io (e purtroppo non vedo tanti progressi nemmeno oggi) era assolutamente eurocentrica. Quindi letteratura italiana (quasi mai contemporanea) a tutto spiano e se eravamo fortunati poteva capitarci almeno qualche francese cosmopolita o al limite qualche resoconto inglese del gran tour. Poca roba. Di arabo, di africano o di latinoamericano nemmeno l’ombra.
Una rivelazione
Per arrivare a conoscere Fatema Mernissi, Mahmoud Darwish, Nizar Qabbani, Sonallah Ibrahim, Ghassan Kanafani, Leila Aboulela, Elias Khoury, Emil Habibi – per citare i classici – ho dovuto davvero aspettare l’università e gli amici. Ma in quella mia parentesi giovanile fu Tayeb Salih a prendermi il cuore. Un romanzo così definitivo, violento, commovente e dolce non lo avevo mai letto. La stagione della migrazione a nord fu di fatto una rivelazione.
Oggi, in questo caotico 2016 fatto di un vicino oriente spezzato, di città scomparse, di terroristi alla ribalta, il romanzo di Tayeb Salih è ancora più attuale. Il libro compie 50 anni, perché di fatto uscì verso la fine del 1966 sulla rivista libanese Hiwar per poi uscire in volume l’anno successivo. L’autore, Tayeb Salih, era nato a Karmakol nel nord del Sudan. Il suo paese (ancora non era diviso come oggi) è sempre stato di fatto una cerniera. Il più grande paese di lingua araba, ma anche uno dei più grandi in estensione del continente africano. Era islam e cristianesimo insieme, tradizione e modernità. La sua era una famiglia modesta, di agricoltori. Però lui ebbe la possibilità di farsi una formazione. Prima in una scuola coranica, poi al Gordon college di Khartoum. Dopo fu un gioco da ragazzi fare il salto in occidente.
Attraverso le donne, Mustafa cerca di conquistare la cultura di questa Europa che da una parte lo concupisce e dall’altra lo allontana
Si stabilì a Londra nel 1952 e da allora si può dire che visse la maggior parte della sua esistenza tra il Regno Unito e la Francia (dove lavorò all’Unesco). Le sue sortite nel mondo arabo continuarono, ma ormai era uno sradicato un po’ per scelta e un po’ per caso. Tayeb Salih, morto nel febbraio del 2009 all’età di 80 anni, non fu mai molto prolifico, ma l’importanza della sua La stagione della migrazione a nord è evidente ancora oggi. Edward Said, il famoso e sempre compianto nume del postcolonialismo globale, definì il romanzo uno dei sei migliori in lingua araba. Una sorta di alter ego del Cuore di tenebra di Conrad, anche se l’autore un po’ ridendo sosteneva che lui in fondo voleva solo scrivere una storia di suspence, un giallo, con un omicidio efferato dentro.
Non fu solo Said a elogiarlo: l’attualità del testo e le traduzioni in quasi tutte le lingue (la versione italiana è tradotta magistralmente da Francesco Leggio) dimostrano quanto meriti ancora la considerazione che accompagnò l’uscita del romanzo. Il Norwegian book club lo considera uno dei cento libri migliori di tutti i tempi e l’accademia letteraria araba lo ha consacrato nel 2001 come il più importante romanzo in lingua araba del ventesimo secolo. Fu anche proibito in alcuni paesi e ogni tanto ancora oggi, soprattutto tra i giovani tradizionalisti, il romanzo è censurato o direttamente proibito. Il linguaggio esplicito, a tratti crudo, le scene di sesso, evocate e dettagliate, portarono qualcuno a dire addirittura che il libro era pornografico. Ma furono più quelli che lo amarono (e lo amano ancora) rispetto ai detrattori.
Lo stereotipo sovvertito
Alla base dell’intuizione di Salih c’era la voglia di sovvertire le narrazioni codificate, univoche, eurocentriche. Infatti il viaggio al centro della narrazione non è più dell’europeo alla scoperta dell’africano, ma l’esatto contrario: è il nero-arabo che parte alla scoperta, e direi anche alla conquista, dell’Europa. Il primo personaggio che vediamo non ha nome. È un narratore, ma anche il ricettacolo della storia. Il secondo invece è Mustafa Said, un uomo misterioso che dice di essere un commerciante, ma che in realtà nasconde molto di sé al villaggio. Poi in una notte racconta al narratore senza nome come ha conquistato l’Europa con il “cazzo”. Racconta come in occidente invece di lottare contro lo stereotipo lo incarna letteralmente e conquista le sue donne. Sono tre le donne che lo amano e si suicidano per lui. Di una di esse, Ann Hammond, Mustafa dice: “Era il mio contrario: anelava a climi equatoriali, soli abbacinanti e orizzonti purpurei. Ai suoi occhi ero il simbolo di tutto questo anelito”.
La sua filosofia era spicciola e chiara: “Per ogni situazione vestivo i panni adatti”. Ed ecco che soggiogava la sua conquista con l’odore del sandalo bruciato e dell’incenso. In un’orgia continua e ininterrotta “mi portai a letto donne prese fra le ragazze dell’Esercito della salvezza, delle associazioni dei quaccheri, delle società dei fabiani. Allorché c’era una riunione del partito liberale, o dei laburisti, o dei conservatori o dei comunisti, io sellavo il mio cammello e partivo”. Di tanto in tanto gli veniva ricordato il vecchio ruolo di “cannibale” e alla domanda “di che razza sei?” Mustafa sorridendo rispondeva “Sono come Otello… arabo e africano”. Ma le donne conquistate (e poi suicide) sono solo un diversivo. Attraverso di loro Mustafa cerca disperatamente di conquistare la cultura di questa Europa che da una parte lo concupisce e dall’altra lo allontana.
Sono due le donne che desidera più di sé stesso. Una è la signora Robinson che già nel nome rimanda al Robinson Crusoe di Defoe, alla cultura del paese colonizzatore, dove lui è un Venerdì spaesato che sa solo assorbire l’odore di quel petto ampio e profumato. L’altra è la moglie Jane Morris che lo rifiuta sessualmente notte dopo notte, lo umilia, lo porta sull’orlo della pazzia e si concede a lui solo per essere consapevolmente uccisa da un Mustafa ormai perso nei meandri di questo “nord” che non ha capito. Ed è qui il genio di Tayeb Salih. Non chiama più oriente il suo mondo. Il rapporto è nord-sud, un rapporto oggi scontato, ma che 50 anni fa nessuno nominava. Si diceva occidente, mai nord. Ed ecco che lo scrittore mette in scena un rapporto violento, incomprensibile, forgiato da un atto volontario di violenza che Mustafa denuncia durante il processo per l’omicidio della moglie:
Le navi hanno solcato le acque del Nilo per la prima volta portando i cannoni, non il pane, e le ferrovie sono state costruite in primo luogo per trasportare le truppe. Hanno fondato le scuole per insegnarci a dire ‘sì’ nella loro lingua. Ci hanno portato il germe della più grande violenza europea di cui il mondo non aveva mai visto l’eguale, quella della Somma e di Verdun, il germe di un male assassino che li ha colpiti più di mille anni fa. Sì, signori, sono venuto da conquistatore fin dentro casa vostra. Una goccia del veleno che avete iniettato nelle vene della Storia. Io non sono Otello. Otello era una menzogna.
Ma se il rapporto con il nord non è pacificato, anzi, quello con il suo sud non è idilliaco. Il Sudan è percorso da un’onda di modernità e anche qui i rapporti per un islam in bilico tra animismo e ortodossia non sono semplici. Ed ecco che in un miscuglio di sud fatto di vecchi saggi, libertini fuori tempo, anziane con la sigaretta e sboccate come un marinaio, tutto sembra fuori controllo. Ma in questo sud a colpire è proprio l’indipendenza delle donne. “Non mi sono inventato niente”, dirà Tayeb Salih in una delle sue rare interviste. “Per fortuna, le donne nel mio paese non erano sottomesse”. E infatti nel romanzo sono soprattutto gli uomini soccombere all’ansia di controllo
Oggi spesso si descrive il mondo islamico (arabo, africano, asiatico) come se fosse monolitico. Ma la realtà è plurale
Per questo l’autore decide di non far scegliere i personaggi. Non c’è scelta tra nord e sud, mondi perduti che si guardano attraverso una reciproca cortina di stereotipi. E non è un caso che il suo narratore senza nome e il suo Mustafa (come Marlow e Kurtz in Cuore di tenebra) si collochino in mezzo ai mondi narrati. Sono personaggi in between. Tutto è altrove. Questo farà dire al traduttore/curatore dell’edizione italiana Francesco Leggio, che nonostante gli sforzi del personaggio Mustafa, in entrambi i mondi rimane in piedi “lo stigma della negritudine” che “gli garantisce l’esclusione dal consorzio civile sia a nord, dove è un essere culturalmente e umanamente inferiore, sia nel profondo sud di un villaggio che si regge sulla solidarietà tribale”.
In questo La stagione della migrazione a nord è un romanzo dell’esclusione, ma è anche un romanzo della complessità. Oggi spesso si descrive il mondo islamico (arabo, africano, asiatico) come se fosse un modello monolitico. Si negano le sfaccettature. Ma la realtà è plurale, fatta di osservanti, laici, agnostici, perfino atei. Fatto di donne con il velo e di donne senza velo. Di cantanti, di artisti, falegnami, operai, insegnanti, dentisti. Un mondo di paesi e ritualità diverse, di cibi diversi. Un mondo di neri e di bianchi. Un mondo ampio. Negato però nella narrazione generalista sia in occidente sia in oriente. Tutto è ridotto a una mera polemica elettorale che crea fratture. E Tayeb Salih, già 50 anni fa, mettendo in piazza questo scontro di civiltà, ha però anche visto che la possibilità di uscirne è proprio nella lotta agli stereotipi, nell’arginare le letture distorte del passato e dell’altrove.
Il luogo di origine, la tradizione, l’appartenenza e l’occidente sono solo sfaccettature di identità, non devono diventare ossessioni. Non servono muri, servono ponti, sembra quasi sussurrarci l’autore. Una nuova relazione tra nord e sud per non soccombere, per non distruggerci a vicenda. Cinquant’anni fa Tayeb Salih ci aveva avvertito. Forse è ora di ascoltarlo.
Igiaba Scego sarà al festival di Internazionale a Ferrara dal 30 settembre al 2 ottobre 2016.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it