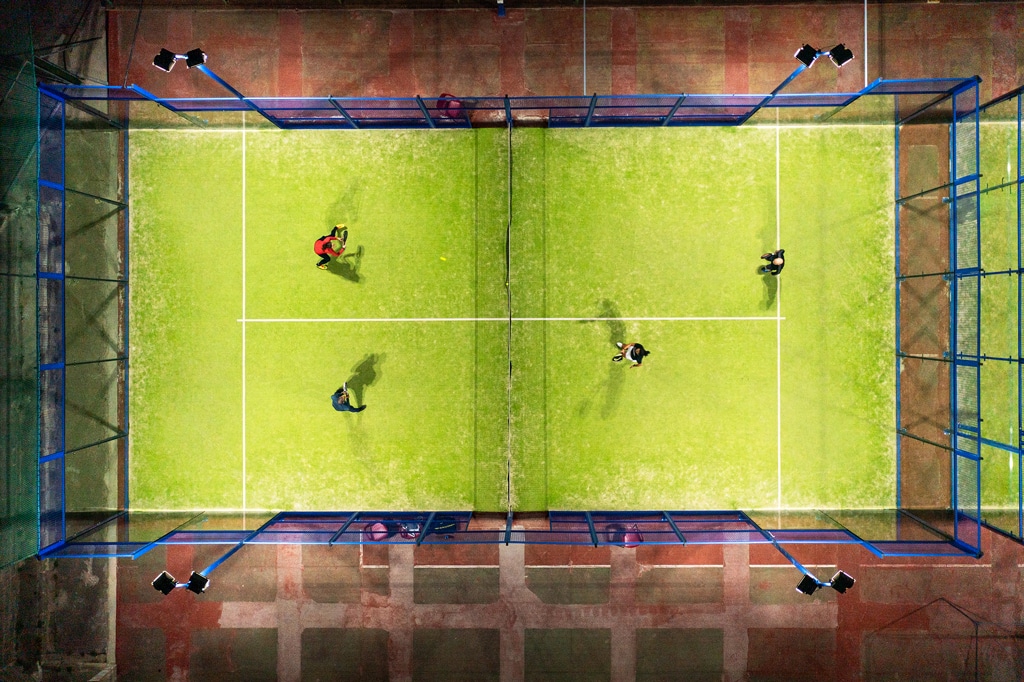Al prossimo festival di Sanremo le sorelle Paola e Chiara Iezzi torneranno, dopo dieci anni, a cantare insieme. Non è la loro prima volta (dopo aver vinto Sanremo giovani nel 1997 hanno partecipato nella categoria big nel 1998 e nel 2005), ma forse sarà la loro partecipazione più importante. Perché per tutta la loro carriera, cominciata a metà anni novanta come coriste degli 883, pur avendo avuto un successo più che discreto hanno sempre dovuto in qualche modo giustificare la loro esistenza nella storia della musica pop italiana.
Il loro peccato originale sembra essere stata la natura smaccatamente pop dance del loro lavoro. La differenza rispetto agli altri anni è che il festival è cambiato e che la scena musicale italiana ha forse meno pregiudizi riguardo ad artisti che si presentano come puramente pop dance, senza altre connotazioni accessorie. Per capirci: una Kylie Minogue, artista capace di passare dalla dance più leggera ai duetti con Nick Cave, in Italia non sarebbe mai stata pensabile, non avrebbe mai potuto aspirare a quel tipo di credibilità.
L’Italia ha dunque un problema con la musica pop dance? Pur avendone prodotta di memorabile negli ultimi quarant’anni, il nostro paese fa ancora fatica ad ammetterla criticamente nel canone della musica nazionale. La lunga stagione della italo disco e poi quella della dance anni novanta sembra interessare più ai critici musicali statunitensi, tedeschi o francesi. Eppure in diversi paesi del mondo, la nostra artista pop più famosa è una vedette della più tarda ondata della italo disco: Sabrina Salerno. La carriera discografica di un mostro sacro del soul come Luther Vandross è cominciata a Bologna, grazie a un produttore dance italiano, Mauro Malavasi, che ha confezionato per lui un pezzo disco memorabile come The glow of love. Al Festival di Sanremo del 2000 gli Oasis, superospiti internazionali, hanno chiesto alla loro etichetta di conoscere anzitutto Ivana Spagna (numero due nelle classifiche britanniche con Call me nel 1987). Quando ai Pet Shop Boys fu chiesto di mettere insieme una compilation dei brani che più li avevano influenzati ben due sono le produzioni italo dance in scaletta: Don’t cry tonight di Savage e Ti sento dei Matia Bazar.
Fino a buona parte degli anni ottanta la maggior parte della musica pop prodotta da afroamericani veniva spesso liquidata in Italia come “disco”
Sono solo alcuni esempi sparsi che indicano quanto la dance italiana, soprattutto quella con ambizioni pop, sia più apprezzata e capita all’estero che da noi. Solo in Italia esiste l’odiosa etichetta di “commerciale” per indicare un ampio ventaglio di musica pop dance che va da Raffaella Carrà agli Eiffel 65, da Alexia a Robert Miles, buttando nel mucchio anche veterane e innovatrici internazionali come Gloria Gaynor e Donna Summer.
Le ragioni della ghettizzazione e della rimozione di un intero genere sono varie: il giornalismo musicale italiano è storicamente legato al rock da una parte e al cantautorato dall’altra. Fino a buona parte degli anni ottanta la maggior parte della musica pop prodotta da afroamericani veniva spesso liquidata in Italia come “disco”, un termine che veniva usato con una certa dose di disprezzo e forse con una punta di razzismo e omofobia. Soul e rhythm ’n’ blues venivano apprezzati solo in quanto parte di una genealogia molto bianca e maschile del “grande rock” e la disco music in tutte le sue infinite varianti e sottogeneri veniva liquidata come moda passeggera o roba da ragazzine o da discoteche gay.
La critica rock militante di casa nostra non ha mai perdonato alla musica pop dance la sua apparente vacuità e la sua capacità di coinvolgere un pubblico, molto variegato ed eterogeneo, spesso lgbt+ ma non solo, che non si sentiva rappresentato dalle classifiche o dal “grande rock”. Quando uso le parole vacuità e superficialità come caratteristiche di una canzone pop dance le uso in senso warholiano: l’inventore della pop art teorizzava il fatto che più le sue opere erano semplici, bidimensionali, poco originali e facilmente riproducibili e più grande era il pubblico a riversarci dentro un senso e, cosa più importante per Warhol, un valore economico. Perché il senso a canzoni superficiali come il Tuca tuca, Rumore o A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà lo danno le persone che le ballano da cinquant’anni in momenti di gioia e di liberazione.
Vamos a bailar (esta vida nueva), video diretto da Luca Guadagnino
Quando Paola e Chiara, nel 2000, uscirono con Vamos a bailar (Esta vida nueva), una trappola pop dance ancora oggi irresistibile, furono subito abbracciate dalla comunità lgbt+: la canzone diventò anche uno dei tormentoni del World Pride del 2000 che si tenne a Roma. Il pezzo aveva elementi di pop, di dance balearica, una chitarra acustica vagamente flamenca e un testo che, nella sua semplicità, era pronto a essere intercettato da chi, in quel momento, sognava davvero “una vida nueva”: primi tra tutti i giovani gay, le lesbiche e le persone transgender del World Pride.
Vamos a bailar, come molti classici della disco, è una revenge song, una canzone di rivalsa. In I will survive Gloria Gaynor cantava al suo amante che l’aveva mollata: “Pensavi che sarei crollata, che mi sarei sdraiata lì a morire?”. Paola e Chiara dicono “Ora mi sento rinascere senza te”. Al di là degli amori passati e delle vendette, quello che rendono I will survive e Vamos a bailar degli inni gay, con le loro abissali differenze, è la promessa di una vita diversa, di un altrove in cui essere persone nuove o “nuova immagine”, come dicono un po’ ambiguamente Paola e Chiara.
Television era un’operazione di alto artigianato pop dance che, oggi più che mai, colpisce per ambizione, solidità produttiva e coerenza
Il primo video del pezzo fu girato dal regista Luca Guadagnino. Nonostante i pochi mezzi e l’idea esile (Paola e Chiara molto carine che ballano avvolte da una ragnatela che sembra intrappolarle e i cui fili diventano le corde di una chitarra spagnola) Guadagnino coglie in pieno il messaggio della canzone: le due ex ragazzine che facevano l’inter-rail in Irlanda sono ora giovani donne libere e sexy e non hanno niente da perdere. E l’aspetto vagamente da spot di Miss Sixty di alcune inquadrature non fa che rendere Paola e Chiara più autentiche nel contesto più artificiale che ci sia: quello di un video dance pop. Vedendole volteggiare sullo schermo il profumo Bon Bon di Malizia ci avvolge ancora oggi come una madeleine proustiana inzuppata nel tè.
L’album di cui Vamos a bailar era il singolo di lancio, Television, era un’operazione di alto artigianato pop dance che, oggi più che mai, colpisce per ambizione, solidità produttiva e coerenza. La pietra angolare dell’album sono tre impeccabili singoli eurodance (Vamos a bailar, Viva el amor! e Fino alla fine), tutti corredati dal video (più o meno) giusto e da remix (quelli tutti giustissimi) pensati per le discoteche europee.
A remixare Paola e Chiara in quel periodo c’erano il duo house spagnolo Pumpin’ Dolls (già noto per il lavoro su Strong enough di Cher) e soprattutto gli italiani Rapino Brothers (già collaboratori della gente più varia: Take That, Corona, Sparks e Heaven 17). Il remix dei Rapino Brothers di Fino alla fine è la cosa che si avvicina di più all’ideale platonico di eurodance o handbag house, ovvero quel tipo di house music che, tra i tardi anni novanta e i primi duemila, le ragazze, soprattutto quelle britanniche, ballavano girando attorno alle loro borsette ammucchiate sulla pista. Altra prepotente sensazione olfattiva al solo ricordo: Bacardi Breezer all’anguria.
Television non era però solo una raccolta di singoloni “diva house”, nascosti tra le pieghe del disco c’erano anche pezzi pop più sofisticati e ambiziosi come Amoremidai, che riusciva a suggerire atmosfere tra il romantico e il malinconico a metà strada tra gli Everything but the Girl di Walking wounded e gli italiani Delta V. Una versione acustica del pezzo, uscita in una riedizione dell’album del 2001, ne svela la delicata natura di bossa nova. Se tutto vi suona un po’ troppo Café del mar è perché quella era esattamente l’intenzione. Pur contenendo pezzi di natura diversa (c’è anche uno strumentale un po’ space-disco intitolato appunto Television), l’album ha una produzione solida e coesa che mescola elettronica e archi disco (archi veri e non campionati o sintetizzati) e vede al lavoro turnisti molto rispettati come Phil Palmer alla chitarra, Lele Melotti alla batteria e Paolo Costa al basso. E sempre al basso comprare anche Morgan.
A ventidue anni di distanza colpisce che un album ben congegnato come Television non sia stato il trampolino per una lunga e soddisfacente carriera per Paola e Chiara. È come se in Italia imboccare con decisione, consapevolezza e competenza la strada di una pop dance dal suono europeo non pagasse. Nello stesso anno la già citata Kylie Minogue usciva con Light years, un album che conteneva più o meno gli stessi ingredienti di Television. Ascoltate la latineggiante Please stay (anche quella remixata dai Rapino Brothers) e dite se non ci sentite quell’aria da house balearica di Vamos a bailar. I suoi singoli di quel periodo (Spinning around, On a night like this e Please Stay) furono uno spettacolare reboot per la carriera internazionale di Kylie Minogue.
È come se Paola e Chiara, nel 2000, stessero facendo la musica giusta nel paese sbagliato. In un paese che, quando si trattava di parlare del loro lavoro, raramente entrava nel merito della loro visione del pop, mettendola nel giusto contesto, ma che si limitava a parlare solo di “svolta sexy” o di “tormentone da spiaggia”. La sensazione, a qualche mese da Sanremo, è che Paola e Chiara, esibendosi in un festival che oggi è meno imbolsito e prevenuto, potranno prendersi qualche rivincita e puntare a quello che sarebbe il loro habitat naturale: l’Eurovision.
Paola e Chiara
Television,
Columbia, 2000
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it