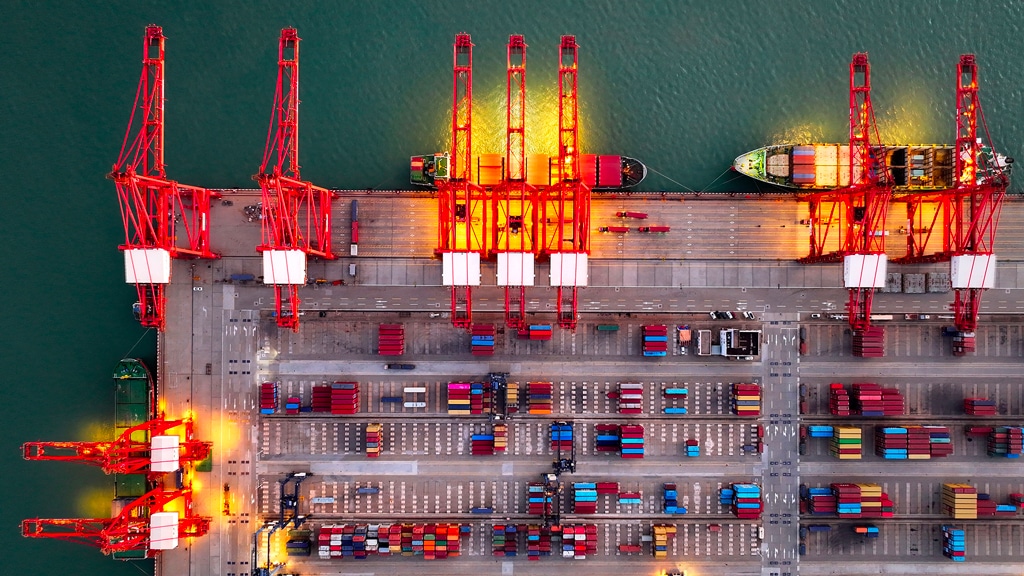La cantautrice irlandese Sinéad O’Connor (Shuhada’ Sadaqat dopo la sua conversione all’Islam del 2018) è morta il 26 luglio. Aveva 56 anni.
Sappiamo tutto dell’infelicità, della solitudine e del disagio mentale di Sinéad O’Connor. Conosciamo ogni dettaglio, anche perché è stata lei stessa a svelarlo: negli ultimi anni capitava che chiedesse aiuto ai fan tramite i social network, twittava minacce di suicidio e poi scompariva per mesi. Negli ultimi dieci anni si è sicuramente parlato più del suo malessere che della sua musica. Eppure Sinéad O’Connor era nata per scrivere canzoni e cantarle.
Lei stessa non esitava a definirsi pazza (“nuts”). Quella pazzia era dentro di lei da quando era bambina: era quella che le faceva sentire i fantasmi dentro al vecchio pianoforte della nonna. “Le canzoni sono fantasmi”, scriveva nel suo memoir Rememberings uscito nel 2021: “E da quando è uscito il mio primo album e io ho cominciato a fare tour sono diventata una specie di venditrice ambulante di fantasmi”. Una ghostbuster al contrario: anziché catturare gli spiriti inquieti lei li liberava tra il pubblico.
La sua pazzia è quella che le ha permesso di andare avanti nonostante un successo che non aveva mai davvero voluto perché in testa aveva tanto altro. Aveva firmato il primo contratto discografico a 17 anni, quasi senza accorgersene, e il suo primo album, The Lion and the cobra, è uscito poche settimane dopo la nascita del primo figlio. È stata la sua pazzia a non farla morire di overdose a 26 anni su un divano sgangherato del Chelsea hotel come una rockstar qualsiasi. La sua pazzia era una valvola di sfogo, un’uscita di sicurezza per la bambina terrorizzata che è sempre stata rinchiusa dentro di lei, un trucco per sopravvivere giorno per giorno. Se non fosse stata “nuts” forse l’avremmo persa molto prima, se non fosse stata pazza avrebbe obbedito alla sua casa discografica e avrebbe rifatto all’infinito il suo secondo album, quello di maggior successo, quello con dentro Nothing compares 2 U, il suo pezzo più famoso, scritto da un uomo (Prince) con cui lei avrebbe avuto pochi, e poco gradevoli, contatti diretti.
Se non fosse stata pazza non avrebbe strappato la foto di Giovanni Paolo II durante una diretta televisiva di Saturday night live nel 1992. Eppure quel gesto, che in pochi secondi le ha disintegrato la carriera, aveva un senso profondo per lei. E ce l’ha ancora oggi per noi. Nel 1992 non si parlava ancora pubblicamente di come la chiesa cattolica insabbiasse i reati di pedofilia commessi dal clero. Solo nel 2002, dieci anni dopo, il gruppo di giornalisti investigativi Spotlight del Boston Globe avrebbe svelato uno scandalo che coinvolgeva 90 sacerdoti statunitensi e che con il tempo avrebbe travolto come una valanga sempre più esponenti del clero, anche al livello internazionale. Per Sinéad O’Connor, nata cattolica irlandese e profondamente, inquietamente religiosa per tutta la vita, era una questione di verità. Voleva usare la sua fama, una fama di cui non le importava nulla, per dire una verità. È stata pazza? Sì è stata pazza. Eppure gli abusi del clero esistevano in tutto il mondo ed erano sistematicamente nascosti dalle gerarchie più alte della Chiesa che proteggevano i sacerdoti pedofili.
La popstar riluttante
“Non sono una popstar”. Scrive Sinéad O’Connor in Rememberings: “Sono un’anima inquieta che ogni tanto ha bisogno di urlare in un microfono. Non ho bisogno di essere al primo posto in classifica. Non ho bisogno di piacere alla gente”. Proprio per questo era cosciente di compromettere per sempre la sua carriera strappando quella foto in tv. Eppure lei scrive che quel gesto le ha in qualche modo salvato la vita come artista: “Avere un album al numero uno in classifica ha fatto deragliare la mia carriera. Strappare quella foto mi ha rimessa nei binari”. Sinéad dice di non essere nata per fare la star ma per cantare: “Dopo quella puntata di Saturday night live potevo finalmente tornare a essere me stessa. Tornare a fare ciò che amavo. Tornare a essere imperfetta. A essere matta perfino (…) alla fine ho mantenuto quattro figli cantando dal vivo e sono diventata, se posso dirmelo da sola, una performer decisamente brava”.
Il punk è stato fondamentale nella sua formazione perché le ha fatto capire che la rabbia e il disagio potevano avere piena cittadinanza nella musica
Il filo da seguire per capire la musica di Sinéad O’Connor non è però quello dell’infelicità e neanche quello della pazzia: è quello della rabbia. Sinéad è nata come artista quando ha scoperto come incanalare una rabbia antica e sempre rimossa. Gli abusi subiti per anni dalla madre, l’internamento da ragazzina in un convento di suore irlandesi che lei chiamava “nuthouse” (manicomio), i rapporti complicati con gli uomini della sua vita e con la religione, tutto chiedeva una via d’uscita e quella via d’uscita erano le canzoni. O’Connor era stata educata a nascondere la sua in felicità e il suo disagio: cantando invece aveva capito che poteva uscire da sé per esprimerle. Cantare era per lei una forma di sdoppiamento: poteva finalmente vedere se stessa da fuori e urlare a pieni polmoni tutta la sua rabbia repressa.
Sinéad O’Connor, Troy (1987), regia di John Maybury
Le più belle canzoni di Sinéad O’Connor hanno sempre a che fare con la rabbia: Troy, una canzone del suo primo album, quindi scritta quando aveva ancora 18 anni, parlava, attraverso una serie di metafore, del rapporto con sua madre, morta nel frattempo in un incidente d’auto. Parlava di amore e di dolore, di morte e di resurrezione. Spesso si è scritto che Sinéad O’Connor cantava come un angelo e in effetti è vero. Ma non come un angelo musicante di Raffaello o di Melozzo da Forlì bensì come uno di quegli angeli terribili di William Blake o di John Milton che con la loro voce enorme facevano tremare le fondamenta del mondo.
O’Connor era ossessionata dalle voci: da piccola aveva amato David Bowie perché aveva una voce sua (“A differenza di Marc Bolan”, scrive, “che sembrava avere la voce di qualcun altro”) e poi Barbra Streisand che aveva una voce meravigliosa e libera. Nella sua fantasia David Bowie e Barbra Streisand erano due uccelli selvaggi che volavano liberi nel cielo. In effetti Sinéad O’Connor come cantante può essere una sorta di ibrido tra Bowie e Streisand: sa tenere una melodia in modo impeccabile e quasi sussurrato, può farla librare in aria con note alte e cristalline ma nel giro di un attimo può farla deragliare in un parlato, in un grido o in una sfuriata punk rock. Il punk è stato fondamentale nella sua formazione perché le ha fatto capire che la rabbia e il disagio potevano avere piena cittadinanza nella musica, non erano la spinta per una rivalsa sociale o economica, erano però un carburante per correre e per bruciare più in fretta. La sua musica è stata anche influenzata dalla canzone di protesta, dall’hip hop e dalla religiosità del reaggae e della cultura rastafariana che aveva scoperto trasferendosi a Londra dall’Irlanda già a 18 anni.
Anche quando canta degli standard (lo ha fatto magistralmente in un album del 1992 intitolato Am I not your girl?), riesce a essere Barbra Streisand e Bowie, Peggy Lee e Johnny Rotten. Success has made a failure of our home (Il successo ha mandato in rovina la nostra casa), cantata originariamente nel 1962 da Loretta Lynn, sembra scritta per lei… nel finale, quando ripete ossessivamente “Sono o non sono la tua ragazza?”, quella che poteva essere una canzone country un po’ sdolcinata, accompagnata da un video troppo enfatico, diventa, grazie anche alla produzione di Phil Ramone, una confessione autentica e straziante. Il successo le aveva davvero rovinato la vita.
Parlando solo della sua infelicità, del suo dolore e del suo disagio rischiamo di perdere di vista la sua intelligenza, la sua ironia amara e crepuscolare, così tipicamente irlandese, la sua bravura con le parole e la sua meravigliosa disinvoltura con le parolacce. È stata tante cose Sinéad O’Connor, secondo alcuni anche troppe, ma sono tutte lì nei dieci album che ci ha lasciato.
Nell’introduzione del suo memoir Sinéad scriveva: “Sul palco riesco sempre a essere ciò che sono veramente. Fuori dal palco non mi riesce molto bene. Non venivo capita da nessuno, neanche da me stessa, a meno che non cantassi. Ma spero che questo libro alla fine abbia un po’ di senso. Se non ce l’ha provate a cantarlo, forse così funziona”.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it