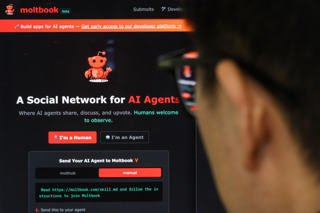Nicola Lagioia leggerà questo testo inedito a Letterature, festival internazionale di Roma, il 16 giugno 2015 alle 21 in piazza del Campidoglio.
Che cosa resta da fare alla letteratura? È questa una domanda che sarebbe suonata forse meno urgente fino a venticinque anni fa, e che oggi accompagna i giorni di una nuova età dell’ansia. Il tempo in cui viviamo ci spiazza di continuo. Qualcuno si era illuso che il ventunesimo secolo sarebbe stato una crociera senza iceberg. Ci siamo fatti cogliere di sorpresa un’altra volta, distratti dall’orchestrina che suonava.
Il novecento aveva offerto delle lezioni anche terribili da cui credevamo di avere imparato molto, e si era chiuso lasciandoci in eredità delle promesse che alla prova dei fatti non hanno retto, e in certi casi si sono addirittura rivelate un rettilario per le solite uova fatali.
Dopo il 1989 si disse gonfi d’ottimismo che la Storia era finita. Che tutte le storie erano state raccontate, ma che questo non era poi così importante dal momento che l’umanità aveva risolto quasi tutti i suoi problemi e noi avevamo appena varcato i cancelli oltre i quali cominciava il Regno millenario della pace universale.
Ora, io, ogni volta che sento parlare di Regno millenario, metto mano a Robert Musil e Charlie Chaplin. Ma all’epoca ci si riempì la bocca di strane cronologie astrologiche. Ci dissero che stavamo per entrare nell’età dell’Acquario. Non so se ricordate. La memoria selettiva dovrebbe averci fatto dimenticare certe cose, eppure il ricordo degli abbagli rimane. Temevamo le pazzie del dottor Stranamore, ma la fine della guerra fredda (dissero) ci aveva catapultato in un futuro fatto di pace, prosperità, opulenza, fratellanza e altri sogni perfettamente climatizzati, e noi che cosa potevamo fare se non rileggere William Shakespeare o Jane Austen in chiave pop e aspettare che i nostri titoli di studio fruttassero come le monetine sotterrate da Pinocchio nel Campo dei Miracoli?
Il Regno millenario della pace universale
E infatti, neanche tre anni dopo scoppiò la guerra in Jugoslavia, e in Europa ricomparvero i campi di concentramento. Dunque (per dirla con lo Stephen Dedalus di Joyce) la Storia non era l’incubo dal quale ci eravamo definitivamente risvegliati.
Piuttosto, ci eravamo assopiti guardando su Mtv i video di Eminem, e ci siamo ritrovati qualche anno dopo su YouTube a osservare ancora mezzo addormentati le decapitazioni di esseri umani che sembravano girate dallo stesso regista.
Ma gli imprevisti ci riguardano anche al di qua del video. Saremmo dovuti essere la nuova classe dirigente, ci siamo ritrovati senza lavoro. La forbice tra ricchi e poveri si è allargata in modo spaventoso. Tanto che oggi le 90 persone più abbienti del pianeta detengono una ricchezza pari a quella posseduta complessivamente dai 3,5 miliardi di più poveri. L’economia ultimamente non ci è amica. O forse ci è amica ma non ce ne accorgiamo? Secondo alcuni sarebbe assimilabile a quella forza che vuole tenacemente il male ma opera costantemente per il bene. Qualcun altro ritiene, al contrario, di poter rispolverare Bertold Brecht quando diceva che rapinare una banca è un crimine meno grave che averla fondata. Dov’è la verità? Forse tra l’altro non stiamo solo ballando sull’orlo di una polveriera, ma di un disastro ecologico imminente.
Se il mondo in cui ci siamo ritrovati è questo, che cosa resta da fare alla letteratura per continuare ad avere, se non un ruolo, un senso?
Forte è la tentazione di armare i nostri libri per scagliarli lancia in resta contro la corruzione, contro le oligarchie, contro le mafie, contro il razzismo, contro le ingiustizie, contro la fame nel mondo e contro i fondamentalismi, contro il disastro climatico, contro la violenza domestica, tutto secondo la logica del muro contro muro.
La letteratura racconta dunque i legni storti, non ha la pretesa di raddrizzarli. Solo così aggiungiamo speranza alla speranza di mantenerci umani.
Ma ha senso combattere un male senza sfumature attraverso un bene che pretende di avere un segno perfettamente opposto? E può, qualcosa che si presenta come “buona”, essere priva di sfumature, ambiguità, contraddizioni?
Fate indossare alla letteratura un’armatura, mettetele in mano una spada, datele il compito di combattere i mali del mondo e la vedrete affondare appesantita dalle buone intenzioni con cui l’avete ingenuamente bardata.
“È ridicolo come ti sei bardato per questo mondo”, scrive Franz Kafka a un certo punto.
I passi lunghi e corti della letteratura
La letteratura non è la prosecuzione di un editoriale brillante sulla prima pagina di un quotidiano, non è un atto giudiziario in forma narrativa, non è uno slogan diviso in capitoli, non è una direttiva di chiesa o di partito, non è una chiamata alle armi, né all’indignazione, non è il megafono di una ong, non parla a tante orecchie contemporaneamente ma a due per volta, non ha la pretesa di mobilitare le masse, non vuole rovesciare governi o promuovere referendum, non vuole difendere o affossare la costituzione, né spera di formare cittadini responsabili, né ambisce a ridurre il numero di disoccupati, né vuole evitare che i ghiacci dei poli si sciolgano (e tuttavia “essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi” magari invece sì, ma questo è ancora Kafka).
La letteratura può ovviamente anche sortire qualcuno degli effetti che non ne fanno la missione, ma ex post, per strade imprevedibili. E tuttavia di effetti involontari può produrne anche altri: basti pensare ai Dolori del giovane Werther che scatenò un’ondata di suicidi emulativi tra i giovani europei del periodo in cui uscì. Dunque attenzione ad assegnare un obiettivo pratico alla letteratura.
La letteratura è nella Storia, eppure al tempo stesso ha il vizio di tradirla, di farle il contropelo. La letteratura ha un passo strano, sempre un po’ più avanti o un po’ più indietro rispetto alla marcia assordante del discorso pubblico.
Certe volte, per essere contemporanea, si riduce a essere inattuale. Magari capita che salvi il mondo. Fosse per lei, però, non sarebbe neanche adatta a riparare il rubinetto di casa quando perde. La letteratura ha un compito molto meno ambizioso, eppure molto più ambizioso di questo.
Volete un esempio? Avevano tra i migliori scrittori, tra i migliori filosofi, tra i migliori musicisti, tra i migliori artisti, tra i migliori uomini di cinema… Erano le donne e gli uomini della Germania di Weimar. Ebbene, non è che La montagna incantata di Thomas Mann abbia impedito l’ascesa del Terzo Reich. O per venire in Italia, non è che le poesie di Ungaretti abbiano scongiurato un altro conflitto mondiale. Non è che le visioni di Kafka abbiano impedito la comparsa di Auschwitz. Questo è il passo breve della letteratura; qui la letteratura è come l’albatro del poeta, goffo e maldestro sul ponte della nave, preso in giro dai forzati dell’attualità.
Eppure (e questo è il passo più lungo della letteratura, la sua maggior ambizione), se La montagna incantata non impedisce l’avanzata dell’orrore, è anche grazie a libri come La montagna incantata, o alle parabole di Kafka, o alle poesie di Ungaretti o di Paul Celan (la vittima che si trovò a scrivere usando la lingua dei suoi carnefici), o le dolenti e vertiginose riflessioni di Primo Levi, è anche grazie a tutto questo che noi siamo in grado (forse persino stasera) di riconoscerci gli uni con gli altri come esseri umani nonostante i veri e propri disastri della specie che seminiamo lungo il nostro cammino per essere come siamo: dei legni storti.
Desiderio mimetico
La letteratura racconta dunque i legni storti, non ha la pretesa di raddrizzarli. Solo così aggiungiamo speranza alla speranza di mantenerci umani. Ci interessano le ragioni di Lucia Mondella, ma anche quelle di Lady Macbeth, ci troviamo a fare il tifo per il partigiano di Fenoglio eppure siamo sensibili all’oscuro magnetismo del Kurtz di Conrad. Il principe Minskyn ci commuove, ma siamo addirittura in grado di empatizzare con Humbert Humbert. Per parafrasare un cantautore, il problema (e il mistero) non è don Rodrigo in sé ma don Rodrigo in me.
La letteratura non è neanche la realizzazione di un desiderio mimetico a buon mercato. Siamo stati tutti cittadini di Sarajevo, come tutti avremmo voluto anni dopo essere Charlie per una notte, o newyorchesi per un giorno il 12 settembre, o aquilani sotto il terremoto per un pomeriggio, o tarantini all’ombra dell’Ilva per un anno. Attenzione, però. Il desiderio mimetico è il meno affidabile dei sentimenti contemporanei. Non di rado dichiara di volersi identificare con una vittima che non conosce bene, e le cui sofferenze mai si sobbarcherebbe sul piano di realtà. Il desiderio mimetico vorrebbe magari anche sì, occuparsi della realtà, se non fosse che è troppo impegnato a guardarsi allo specchio. Il desiderio mimetico si illude, magari sogna. Com’è bello essere un altro rimanendo ben saldi dentro le proprie scarpe.
La letteratura ci porta sì nelle scarpe e nelle vite e nei corpi e nelle sofferenze degli altri, ma riesce nell’impresa seguendo un percorso completamente diverso.
La letteratura abbraccia l’intero genere umano, e lo fa perché ha il coraggio di sondarne anche i coni d’ombra. I coni d’ombra di tutti. Per questo tocca in modo così profondo le nostre corde. Non spara sentenze, cerca di comprendere. La sua è un’istruttoria non finalizzata a gradi di giudizio. Avere braccia tanto larghe non è facile. Ci vuole fegato per dire: madame Bovary c’est moi. Don Abbondio sono io. Chiamatemi Iago. E certo, chiamatemi pure Gregor Samsa.
Sto dicendo che alla letteratura non resta che essere disimpegnata per continuare a fare il suo dovere?
Tutto il contrario. In un mondo in cui la semplificazione domina il discorso pubblico, lo slogan è un lasciapassare per la celebrità, non c’è impegno più grande che essere complessi, articolati, pieni di sfumature, carichi di contraddizioni e magari di stranezze. Esattamente come la condizione umana.
Un incredibile ruolo vicario
Abbiamo detto che il passo lungo della letteratura arriva a farci riconoscere ancora tra di noi come esseri umani. Ma qual è la conseguenza ideale di questo riconoscimento?
Potrebbe significare arrivare a testimoniare per chi non può farlo, o a comunicare con chi non può ricevere il messaggio. “Per l’analfabeta a cui scrivo”, è la dedica meravigliosa di La storia di Elsa Morante. Si potrebbe arrivare addirittura alla vertigine di Primo Levi in I sommersi e i salvati, quando, parlando di Auschwitz, dichiara che non sono quelli come lui i veri testimoni di quel disastro. E allora chi?, verrebbe da chiedere. I “testimoni integrali” sono coloro davanti ai quali si chiusero le porte delle camere a gas. “Lo ripeto”, scrive Levi, “non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri (…) noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua: siamo quelli che (…) non hanno toccato il fondo (…). Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o è tornato muto, ma sono loro (…) i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale”.
Dunque ci troviamo nel paradosso che i testimoni integrali sono coloro che non possono più testimoniare. Di qua, l’incredibile ruolo vicario della letteratura.
Ma forse c’è un punto addirittura ulteriore. Scusate se uso ancora un grande autore come stampella, ma è necessario.
C’è un racconto di Jorge Luis Borges, contenuto nell’Elogio dell’ombra, una raccolta del 1969. È un racconto brevissimo, poche righe, ve lo leggo:
Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: ‘Tu hai ucciso me, o io ho ucciso te? Non ricordo più: stiamo qui insieme come prima’. ‘Ora so che mi hai perdonato davvero’, disse Caino, ‘perché dimenticare è perdonare. Anch’io cercherò di scordare’. Abele disse lentamente: ‘È così. Finché dura il rimorso dura la colpa’.
Intanto Abele è riuscito a perdonare Caino perché ha bevuto le acque del Lete, il fiume in cui i morti dell’Eneide si tuffano per dimenticare le vite passate, e le anime di Dante si immergono nel Purgatorio per dimenticare i loro peccati prima di ascendere al cielo. Perdonare è dimenticare. Ma forse le cose non stanno solo come vorrebbe il loro significato letterale. Forse, il Lete è una figura retorica. Forse si può dimenticare (cioè perdonare) perfino in vita.
Per capire che cosa sto dicendo ci viene in aiuto ancora una volta Borges, dall’alto di una poesia contenuta nella stessa raccolta che ospitava il breve racconto su Caino e Abele. Questa poesia dà anzi il titolo all’intera raccolta, Elogio dell’ombra. Leggiamone un frammento:
Dal Sud, dall’Est, dall’Ovest, dal Nord,
convergono i cammini che mi hanno portato
nel mio segreto centro.
Quei cammini furono echi e passi,
donne, uomini, agonie, resurrezioni,
giorni e notti,
dormiveglia e sogni,
ogni infimo istante dello ieri
e di tutti gli ieri del mondo
(…)
Adesso posso dimenticarle. Arrivo al mio centro,
alla mia algebra, alla mia chiave,
al mio specchio.
Presto saprò chi sono.
“Adesso posso dimenticarle”, dice Borges, e (come una conseguenza) “Presto saprò chi sono”.
Dunque, si può dimenticare (vale a dire perdonare) anche restando in vita. Solo che la piena dimenticanza, il pieno perdono, in questo caso va di pari passo con la piena comprensione. Dimenticare (cioè perdonare) si può, ma a patto di giungere nel nostro centro, ossia arrivare a sapere chi siamo. Ciò che possiamo fare solo attraverso gli altri.
Ecco qual è il fine ultimo della letteratura, un fine che essa persegue senza mai dichiararlo, e senza mai seguirlo in via diretta. Anzi, a volte può prendere deliberatamente strade opposte. “Arrivo al mio centro”, scrive Borges, mentre spesso la grande letteratura esplora i margini, l’eccentrico, la periferia, ma, se è davvero buona, questo la porta paradossalmente a diventare all’istante il centro di cui scriveva Borges.
La letteratura non ha dunque a che fare con la geometria euclidea. Ma la letteratura ci porta idealmente a perdonare. E anche qui, non prendete la cosa letteralmente. Prendetela letterariamente. Perdonare non significa arrendersi ai propri carnefici, o ai propri aggressori. Significa comprendere, riconoscere se stessi e gli altri nella nostra pienezza di esseri umani – e cioè pozzi ricolmi di mediocrità ma anche pozzi senza fondo, come senza fondo è il creato di cui facciamo parte – ed è grazie a questa consapevolezza, una folgorazione che cancella se stessa nell’atto di rivelarsi alle nostre coscienze, che noi possiamo accedere (sia pure per poco tempo) a una dimensione a cui non eravamo arrivati prima. O forse c’eravamo stati molto a lungo, prima di dare il primo grido.
Lo so, una cosa del genere la diceva un pochettino meglio di così Schopenhauer.
Ma la letteratura (come le falene con la luna) ha bisogno di irraggiungibili punti luminosi sul suo capo per esplorare deserti, foreste, oceani, stagni, paesini e città che invece sì, sono raggiungibili eccome. E il paesaggio cambia di continuo. Oh, questo ve l’assicuro. Ecco perché non è vero che tutte le storie sono state raccontate, ecco perché la vita continua e nessuna generazione può avere la pretesa (e l’arroganza) di essere l’ultima.
Conoscevamo l’amore ai tempi del colera, non quello ai tempi dell’hiv. Avevamo notizia delle relazioni pericolose che possono correre per gli scambi epistolari, non dei disastri diplomatici (e sentimentali) che possono esplodere attraverso uno scambio di posta elettronica o di sms. Avevamo seguito le vicende di donne che finivano per buttarsi sotto i treni, mai avremmo immaginato di vederle volare a diecimila metri di altezza, con il cuore spezzato, dirette verso altri continenti. C’erano una volta uomini politici che regalavano una scarpa a tutti gli elettori potenziali, e promettevano di regalare l’altra a chi li avesse votati. Questo, avevamo imparato a chiamarlo populismo. Ma siamo rimasti senza parole quando un uomo politico è venuto a dirci di avere acquistato una casa a sua insaputa.
Come vedete, il mondo cambia forma e maschera, e lo fa continuamente. La Terra al centro del sistema solare è diversa dalla terra alla periferia della periferia dell’universo. Credevamo che il tempo fosse lineare, e invece non lo era. Non sapevamo cosa fosse l’inconscio né il bosone di Higgs. La possibilità degli universi paralleli sembrava solo fantascienza. Due ragazzi che si baciano in un fienile non sono due ragazzi che si baciano a un rave, o nelle profondità di una linea della metropolitana.
Il mondo non si ferma, la letteratura lo insegue. Di storie ne nascono sempre di nuove e di diverse, e con la novità della materia del racconto cambia, più o meno lentamente, anche la forma che gli dà sostanza. Forse ci stiamo avvicinando al punto che ci sfuggì la volta scorsa. Intravediamo qualcosa sulla linea d’orizzonte, ma non riusciamo ancora a capire di che si tratta. Allora allunghiamo il passo, pieni d’ansia e di paura, ma anche di curiosità, di speranza. Erano i tempi migliori, erano i tempi peggiori. Da questo punto di vista il sole è sempre alto e implacabile nel cielo, il che vuol dire che soffriamo, ma non ci sono mai braccia a sufficienza per l’abbondanza del raccolto. Il lavoro da fare è come sempre enorme. Coraggio, ce n’è per una vita intera.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it