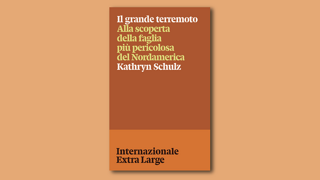La grande maggioranza dei lavoratori statunitensi pensa che il fattore determinante del proprio salario sia l’impegno. Di recente ho coinvolto in un sondaggio più di mille dipendenti. Davanti a una lista di fattori, tra cui l’anzianità, l’esperienza, il livello d’istruzione e i profitti aziendali, due terzi degli intervistati hanno risposto che le prestazioni individuali erano per loro il fattore che decideva la busta paga. In realtà, la maggior parte di noi non è pagata in base alle sue prestazioni e la percentuale del salario determinata dall’impegno individuale è perfino diminuita nel tempo. Secondo alcune ricerche, negli anni ottanta i sistemi retributivi legati alle prestazioni erano più diffusi e hanno raggiunto la massima applicazione nei primi anni duemila, per poi calare nei due decenni successivi. Nel 2009 un gruppo di ricercatori ha scoperto che “pochi lavoratori ricevono una paga legata direttamente alla produttività e che il loro numero è probabilmente in ulteriore calo”. E anche quando si considera la produttività dei lavoratori, in genere questo fattore pesa solo in piccola parte sul salario complessivo.
Assenza di consenso
Analizzando il fenomeno, saltano agli occhi tre fattori: l’attenzione all’equità, la difficoltà in molti lavori nel misurare le prestazioni individuali e l’assenza di consenso su cosa significhi esattamente “prestazione”. Nel 2008 il quotidiano Sacramento Bee pubblicò online la paga dei dipendenti statali. Alcuni ricercatori ne approfittarono per seguire le reazioni dei lavoratori. Chi scoprì di essere pagato meno dei coetanei che svolgevano una mansione simile rimase deluso e si mise a cercare un nuovo lavoro. Chi scoprì di essere pagato più dei colleghi, invece, non diventò all’improvviso più fedele all’azienda né più soddisfatto del datore di lavoro. Perché? Una risposta che danno da tempo gli studiosi di psicologia sociale ed economia è che la maggior parte di noi pensa di essere piuttosto brava in quello che fa. Anzi, in genere è convinta di essere meglio degli altri. In un sondaggio degli anni sessanta fu chiesto a professionisti e manager come valutassero le loro prestazioni rispetto a quelle dei colleghi. In media gli intervistati consideravano le loro prestazioni migliori di quelle di tre quarti dei colleghi. Solo due dei circa cento intervistati affermarono di avere prestazioni inferiori alla media.
Sono numeri matematicamente impossibili e pongono un problema ai datori di lavoro che vorrebbero differenziare le retribuzioni in base alla produttività. Questa mossa scontenterebbe molti lavoratori, erroneamente convinti di essere più produttivi dei colleghi. Così i datori di lavoro lasciano perdere, evitando anche i problemi di equità che emergono quando i lavoratori pensano di meritare più dei colleghi.
Pagare un dipendente in base alle sue prestazioni presuppone che esista una misurazione affidabile della produttività. In alcuni campi c’è: il trasporto su camion, per esempio, comporta lo spostamento di quante più merci possibili da un punto a un altro, in modo rapido e sicuro. Ma nella maggior parte degli impieghi non ci sono misurazioni comparabili. Questa difficoltà è più evidente per quei lavori intellettuali che si sono moltiplicati negli ultimi decenni, come le consulenze aziendali. Oggi sono milioni e valutare e quantificare le prestazioni individuali in questi casi va oltre le nostre capacità, semplicemente perché non esiste il metro di misura giusto.
Può essere difficile anche nelle professioni per cui c’è consenso su uno standard generale. Per i medici l’obiettivo è migliorare la salute dei pazienti. Quindi dovrebbero essere pagati in base alla salute dei loro pazienti o piuttosto per la corretta esecuzione di compiti specialistici, come per esempio una protesi all’anca? E se il medico preferisse l’intervento chirurgico a opzioni meno invasive per farsi pagare di più? Nel Regno Unito, sotto il governo di Tony Blair, il servizio sanitario nazionale aumentò i finanziamenti agli ospedali che riducevano i tempi d’attesa. Ben presto, però, emerse un problema: nel tentativo di raggiungere gli obiettivi sui tempi d’attesa e assicurarsi i fondi, gli ospedali trattenevano i pazienti in ambulanza prima di trasferirli in sala d’attesa. Perché? Il tempo trascorso in ambulanza non contava come attesa, stando al criterio di misurazione delle prestazioni.
Scelte e compromessi
Per molti lavori la definizione di produttività implica scelte e compromessi, non esiste una misurazione unica e oggettiva. Nel 2014 il gruppo editoriale Time, che all’epoca possedeva più di novanta testate, cominciò a valutare le prestazioni dei suoi giornalisti nel produrre contenuti “vantaggiosi per il rapporto con gli inserzionisti”. I giornalisti erano sconvolti dal fatto che la loro professione potesse essere ridotta a una misura così grossolana. Ma come si può misurare la produttività di un giornalista? Numero di articoli scritti a settimana? E allora che dire del tempo speso a coltivare fonti per reportage approfonditi?
Le controversie sulle definizioni toccano tutte le professioni. Alcuni giornalisti, per esempio, credono che il vero scopo del loro lavoro sia produrre inchieste pluripremiate, mentre altri ritengono che i profitti siano la questione centrale. Alcuni professori universitari danno la priorità all’insegnamento, mentre altri credono che un’università vada valutata principalmente in base all’attività di ricerca.
In altre parole, le discussioni sulla definizione derivano spesso da disaccordi su ciò che dovrebbe essere il “prodotto” di un’organizzazione. Se non c’è un’intesa su questo aspetto, non ci può essere accordo sul contributo individuale apportato da ciascun lavoratore per realizzarlo. Di conseguenza, compensare i lavoratori sulla base della produttività individuale scontenterà chiunque abbia una visione diversa da quella adottata. ◆ nv
Jake Rosenfeld _ è un sociologo della Washington university. Quest’articolo è tratto dal suo saggio You’re paid what you’re worth : and other myths of the modern economy (Harvard University Press 2021)._
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1404 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati