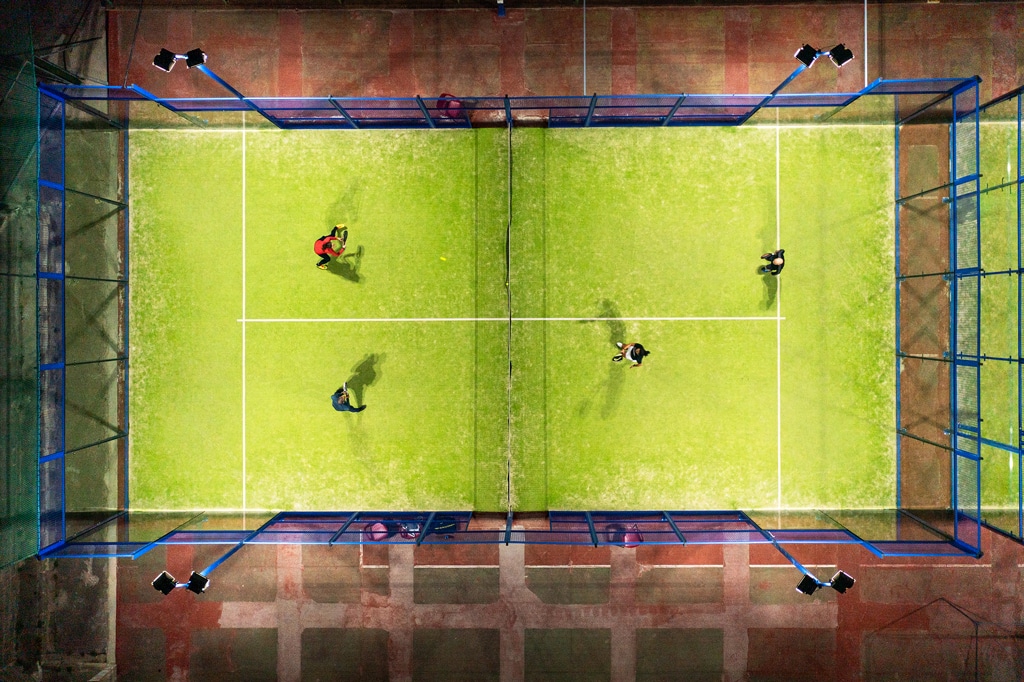Sulla settantesima edizione del festival veneziano daremo presto le nostre valutazioni assieme a quelli di altri critici sul festival che ha avuto nel concorso delle scelte sorprendenti e coraggiose ma ha dimostrato molto meno coraggio e capacità di sorprendere nella sezione di esplorazione, Orizzonti. Milanesi e romani possono in questi giorni scoprire alcuni dei film presentati quest’anno nelle rispettive rassegne di Venezia a Milano e Venezia a Roma. Non figura peraltro nelle rassegne cittadine in corso questo Die Andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht, che è stato invece uno degli avvenimenti di spicco extra-concorso.
Ma intanto ecco un estratto dell’intervista che ci ha gentilmente offerto Giampiero Raganelli, ottimo critico di cinema, grande esperto di cinema d’Estremo Oriente, ma non solo, come dimostra quest’estratto per il quale lo ringraziamo vivamente. E lascio a lui la parola (scritta).
Dopo la monumentale saga di Heimat in tre parti, più Heimat-Fragmente: Die Frauen, il regista Edgar Reitz torna nell’immaginaria cittadina di Schabbach per ambientarvi un film, Die Andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht, che si svolge antecedentemente al primo Heimat, nell’Ottocento. Protagonisti due fratelli che anelano ad andarsene dal villaggio.
Abbiamo incontrato il regista durante la 70. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove il film è stato presentato.
Anche qui, come nella precedente trilogia di Heimat, c’è una scissione in alcuni personaggi, tra la propria heimat di appartenenza, e una tensione all’emigrazione, alla ricerca di una nuova terra, in questo caso rappresentata dal Brasile e dal Nuovo Mondo che furono la destinazione di un esodo forzato dei contadini poveri e degli artigiani tedeschi a metà Ottocento. Qual è il suo concetto di heimat?
Alla base di tutto questo c’è una parte della mia biografia. Io stesso sono cresciuto in una zona rurale, in un piccolo paese e per potermi realizzare, per seguire il mio interesse cinematografico – lì dov’ero non avevo nessuna possibilità – sono dovuto emigrare in una grande città. Questa è la condizione di tante persone che vivono nelle grandi metropoli, conglomerati di individui venuti con l’intento di poter realizzare i propri interessi, i propri sogni.
Facendo il punto sul percorso di questa realizzazione personale mi sono dovuto rendere conto a un certo momento, soprattutto in questo mondo caratterizzato dalla competizione e dalla concorrenza, che una volta trovato qualcosa – realizzandoci – l’abbiamo perso al contempo. Questo dolore della perdita è una dimensione psichica della provenienza. Il concetto di heimat. Un mondo senza parole, un mondo che non si può spiegare, un mondo emotivo, interiore. Quanto guadagniamo da un lato riuscendo a raggiungere i nostri obiettivi, perdiamo, dall’altro, ciò che portavamo con noi fin dalla nascita. C’è un dolore che nasce da questa dicotomia, tra quello che riusciamo a guadagnare e quello che perdiamo.
Da questa ambivalenza, dal guadagnare libertà e perdere allo stesso tempo una dimensione interiore, nasce il mio interesse verso il concetto di heimat, al quale non credo ci sia una risposta intellettuale, ma solo una risposta che si può esprimere artisticamente.
**L’interesse di uno dei protagonisti, Jacob, per la lingua dei nativi dell’America del Sud rientra in questa tensione verso altre culture, anche lontane?
**
Storicamente l’alfabetizzazione del popolo tedesco attraverso l’obbligo scolastico, risale a dopo Napoleone, nel 1815. Questi ragazzi, che nel 1815 avevano cinque o sei anni, rappresentano la prima generazione ad aver letto libri, ad aver potuto studiare senza appartenere a un’élite aristocratica o a una classe più intellettuale. E queste prime ondate di immigrazione tedesca sono riconducibili a questa alfabetizzazione postnapoleonica.
Quello che all’epoca succedeva, la possibilità di poter leggere, d’un sol tratto, libri e giornali, è paragonabile all’odierna diffusione delle informazioni attraverso la televisione e internet. Molte delle grandi ondate di immigrazione del giorno d’oggi sono date dal fatto che ovunque è ottenibile un’informazione. In un miscuglio di cultura, sapere e fantasia o proiezione di quello che ciascuno estrapola da queste informazioni che riesce a ricevere. Quindi queste immigrazioni di massa hanno la medesima caratteristica.
**Come mai dopo la trilogia ha deciso di tornare ancora a Schabbach, in quel villaggio immaginario e al suo universo, per realizzarvi un prequel?
**
Il ciclo di Heimat per me è effettivamente chiuso, non considero questo film un prequel. È un film assolutamente autonomo e indipendente, fatto non per la televisione, ma pensato per il grande schermo. E’ ambientato nello stesso luogo, ma la sua prossimità con gli altri cicli è culturale più che strutturale.
Una domanda formale. C’è un senso di galleggiamento, di fluidità della macchina da presa per l’intero film, evidentemente realizzato con l’impiego della steadycam. Che effetto voleva raggiungere?
Il concetto visivo del film è esattamente questo. Volevamo un film che non avesse gravità che fosse appunto galleggiante. Che rispecchiasse questo mondo in qualche modo fantastico. Ci sono vari indizi in questo senso, per esempio quando Jacob cade dall’albero senza farsi male. C’è come una sospensione. Effettivamente non si è mai usato un cavalletto. Tutto è stato girato in* steadycam* o con una grossa gru.
**Ci può dire invece qualcosa su questi dettagli a colori, nel contesto di un film in bianco e nero?
**
È chiaramente un film in bianco e nero. Se si potesse dire, lo definirei un film in bianco e nero a colori. Ci sono piccoli momenti, come appunto la parte blu, la bandiera che simboleggia la libertà, il ferro di cavallo rovente, momenti molto emotivi che non si potevano rendere se non attraverso il colore. È una cosa che ho già sperimentato varie volte negli altri film di Heimat. Per me è una cosa molto importante la libertà di poter usare il colore quando penso sia necessario e diventi un elemento poetico.
Come concepisce il rapporto tra la Storia e le storie degli uomini che si inseriscono nella grande storia della Germania?
Questa è la domanda delle domande, la domanda della mia vita. Per dirla brevemente, la Storia è un’astrazione, se oggetto di ricerca scientifica si allontana dalla vita vissuta, ma ci permette di dare una spiegazione a degli eventi storici, che hanno portato avanti o indietro il mondo. Io non sono uno storico e non comprendo la vita in questi termini. Per me la Storia sono le piccole storie. È l’unico modo che io ho di capire ciò che mi circonda, di capire il mondo e di capire perché le cose siano come sono.
Nel film compare, in un ruolo cammeo, il regista Werner Herzog, impegnato in un dialogo proprio con lei. Ci può dire com’è nata questa scena e perché ha deciso di scritturare il suo collega?
Il personaggio di Alexander Von Humboldt non è un ruolo che un attore qualsiasi avrebbe potuto fare, anche perché non è un ruolo che si possa elaborare. È talmente breve, come un’esistenza puramente spirituale che si materializza a quel momento. Ho cominciato a chiedere a tutta una serie di colleghi e ho scritto una mail anche a Herzog in California, che mi ha subito risposto. Era disponibilissimo e anzi tre giorni dopo era in Germania. La sua unica condizione per fare quel ruolo è stata che avrei dovuto esserci anch’io nel film. È un piccolo confronto tra la finzionalità e la storia, che a me è piaciuto molto. Lui passa e mi chiede «Che luogo è questo?» e io rispondo «È Schabbach». Un passaggio dalla finzione alla realtà anche come citazione cinematografica. Una bella autocitazione.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it