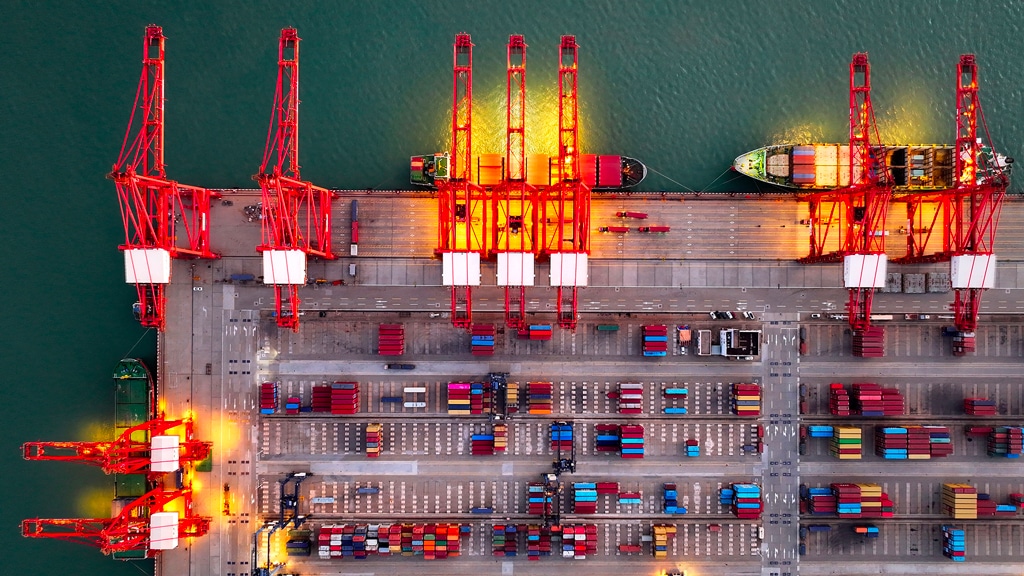Il 6 novembre il New York Times ha pubblicato nella sezione opinioni la trascrizione di un episodio del podcast Interesting times che all’inizio era intitolato: “Le donne hanno rovinato i luoghi di lavoro? E se sì, il femminismo conservatore può risolvere il problema?”.
Nei giorni successivi l’articolo ha suscitato tante critiche che il titolo è stato cambiato diverse volte. Alla fine è diventato: “Il femminismo liberal ha rovinato i luoghi di lavoro?”. E il sottotitolo: “Il femminismo conservatore può risolvere il problema?”. L’articolo non è stato rimosso nonostante le proteste di molte lettrici che hanno minacciato di sospendere l’abbonamento al New York Times. Il podcast è un dibattito tra un opinionista conservatore del giornale, Ross Douthat, e due autrici antifemministe, Helen Andrews e Leah Libresco Sargeant.
Andrews è l’autrice di un saggio che sta suscitando molte polemiche negli Stati Uniti e che si chiama The great feminization (La grande femminilizzazione). Nel testo Andrews sostiene che i luoghi di lavoro sono ormai troppo “femminilizzati”, cioè che ci sono troppe donne e questo li ha peggiorati, perché ha permesso la diffusione di idee, valori e atteggiamenti che per Andrews sono intrinsecamente femminili come l’empatia e la cooperazione.
Andrews attribuisce alla presenza delle donne il successo del “politicamente corretto”, che lei chiama wokeness (”wokismo”; da woke, “sveglio, attento alle ingiustizie”). E sostiene che a questa presenza sia legata “l’esplosione di follia del 2020”, cioè le proteste di massa negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Si tratta, sostiene, di “un piccolo assaggio di ciò che riserva il futuro”.
Anche Libresco Sargeant è dello stesso orientamento. Ma nella conversazione sembra assumere posizioni più moderate. Nel suo The dignity of dependence (La dignità della dipendenza), l’opinionista cattolica e conservatrice sostiene che il femminismo progressista ha fallito perché ha costretto le donne ad adattarsi a luoghi di lavoro e sistemi sociali pensati per gli uomini, svalutando il lavoro di cura e le mansioni domestiche e piegando anche le lavoratrici al modello maschile, assunto come universale. Libresco Sargeant si definisce “femminista conservatrice”.
Nella conversazione del podcast i termini woke o wokeness sono usati venticinque volte in vario modo, per indicare concetti diversi. “La patologia nelle nostre istituzioni nota come wokeness è femminile e femminilizzata… in senso molto letterale, le nostre istituzioni sono diventate woke perché ci sono più donne al loro interno rispetto al passato”, dice Andrews elencando tutte le conseguenze negative del movimento #MeToo, che nell’ottobre del 2017 portò alla denuncia di molestie, abusi e violenze sessuali prima nell’industria del cinema e dello spettacolo statunitense e poi in ogni campo e in tutto il mondo. Andrews spiega che alle donne piace “spettegolare” e che “sono incapaci di gestire direttamente i conflitti”.
Il podcast e la sua trascrizione non sono un editoriale del quotidiano di New York, ma la scelta di dargli una posizione di rilievo, sapendo che susciteranno molte critiche, non è casuale.
Segnala la diffusione sempre maggiore delle teorie che mettono al centro la misoginia dei conservatori oggi al governo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Queste teorie individuano un disagio reale sia delle lavoratrici sia degli uomini che si sentono impoveriti e messi in discussione da nuovi modelli di femminile. Ma il loro obiettivo è colpire l’autonomia economica delle donne, la loro presenza nei posti di lavoro (ancora molto lontana dalla parità in tutto il mondo) e la loro libertà.
Alcuni analisti hanno fatto notare che mentre il New York Times pubblicava l’articolo sulla femminilizzazione dei posti di lavoro, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum era molestata da un uomo in pubblico durante un evento a Città del Messico. “La leader di un paese non può svolgere il suo lavoro senza essere molestata in pubblico e il New York Times ci chiede di riflettere sull’eccessiva femminilizzazione del mondo del lavoro”, ha commentato Arwa Mahdawi sul Guardian.
Negli stessi giorni l’ex first lady statunitense Michelle Obama dichiarava durante un’intervista che il suo paese non è ancora pronto per avere una donna alla presidenza, come è stato dimostrato dalla sconfitta di Kamala Harris alle scorse elezioni. “Ci sono molti uomini che ancora non accettano di essere guidati da una donna”, ha detto Obama.
Mentre i diritti delle donne sono ridimensionati, in quello che la femminista Susan Faludi negli anni ottanta avrebbe definito un backlash, cioè un’ondata regressiva, un ritorno indietro dopo tanti progressi, le destre al potere attaccano le libertà femminili in modo aggressivo e con grande visibilità anche su pubblicazioni progressiste come il New York Times.
È il sintomo di almeno due fenomeni: in molti paesi le donne stanno lasciando il lavoro dopo la pandemia a causa della crisi del welfare; e le estreme destre al potere stanno prendendo di mira le donne che lavorano, esaltando modelli più tradizionali di femminilità e di famiglia, con una struttura ideologica che si diffonde anche online.
Va in questa direzione per esempio il successo delle influencer antifemministe e della sottocultura delle traditional wives (o tradwife) sui social media come TikTok e Instagram, un fenomeno che s’intreccia a quello della manosfera. La pandemia ha messo in luce che quando una società non ha al centro la cura e il lavoro di cura va incontro a crisi strutturali importanti. Ma invece di ripensare la società e il sistema produttivo, si è preferito tornare indietro a modelli più tradizionali.
Una su due non lavora
In primo luogo “la grande femminilizzazione” di cui parla Helen Andrews (che ricorda la teoria del complotto razzista della grande sostituzione etnica) non esiste nella realtà. Secondo l’International labour organization (Ilo), nel mondo il 47 per cento delle donne lavora, più di una su due quindi resta a casa. Mentre è impiegato il 7o per cento degli uomini.
Le donne hanno più difficoltà degli uomini a trovare un lavoro. Secondo l’Ilo, sono 708 milioni quelle escluse dal mercato del lavoro nel mondo. È un dato più evidente in Nordafrica e nei paesi arabi, dove il tasso di disoccupazione femminile supera il 20 per cento, ma in quasi tutti i paesi del mondo c’è ancora una forte disuguaglianza di accesso al lavoro, di salario e di carriera.
Negli Stati Uniti all’inizio del 2025 il divario tra i sessi è stato il più basso mai registrato, ma dall’agosto del 2024 hanno lasciato il lavoro o lo hanno perso seicentomila donne. A settembre del 2025 lavorava il 57,4 per cento delle donne, contro il 67,8 degli uomini. Se si paragona agli ultimi ottant’anni, si registra un importante progresso, ma con degli alti e dei bassi. Nel 1948 solo il 32 per cento delle donne era impiegato o in cerca di lavoro negli Stati Uniti, contro l’87 per cento dei coetanei maschi.
Nei primi due decenni di questo secolo il divario tra donne e uomini ha continuato a ridursi, a causa del calo dell’occupazione maschile. Poi la pandemia di covid-19 ha fatto perdere molti posti di lavoro in vari settori, ma le donne si sono riprese più velocemente. Il nuovo calo dell’occupazione tra le donne statunitensi è legato in gran parte alla crisi dello stato sociale e alla difficoltà di conciliare lavoro e figli, in un contesto in cui i servizi sono sempre di meno e la cura è ancora sulle spalle delle donne, mentre s’impongono modelli culturali più reazionari.
Secondo l’Economist, una delle ragioni più fondate di questa tendenza è la difficoltà di conciliare vita personale e lavoro soprattutto per le madri lavoratrici: “È possibile che le madri stiano lasciando il lavoro a causa dell’aumento dei costi dell’assistenza all’infanzia. Questa idea sembra confermata dai dati del Census bureau: il tasso di partecipazione al mondo del lavoro delle donne in età lavorativa (25-54 anni) con figli sotto i cinque anni è diminuito rispetto al picco registrato dopo la pandemia”.
La propaganda delle casalinghe
In Italia la situazione è anche peggiore. Uno studio della School of gender economics dell’Unitelma Sapienza, presentato al senato il 1 dicembre, sottolinea che negli ultimi tre anni il paese ha perso ventidue posizioni nel Gender gap index del World economic forum. In Italia lavora poco più di una donna su due contro il 70,4 per cento degli uomini e il paese è all’85° posto su 148 nella classifica mondiale del contrasto al divario di genere.
“Abbiamo lavorato tre anni a questa ricerca, che mette nero su bianco quanto è lontana la parità di genere nonostante la falsa narrazione consolatoria secondo cui ormai le donne sarebbero dappertutto”, ha detto Azzurra Rinaldi, che ha guidato lo studio insieme a Claudia Pitteo. Più del 70 per cento delle donne che hanno intervistato non ha accesso allo smart working e il 53 per cento ammette di occuparsi da sola del lavoro domestico.
Anche in Italia per le donne che lavorano l’ostacolo più grande è ancora la maternità. “Ci sono meno possibilità di essere assunte dopo aver avuto un figlio. E chi già lavora ha meno possibilità di crescita professionale e riceve un salario più basso”, chiarisce Pitteo. Questa situazione produce nelle donne in età lavorativa una specie di burn out cronico, una stanchezza che spinge a lasciare il posto di lavoro soprattutto nei primi anni di vita dei figli. Lo ha sostenuto anche la demografa Alessandra Minello nel suo saggio Non è un paese per madri.
Alla fine degli anni novanta si parlò molto di femminilizzazione dei posti di lavoro, ma s’intendeva soprattutto l’adozione di modelli lavorativi più precari con l’adozione più diffusa di contratti part time e lavoro autonomo. Molti sostenevano che questo avrebbe favorito la conciliazione tra vita privata e lavoro e che avrebbe favorito soprattutto le donne, mentre nei fatti la precarizzazione del mondo del lavoro le ha penalizzate, perché le ha spinte verso contratti meno garantiti.
Lo stesso dibattito si è riproposto dopo la pandemia di covid-19 con esiti simili: la questione che rimane sul tavolo è la mancata femminilizzazione dei posti di lavoro, cioè l’assenza di politiche e culture del lavoro che favoriscano davvero l’inclusione delle donne, considerando anche le loro esigenze.
Ma questa volta, spiega la sociologa Silvia Semenzin, le estreme destre al governo in molti paesi hanno provato a rispondere al burn out delle lavoratrici e delle madri con modelli più conservatori, provando ad allontanare l’attenzione dalla crisi dello stato sociale con l’aiuto dei social media.
“Le tradwife sono l’altra faccia della manosfera e degli incel, dobbiamo interpretare il successo di queste influencer antifemministe e conservatrici come un progetto preciso e ben finanziato dalla politica, ma soprattutto dalle aziende tecnologiche”, spiega Semenzin, autrice del saggio Internet non è un posto per femmine.
Con tradwives, cioè “mogli tradizionali”, si indica la galassia di account di successo su YouTube, TikTok e Instagram gestiti da donne che esaltano il ruolo di casalinga e di madre, si sottomettono con entusiasmo al marito, disprezzano le donne che lavorano, filmano e postano online i video della loro vita familiare apparentemente idilliaca.
Belle, mai in disordine, eleganti, ma sobrie, affaccendate nei lavori domestici. Cucinano le lasagne o il ciambellone mentre si prendono cura dei figli neonati e lasciano intendere che la famiglia tradizionale è il paradiso perduto da cui le donne si sono volontariamente e a torto esiliate. Nessuna macchia, nessuna fatica, nessuna sporcizia.
“Il fenomeno nasce negli anni dieci del duemila negli Stati Uniti, ma ormai ci sono tradwives in tutti i paesi. Hanno milioni di follower. In alcuni casi hanno rapporti espliciti con i partiti dell’estrema destra e partecipano ai loro raduni. Penso al caso della spagnola RoRo, 22 anni, che andava alle manifestazioni del partito di estrema destra Vox”, spiega Semenzin. “In Italia le casalinghe influencer non sono arrivate, ma ci sono ‘le mantenute’, donne che sostengono i vantaggi di farsi mantenere economicamente dal loro compagno”.
Le più famose sono Hannah Neeleman e Nara Smith negli Stati Uniti, l’autrice e blogger inglese Alena Kate Pettitt, e altre influencer come Estee Williams. Fanno pensare alle campagne pubblicitarie sulle casalinghe perfette che ebbero successo nel decennio successivo alla seconda guerra mondiale, perché dovevano convincere le donne a tornare a ruoli più tradizionali, dopo aver sperimentato più libertà durante il conflitto, quando avevano potuto lavorare perché gli uomini erano al fronte.
“Sono fenomeni tutt’altro che spontanei, sono il prodotto di investimenti precisi delle aziende tecnologiche che ne favoriscono i contenuti, polarizzando i modelli di femminilità e creando un’inconciliabile tensione tra casalinghe perfette (tradwives) e girlboss, cioè donne che lavorano e hanno potere rinunciando alla maternità e alla famiglia”, continua Semenzin. In entrambi i casi si tratta di modelli irrealistici che producono infelicità per le donne, le riportano indietro e le allontanano dall’autonomia e dalla libertà conquistate.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it