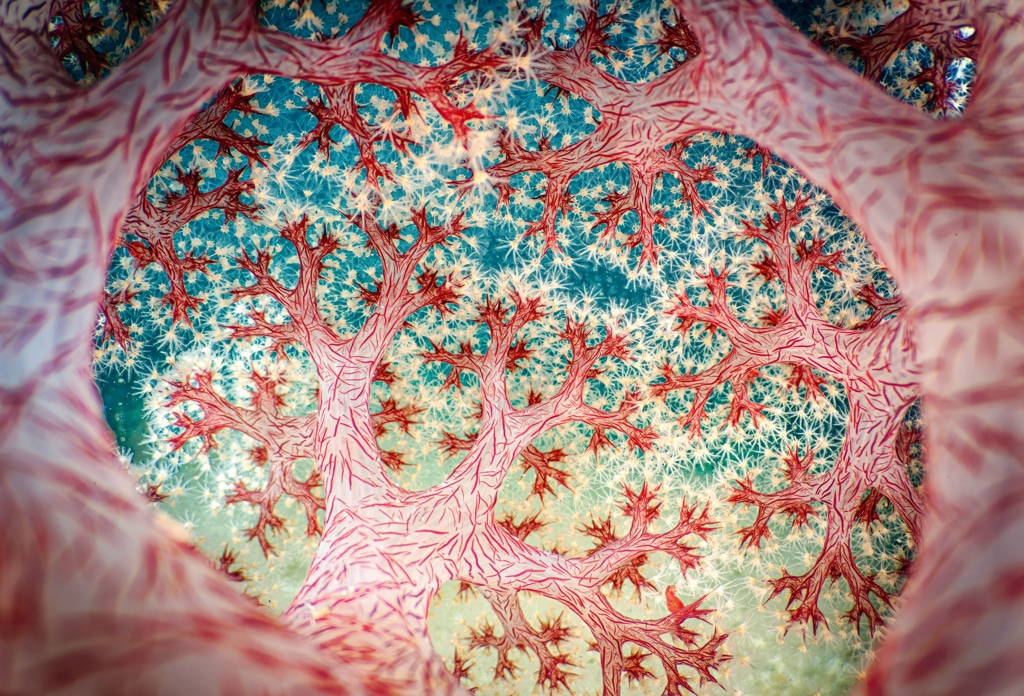È da tempo che non si discuteva così tanto di insegnamento e didattica come sta succedendo in queste settimane, dopo che il ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato la bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Un testo così importante che si potrebbe definire come una specie di carta costituente per la scuola. Il documento definisce quali sono le conoscenze e le competenze per i vari cicli d’istruzione, il riferimento fondamentale per insegnanti, ma anche per tutte le varie comunità educanti (studenti, dirigenti, famiglie, il vario personale scolastico).
La discussione sulle indicazioni risale al 2007, nel 2012 ne è stata pubblicata una versione, poi rivista nel 2018. L’attuale ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha infine incaricato una commissione composta da 115 esperti, coordinati dalla professoressa di didattica generale e speciale Loredana Perla, per rivederle ancora, in modo corposo. L’11 marzo è uscita questa bozza. Quella per il secondo ciclo (secondaria di secondo grado) non sappiamo quando sarà diffusa ma entrerà in vigore nel 2027.
Nonostante spesso si parli indistintamente di indicazioni nazionali e di programmi, bisogna sapere che le indicazioni nazionali hanno sostituito i programmi dopo la legge sull’autonomia scolastica della fine degli anni novanta. La differenza è chiara: lì dove i programmi tendevano a omologare il lavoro degli insegnanti, le indicazioni cercano invece di valorizzare le differenze delle varie scuole; lì dove i programmi erano prescrittivi e fatti per durare, le indicazioni nazionali sono pensate per orientare e essere continuamente ridiscusse nel lavoro quotidiano in classe.
Il dibattito sulle nuove indicazioni è stato preceduto e accompagnato da quello sulle diverse dichiarazioni del ministro Valditara e della presidente della commissione Perla, che si stanno esponendo molto, anche personalmente, per difendere la proposta pedagogica contenuta nella bozza. Tra le tante dichiarazioni ufficiali e non, se ne possono citare due che sintetizzano bene qual è la novità della loro visione.
La prima è parte dell’intervento che Valditara ha fatto al congresso della Lega: “Vogliamo una scuola seria, che chiuda definitivamente l’epoca in cui merito, regole, responsabilità, impegno, rispetto, erano considerati da una certa intellighenzia di sinistra disvalori”. Una scuola che torni a insegnare “nell’epoca di internet e del cellulare aiuti a coltivare la memoria ritornando a far studiare le poesie, che insegni la logica e il ragionamento con il ritorno del latino, che insegni a scrivere bene (…) che rispetti la lingua italiana evitando asterischi e schwa (…) Una scuola che ponga rimedio alla pedagogia dello spontaneismo e della deresponsabilizzazione”.
Di Perla invece si possono citare le parole pronunciate durante il dibattito organizzato da Tuttoscuola e dalla fondazione Agnelli, in cui rivendica la discontinuità con il testo del 2012: “L’impianto ideologico delle indicazioni ha subìto una torsione che è quella del personalismo comunitario di Emmanuel Mounier”. Inoltre, ha continuato Perla: “C’è un grande elemento che nelle vigenti indicazioni non c’è e che noi abbiamo voluto introdurre ed è la valorizzazione della docenza, questo è un punto chiave. In questa sottolineatura dell’insegnante professionista ma anche Maestro con la “m” maiuscola si vuole riconoscere una titolarità dal punto di vista culturale e intellettuale pari a quella che la nostra tradizione pedagogica puerocentrica attribuisce allo studente”.
Il personalismo comunitario di Mounier (una teoria sviluppata dal filosofo cattolico francese nel periodo tra le due guerre mondiali) e la restituzione di uno status di autorità ai docenti sono sicuramente due punti chiave importanti che emergono con evidenza nelle nuove indicazioni e su cui Valditara e Perla si ritrovano in modo convergente.
Nella premessa della bozza sulle indicazioni, intitolata “Persona, scuola, famiglia”, il testo ha diversi richiami a Mounier e al personalismo, e inoltre si legge: “Troppo spesso si dimentica che un insegnante è magis, di più, e che è il volano del desiderio di apprendere di un allievo”.
Perché questi riferimenti sono così ripetuti? Innanzitutto la convinzione di Perla e Valditara è che le criticità della scuola italiana – quelle che emergono nelle statistiche internazionali sull’alfabetizzazione, le competenze di base, eccetera – siano in parte il risultato di un andamento lassista che la scuola italiana avrebbe intrapreso almeno dal sessantotto, quando è stato messo in discussione il concetto di autorità, anche da quelle che sono considerate delle derive dell’attivismo pedagogico (“Lo spontaneismo e la deresponsabilizzazione”, nelle parole di Valditara). Il rimedio consisterebbe nel ritorno o nel progresso verso una “una scuola seria”.
Il riferimento a Mounier è spesso invece usato da Valditara per proporre un’altra lettura, personalista, anche del dettato costituzionale. In molte occasioni, anche ufficiali, ha sottolineato come il termine persona nella costituzione sia stato usato da chi ha concepito e redatto il testo per contrastare una visione statolatrica, ossia di centralità dello stato, che secondo Valditara è tipica dei totalitarismi, sia fascista sia comunista.
La quantità di reazioni critiche è cresciuta fino a diventare quasi una bocciatura
In questa lettura sembra implicito che andrebbe ridotto il peso della prospettiva ideale e politica che i costituenti del partito comunista e di quello socialista vollero inserire nella costituzione: dai valori della giustizia sociale a quelli dell’uguaglianza sostanziale.
Del resto sempre la premessa generale della bozza sulle indicazioni sembra ricalcare alcune uscite pubbliche di Valditara proprio sulla costituzione, a partire dall’incipit: “La costituzione mette al centro la persona e concepisce lo stato per l’uomo e non l’uomo per lo stato come opportunamente sottolineava il costituente Giorgio La Pira”.
Ci sarebbero tante notazioni tecniche da fare sul testo delle nuove indicazioni, che è molto lungo, 154 pagine fitte: quello precedente era meno della metà. Ma vorrei concentrarmi su questi aspetti più generali: se riconosciamo la battaglia ideologica intrapresa dalla proposta delle nuove Indicazioni e dal progetto pedagogico di Perla e Valditara riusciamo a capire meglio la discussione ricchissima e accesissima che si sta sviluppando tra pedagogisti, maestri, educatrici, professori e associazioni che si occupano di insegnamento.
La quantità di reazioni che vanno dal critico all’indignato, e di analisi approfondite delle varie sezioni, è cresciuta fino a diventare quasi una bocciatura sia dei contenuti sia del metodo. Lo stesso questionario proposto dal ministero per fare dei rilievi alla bozza è stato considerato da molti uno strumento insufficiente. O addirittura “risibile”, per citare Italo Fiorin, il coordinatore della commissione del 2007, che ha messo in fila molte critiche nel confronto di Tuttoscuola citato sopra. Il questionario è stato rivisto, le modalità di risposta sono state cambiate, il termine per rispondere è stato prorogato di una settimana; ma non sembra assolutamente nelle intenzioni del ministero ritirare il testo o riscriverlo in modo radicale.
In molti lamentano come la bozza sia un testo poco curato, che indichi un ritorno al passato, e che soprattutto nella parte dell’italiano, del latino (che dovrebbe essere inserito nel curricolo della secondaria di primo grado) e della storia riveli anche degli accenti autoritari, paternalisti e di precettismo didattico. Ecco un passaggio chiave: “Grazie al lungo allenamento all’autogoverno garantito negli anni di frequenza scolastica, e in virtù delle ‘regole’ (regole di comportamento, ma anche regole tratte dai contenuti e dai metodi delle stesse discipline, come, p.e., le regole di grammatica) l’allievo interiorizza il senso del limite e un’etica del rispetto verso il prossimo”.
Ma questo genere di concezioni per cui il latino insegni il ragionamento o la grammatica insegni la cultura della regola sono considerate da molti dei pregiudizi rischiosi, oltre che idee senza fondamento dal punto di vista scientifico.
La sezione dedicata alla storia, redatta sotto il coordinamento dello storico e collaboratore del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia, è stata letta più come un manifesto che come un testo di orientamento pedagogico. A partire dall’inizio, dove si può leggere una frase molto assertiva: “Solo l’Occidente conosce la Storia”, seguita da una citazione di Marc Bloch (“I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. (…) è nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del Peccato e della Redenzione”) che molti storici e professori di storia hanno considerato decontestualizzata e strumentalizzata.
Scorrendo si trovano esplicitati gli obiettivi di quella che sembra una dottrina nazionalista e antiglobalista: “Nella scuola primaria sembra poi necessario che l’insegnamento abbia al centro la dimensione nazionale italiana, sia al fine di far maturare nell’alunno la consapevolezza della propria identità di persona e di cittadino”. E ancora: “Anziché mirare all’obiettivo, del tutto irrealistico, di formare ragazzi (o perfino bambini!) capaci di leggere e interpretare le fonti, per poi valutarle criticamente magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche, è consigliabile percorrere una via diversa. E cioè un insegnamento/apprendimento della storia che metta al centro la sua dimensione narrativa in quanto racconto delle vicende umane nel tempo. (…) Non è pertanto necessario che i discenti imparino tutto ciò che di più o meno notevole è avvenuto in ciascuna epoca, bensì che apprendano quanto è stato davvero determinante, in primo luogo nella vicenda storica italiana”.
Queste indicazioni sembrano cercare, anche all’interno della comunità accademica, un confronto più simile a una contrapposizione (qui si può vedere come proprio sulla didattica della storia il dibattito tra i redattori della bozza e i rappresentanti delle associazioni si stia polarizzando).
La buona notizia è che queste nuove indicazioni nazionali hanno creato un dibattito ricco e davvero plurale su molte questioni importanti per la scuola: dalla riflessione sulla valutazione a quella sulla didattica della matematica. In poche settimane sono stati pensati per Erickson e Gessetti colorati due libri critici che raccolgono interventi divisi per temi e discipline. Non bisogna però ridimensionare il fatto che questo dibattito sia polarizzato, proprio perché il testo proposto dal ministero mostra, sotto molti aspetti, più che una discontinuità un’avversità di tipo politico, storico, ideologico.
Qual è l’avversario? Una tradizione scolastica, centrale e determinante nella scuola italiana, che ha legato l’attivismo pedagogico al riformismo socialista e comunista. Una tradizione pedagogica che è nata dalle intuizioni pioneristiche di Bruno Ciari e don Lorenzo Milani, Gianni Rodari e Mario Lodi, Margherita Zoebeli e Tullio De Mauro, e che è stata portata avanti da migliaia di professori, moltissimi maestri e maestre elementari, che hanno sperimentato nelle loro classi un’idea diversa di scuola, più legata a una concezione pedagogica antiautoritaria, laboratoriale, partecipata, in nome di un’idea di società più ugualitaria, democratica e plurale.
Le nuove indicazioni nazionali sembrano volerla cancellare con un tratto di penna, ma da almeno mezzo secolo questa tradizione ha prodotto proposte, pratiche e metodi didattici, sostenuti da risultati innovativi per la ricerca scientifica, sia nella scuola sia nell’università. Il rischio concreto è che quella del ministero, oltre a essere una battaglia sbagliata, diventi anche un’estenuante battaglia persa.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it