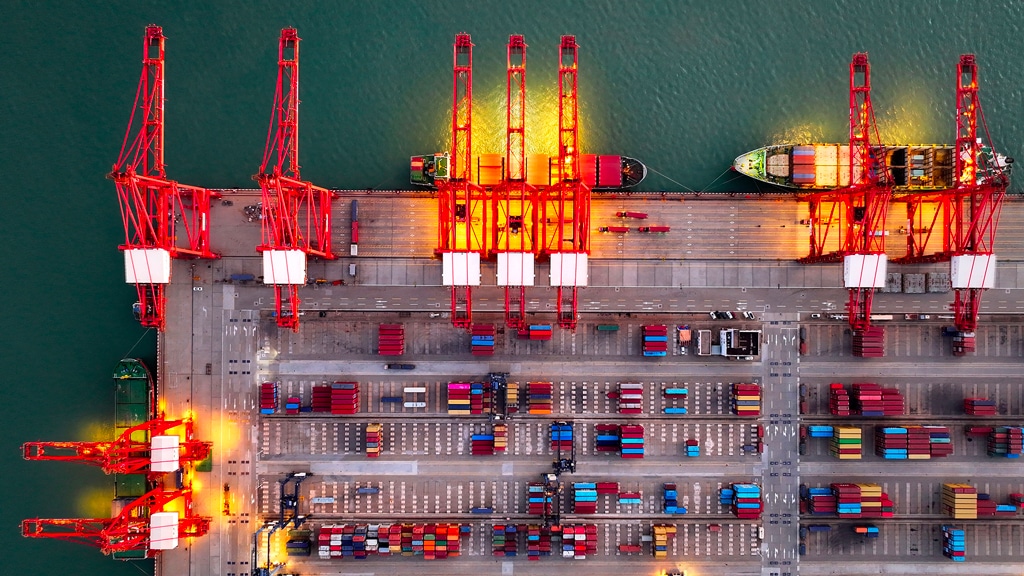La repressione in corso a Minneapolis andrebbe analizzata come la fase finale di un processo di militarizzazione della polizia cominciato molti anni fa. Si tende infatti a dimenticare che molte delle tattiche e dei comportamenti che ci scandalizzano e ci sembrano eccezionali hanno radici precise nelle politiche di sicurezza adottate dopo l’11 settembre 2001.
Per anni alcuni giornalisti hanno raccontato l’evoluzione delle forze dell’ordine statunitensi – l’uso di armi e mezzi da guerra, il perimetro sempre più ampio della loro capacità d’intervento, la crescente impunità – non solo per denunciare gli effetti nell’immediato sulle persone prese di mira ma anche per avvertire di potenziali scenari futuri, in cui un governo con tendenze autoritarie avrebbe potuto usare un apparato del genere per reprimere il dissenso interno.
Uno di quei giornalisti è Radley Balko, che in Rise of the warrior cop (L’ascesa del poliziotto guerriero, 2013) ha ricostruito il processo che ha portato la polizia americana a somigliare sempre di più, per mezzi e mentalità, a un esercito domestico.
La prima svolta ci fu con la cosiddetta guerra alla droga, una serie di politiche di contrasto al traffico di stupefacenti avviata a partire dagli anni settanta e intensificata negli anni ottanta. La crescente diffusione di sostanze e dipendenze negli Stati Uniti fu trattata non come un problema sanitario o sociale ma come una guerra interna: più arresti, pene più dure, carcerazione di massa e un’enorme espansione dei poteri e delle risorse per polizie e forze federali. Le autorità cominciarono a usare strumenti tipici dell’emergenza – raid, irruzioni, task force, unità speciali, equipaggiamento militare, meno supervisione e controllo sugli abusi – per colpire non solo grandi traffici ma anche reati minori e consumo, con effetti profondi su comunità povere e minoranze.
La militarizzazione ha preso ulteriormente piede negli anni ottanta e novanta, il periodo della retorica legge e ordine, e ha subìto un’accelerazione decisiva dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Le esigenze di sicurezza nazionale hanno normalizzato la cultura dell’emergenza permanente e alzato l’asticella di quello che si poteva fare a livello di ordine pubblico. Balko ha spiegato che il vero salto non è stato solo materiale (armi, mezzi) ma anche culturale: il poliziotto si è trasformato in “guerriero”, vedendo sempre più spesso il territorio come ostile e il cittadino come potenziale nemico, cosa che inevitabilmente ha fatto crescere errori, abusi e vittime collaterali.
Tutto questo succedeva mentre i soldati statunitensi combattevano all’estero in guerre avviate da Washington nel quadro della guerra al terrore, presentate come operazioni di sicurezza e, almeno nella retorica ufficiale, come interventi per esportare stabilità e democrazia in “stati falliti”.
Sul New York Times David Wallace-Wells ha citato la teoria dell’imperial boomerang, l’effetto boomerang imperiale: la violenza sperimentata e normalizzata all’estero torna indietro e si applica in patria, erodendo libertà e diritti. Un po’ alla volta equipaggiamenti militari comprati per l’Iraq e l’Afghanistan sono finiti alle forze dell’ordine americane, mentre la logica paranoica della forever war ha inasprito sorveglianza e repressione e portato a leggere ogni conflitto come scontro esistenziale.
Secondo un processo che conosciamo bene anche in Europa, il primo campo di applicazione di questa nuova mentalità iperaggressiva è stato quello dell’immigrazione. L’amministrazione Bush ha imposto di raddoppiare gli organici della polizia di frontiera, e la corsa alle assunzioni ha portato nei vari dipartimenti molti reduci dell’Iraq e dell’Afghanistan: persone formate a vedere il territorio come zona ostile, a individuare minacce, a muoversi in assetto militare.
Nel frattempo si verificava uno slittamento anche a livello legislativo. In entrambi i partiti le voci più moderate, quelle che da anni si spendevano per proporre e approvare una riforma sensata dell’immigrazione, sono state schiacciate da una retorica in cui c’era spazio quasi solo per la repressione. Come ha spiegato Wallace-Wells, “molte delle attività attuali dell’Immigration and customs enforcement (Ice) si svolgono dentro i confini inquietantemente ampi del diritto statunitense sull’immigrazione. Anche la forma di quel diritto, e l’intero apparato che è cresciuto per farlo rispettare, sono il risultato della guerra al terrore. L’Ice è stata creata in tempi relativamente recenti, come parte dell’iniziativa legislativa del 2002 che istituì anche il dipartimento per la sicurezza interna, in base alla logica secondo cui, data la minaccia terroristica imminente, l’applicazione delle leggi sull’immigrazione avrebbe dovuto diventare più ampia e aggressiva”.
Negli ultimi mesi abbiamo visto Trump prendere il controllo di questo sistema e usarlo non solo contro gli immigrati ma contro quelli che considera “nemici interni”. Di fatto ha spostato la frontiera dal sud all’interno del paese, nelle città a guida democratica.
Si è capito presto che l’enorme potenziamento dell’Ice non serviva solo a raggiungere l’obiettivo (probabilmente impossibile) di espellere un milione di persone all’anno, ma anche e soprattutto a creare una forza separata dal controllo democratico e sempre più fedele al presidente. In questo senso l’Ice – nata nel 2003 per far rispettare le leggi sull’immigrazione e contrastare alcune forme di criminalità internazionale, soprattutto legate al terrorismo – è l’evoluzione estrema del warrior cop: non più polizia militarizzata per combattere un’emergenza, ma un apparato paramilitare usato per produrre paura nelle comunità considerate ostili.
I fatti di questi giorni a Minneapolis sembrano condensare tutto questo processo nella figura di Jonathan Ross, veterano dell’Iraq che il 7 gennaio ha ucciso Renee Nicole Good, una donna disarmata. Ross e i suoi colleghi dello Special response team, un’unità dell’Ice addestrata per operazioni ad alto rischio, erano stati mandati in città per rispondere a uno scandalo di frodi nei servizi sociali che ha coinvolto soprattutto la comunità di origine somala. Una vicenda che nell’ecosistema della destra era diventata il pretesto ideale per raccontare le “città blu” (governate dal Partito democratico) come territori allo sbando e per riattivare l’islamofobia del dopo 11 settembre, trasformando una minoranza in un simbolo di minaccia interna.
Wallace-Wells ha scritto: “L’intervento a Minneapolis equivaleva a spedire l’esercito a ripulire uno stato fallito, con ‘blu’ che ormai è, di fatto, un sinonimo di ‘fallito’ per l’amministrazione Trump. E gli immigrati accusati di aver messo in atto lo schema di frode erano somali – molti dei quali ex residenti dello stato fallito per eccellenza, un paese musulmano in Africa che è stato colpito da più di 130 attacchi statunitensi da quando Trump si è insediato. Proprio il giorno in cui Good è stata uccisa, il conduttore di Fox News Jesse Watters ha suggerito al vicepresidente JD Vance che i democratici in Minnesota hanno ‘un piccolo problema somalo’. Il vicepresidente ha risposto ridendo: ‘L’America ha un problema somalo’”.
Questo testo è tratto dalla newsletter Americana.
|
Iscriviti a Americana |
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Americana
|
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it