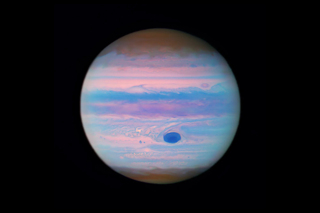Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2009 nel numero 809 di Internazionale.
Purtroppo, e con mio grande sgomento, sto divorziando. Il mio matrimonio è durato vent’anni. Mio marito è un brav’uomo, anche se effettivamente era in viaggio per lavoro venti settimane all’anno. Ma a 47 anni la mia dedizione alla monogamia si è dissolta come neve al sole. Sono stata la prima a sorprendermi: in genere gli uomini non mi divertono molto. Avevo una vita perfettamente organizzata e pensavo che avrei lasciato questa terra portandomi dietro un calice di merlot e un buon libro, come faccio la sera quando vado a dormire.
Travolta dagli eventi, ho vuotato il sacco a mio marito. Abbiamo pianto, ci siamo strappati i capelli, abbiamo pensato con tristezza al futuro delle nostre bambine. Ma alla fine, quando il terapeuta familiare mi ha messa di fronte alla scelta definitiva ho capito che… no. Anche se mi spezzava il cuore, non riuscivo proprio a sostituire l’immagine romantica della mia avventura con l’immagine di mio marito. Sarebbe stato l’unico modo per ricucire lo strappo che aveva lacerato il tessuto domestico del nostro nucleo familiare, per usare il gergo della moderna terapia di coppia. Se vogliamo usare il linguaggio dei settimanali femminili, non avevo “la forza di lavorare” a innamorarmi di nuovo del mio matrimonio. Un rapporto di coppia riuscito, invece, richiede lavoro, come ha scritto Laura Kipnis in Contro l’amore (e come tutti sanno).
Questo non significa che io sia contraria al lavoro. Anzi, proprio nel corso della terapia familiare è venuta fuori l’enorme mole di compiti che io, come tante madri che lavorano e dividono con il marito l’impegno di crescere i figli, svolgo da anni.
So andare a prendere le bambine a scuola, preparare la cena, baciarle sul naso e raccontargli le favole; so portarle dal medico e dal dentista; so guadagnare la mia metà del reddito familiare; so pagare i conti; so trovare un rifinanziamento del mutuo sulla casa al miglior tasso d’interesse; so accompagnare mio marito all’aeroporto in macchina; in sua assenza so smistare la sua posta; so farmi trovare in casa per accogliere l’idraulico giovedì tra le 9 e le 15; so tenere viva la conversazione a tavola con qualsiasi membro della famiglia; so manifestare interesse per come è andata la giornata di tutti; so fare le coccole a bambini, adulti, cani e gatti; so svuotare la cassetta del gatto; so mescolare il cibo umido con quello secco. Insomma, so gestire la mia vita professionale, la vita dei figli, un appartamento in comproprietà e perfino una relazione platonica uomo-donna.
Quello che proprio non mi riesce è far rivivere l’antico sogno di tutte le spose. Non ci riesco neanche con le “seratine intime” una volta a settimana, quando la luce soffusa delle candele dissimula il disordine della casa, si accantonano i discorsi da bambini e si tira fuori la lingerie di seta, così io e lui possiamo guardarci negli occhi e sentire l’antica scintilla che torna a scoccare. Mi spiego? Considerato l’impressionante elenco di cose che mi ritrovo a dover fare avendo un lavoro e due figlie, proprio non ce la faccio ad accollarmi l’ulteriore progetto di ridare vita alla nostra storia d’amore.
Dopo la doccia fredda di questo fallimento ho intrapreso un viaggio di lettura, riflessione e ascolto di quello che sta succedendo in altre famiglie americane. E strada facendo, di fronte a tanta infelicità repressa, ho cominciato a domandarmi: perché insistiamo a volerci sposare? Il matrimonio aveva un senso per le famiglie contadine dell’ottocento, che per lavorare la terra avevano bisogno di due coniugi, dei nonni e un esercito di figli. Ma adesso che esistono i colletti bianchi e le lavatrici, e che la nostra speranza di vita è schizzata da 47 a 77 anni, l’idea del matrimonio che dura una vita non sarà un po’ obsoleta?
Secondo Andrew J. Cherlin, autore di The marriage-go-round, gli americani sono molto più ingenui degli europei quando si parla di matrimonio. Da un sondaggio condotto nel 2000 è emerso che solo il 10 per cento dei cittadini statunitensi pensa che il matrimonio sia un’istituzione “sorpassata”, rispetto al 36 per cento dei francesi. Ma al tempo stesso negli Stati Uniti c’è il tasso di divorzio più alto di tutto l’emisfero occidentale.
Per Cherlin il motivo di questo paradosso è che gli americani coltivano due valori insieme: la cultura del matrimonio e la cultura dell’individualismo. Tre cittadini su quattro sono convinti che il matrimonio debba durare tutta la vita, ma solo uno su quattro pensa che si debba restare insieme per il bene dei figli anche se il matrimonio è infelice. Forse la “cultura del divorzio” è semplicemente l’altra faccia della “cultura del matrimonio”, visto che negli Stati Uniti sia il tasso di matrimoni sia il tasso di divorzi sono tra i più alti del mondo.
Cherlin è preoccupato soprattutto per le conseguenze negative di questa frenetica giostra matrimoniale sui nostri figli. Perché è vero che, secondo le statistiche, vivere con due genitori biologici è la cosa migliore per i figli, ma anche una famiglia monoparentale va bene. I guai, spiega Cherlin, cominciano quando entrambi i genitori separati cominciano ad avere nuove relazioni e i figli sono costretti a stringere legami con figure sempre nuove, oppure devono contendersi l’attenzione del genitore. Questi ragazzi sono i più esposti alle sofferenze: lo dimostrano alcuni indicatori come il profitto e la frequenza scolastica e le gravidanze nelle giovanissime.
Quindi, dice Cherlin, invece di predicare il matrimonio, dovremmo insegnare alle persone a preoccuparsi della stabilità domestica per i figli. Ma il miglior modo per garantirla è davvero il matrimonio? A quanto pare no. O almeno, non come lo pratichiamo negli Stati Uniti.
A casa di Rachel
Rachel è una delle donne con cui vado regolarmente a cena adesso che sono una divorziata che è riuscita ad abituarsi all’affidamento congiunto dei figli. Erano quasi dieci anni che non cenavo una volta alla settimana con degli adulti. La mia tipica seratina domestica cominciava alle cinque del pomeriggio con un cheeseburger da McDonald’s e proseguiva in una lenta dissoluzione tra piatti da lavare e cartoni animati. Già, perché un altro dei miei fallimenti coniugali è che non sono mai stata capace di prendere una tata fissa.
Io e mio marito lavoravamo entrambi a tempo pieno, ma io, facendo la scrittrice e lavorando a casa, ero in una posizione ambivalente: se qualcuno mi aiutava nelle faccende domestiche, dove andava a finire il mio ruolo di madre? Per giunta ero segretamente rosa dal dubbio che avere dei domestici volesse dire sfruttarli: Barbara Ehrenreich ha detto che non si farà mai pulire il gabinetto da un’altra donna. Queste erano le barriere postfemministe che s’innalzavano nella mia mente alle due di notte, mentre mi contorcevo nel letto circondata da gatti e bambini.
Adesso immaginate di salire in macchina con me e accompagnarmi a casa di Rachel per il nostro nuovo hobby sociale, la cenetta tra donne. Mi rendo conto che posso sembrarvi poco credibile come interprete del matrimonio moderno. Ma voglio rimangiarmi tutto per un momento e smettere di essere ostile al matrimonio, un’istituzione che almeno per certe persone funziona perfettamente.
Di sicuro ha funzionato per Judith S. Wallerstein, sposata per 48 anni e coautrice, con Sandra Blakeslee, di The good marriage: how and why love lasts. Dopo aver studiato a fondo l’esperienza di cinquanta coppie felicemente sposate, le autrici hanno individuato quattro tipologie di matrimonio che ne assicurano il successo sul lungo periodo.
Il matrimonio romantico è alimentato dalla scintilla dell’amore che non muore mai (pensate a quegli affettuosi ultraottantenni che si tengono per mano in una casa di riposo). Nel matrimonio salvataggio, invece, i coniugi si adattano l’uno all’altro come pezzi perduti di un puzzle e si curano a vicenda i traumi dell’infanzia (un sottotipo è quello delle coppie legate dalla comune dedizione ad abitudini malsane, come i genitori ultrasettantenni di un mio amico che partono in crociera ogni due mesi con dei bottiglioni di collutorio riempiti di gin). Il matrimonio tradizionale funziona a meraviglia perché l’uomo lavora mentre la donna manda avanti la casa, in una divisione del lavoro di pregevole chiarezza. Infine, la tipologia di matrimonio più diffusa oggi: il matrimonio per compagnia, in cui marito e moglie hanno ciascuno la sua carriera e si occupano entrambi dei figli e della casa in base a norme concordate e non di genere.
Trent’anni fa, nel loro best seller Open marriage, Nena e George O’Neill avanzarono l’ipotesi che il moderno assetto di coppia potesse addirittura prevedere la libertà sessuale. Ma come tutti sappiamo, il matrimonio sessualmente aperto è uscito di moda insieme alle lampade di lava degli anni settanta, semplicemente perché un sacco di gente lo trova insopportabile. Vediamo allora come si è evoluto il matrimonio. Che tipo di partnership sono quelle del ventunesimo secolo? Entrate con me, finalmente, nella casa della mia amica Rachel.
La cucina del marito perfetto
Immaginate una spettacolare casa tradizionale a due piani in legno (caminetto rivestito in piastrelle Batchelder, travi a vista color caramello, lumi Tiffany su tavolini stile coloniale) annidata in quella storica enclave di Pasadena che si chiama Bungalow Heaven.
Rachel, 49 anni, avvocato ambientalista, è sposata con Ian, 48 anni, montatore di documentari. Hanno due maschietti di nove e undici anni. Questa sera Ian, padre modello, ha portato i bambini al campo scuola di calcio (o a lezione di batteria, è difficile tenere il conto dell’impressionante numero di attività che svolgono). Rachel è in cucina che prepara la cena per noi tre: Ellen, scrittrice sposata con figli, Renata, violinista single di 45 anni, flessuosa e in cerca di preda, e me. Più precisamente, Rachel sta riscaldando la cena. Il piatto forte è una cosa meravigliosamente delicata e complessa, una specie di risotto ai porcini aromatizzato allo zafferano, che Ian ha preparato nel weekend e ha surgelato per noi dentro un Tupperware ordinatamente etichettato. Sì, perché Ian è abbonato a Cook’s Illustrated online e a un’altra raffica di riviste per gastronomi professionisti, ed è sempre lì a perfezionare una polenta o una bouillabaisse.
Cercate di immaginarvelo in calzoncini da ciclista (la bici è la sua passione), che si aggira in mezzo a un dedalo di pentole dove soffrigge pian piano chissà cosa. Secondo Rachel l’amore di Ian per la gastronomia sperimentale è uno dei motivi per cui i suoi figli ingurgitano qualsiasi cosa, dal curry agli spaghetti di soia (le mie bambine mangiano volentieri solo da McDonald’s, ma l’analista mi ha detto di piantarla di battermi il petto per queste quisquilie).
Visto il clima di idillio domestico che si respira a casa di Rachel, ho esitato a lungo prima di darle la notizia della mia separazione. E infatti la sua prima reazione è stata di incredulità mista a orrore: “Ma… e le bambine?”. Le ho spiegato che avendo due genitori che vivevano su binari paralleli da quando erano nate, le mie figlie, almeno in apparenza, non hanno fatto una piega. Si capisce: oltre alle continue tournée di mio marito musicista, in certi anni ho dovuto sciropparmi duecento serate in cui lui si esibiva a teatro mentre io mi trascinavo le bimbe piccole nelle camere d’albergo. Per giunta, quando i loro cuginetti, di due, cinque e sei anni, hanno improvvisamente perso la mamma, per far fronte all’emergenza abbiamo deciso di trasferirci a casa di mio fratello per due anni.
Le mie figlie erano più abituate a cenare insieme a una famiglia allargata che con un padre e una madre. Oggi che hanno raggiunto l’età delle elementari sembrano relativamente contente se possono avere la loro casa, i loro letti e la loro scuola, con mamma e papà che fanno avanti e indietro come al solito. Le passioni quotidiane continuano a essere le figurine dei Pokémon e i nuovi pupazzi da aggiungere alla collezione.
In realtà è Rachel il papà tradizionale, ma nessuno le porta la pipa e le pantofole alle sei
Ma stasera è la nostra seconda cena di sole donne da quando ho fatto il mio annuncio, così Rachel ha lasciato da parte il bordeaux da intenditore di Ian e ci sta preparando dei martini dal tasso alcolico preoccupante. Sporgendosi oltre il bancone del bar, fa roteare il contenuto del bicchiere e con la sua voce roca sgancia la bomba: “Sai che ti dico? Da quando ne abbiamo parlato ho cominciato anch’io a pensare al divorzio”. “No!”, esclamiamo all’unisono Ellen, Renata e io. “Non puoi fare una cosa del genere!”, strilla Renata, “Ian è un padre perfetto! Un marito perfetto! Ma insomma, guarda questa cucina!”.
È vero: la cucina è l’esempio lampante del contributo di Ian alla loro unione. L’ha ristrutturata basandosi sulla cucina di una vecchia fattoria che avevano visto insieme durante un viaggio in Toscana. Ha curato tutti i dettagli. Ha costruito i pensili con le sue mani. Ha assegnato un posto a ognuno dei suoi utensili speciali: le pentole di rame appese in bell’ordine, lo spremiaglio, il colapasta, il rigalimone, la caffettiera francese.
“Ian non vuole più fare sesso con me”, continua Rachel con voce ferma. “Sono due anni che non mi tocca. Dice che sono ingrassata”. Si alza il coro di proteste delle amiche, ma lei prosegue: “Per giunta dice che sono una cattiva madre. Che sono sciatta e disattenta”. Rachel elenca le sue colpe: ha dato al cane la medicina sbagliata (un errore che Ian non farebbe mai), ha dimenticato di togliere la glassa dalla casseruola e si è fatta sfuggire l’ultimo momento buono per prenotare i voli per Seattle per tutta la famiglia (Ian segue minuto per minuto le offerte di Expedia, segnalate da una tintinnante suoneria).
Rachel si vede come una madre fallita, è depressa e schiacciata da troppo lavoro. Non può rinunciare al suo impiego da 120mila dollari all’anno anche per motivi previdenziali, visto che Ian fa il freelance. Di notte, vogliosa e insonne, si aggira per la sua raffinatissima cucina trangugiando barrette di gelato. È lei che porta a casa il grosso del reddito familiare. In realtà, è Rachel il papà tradizionale: ma anziché vedersi porgere la pipa e le pantofole alle sei di sera, è arenata in un progetto di ristrutturazione a sesso zero con un mammo competitivo affetto da disturbo passivo-aggressivo.
Rachel è arrivata al punto di chiedere a bruciapelo a Ian: “Vuoi divorziare?”. E lui ha risposto che assolutamente no, che devono dar prova di disciplina e lavorare sul loro matrimonio (ancora lavoro!), perché ogni turbamento della quiete domestica rischia di ripercuotersi sui ragazzi, che in questo momento vivono un periodo difficile perché la scuola gli impone un carico straordinario di attività extracurricolari e di test trimestrali.
Monogamia seriale
“Sapete, è strano”, dice Ellen dopo un attimo di sgomento generale. Ellen è sposata da 18 anni e anche lei, notoriamente, non fa sesso. Insieme a Ron è passata dai vent’anni incandescenti ai trenta della nascita dei figli, e ora che è arrivata ai quaranta c’è il nulla. A suo tempo, Ellen scelse Ron perché era stanca dei ragazzacci e lui era il marito ideale con cui metter su famiglia. Non sapeva che, grazie a Mister Pantofolaio, passati i 38 anni non avrebbe mai più fatto sesso regolarmente con un uomo.
“Quando è stato inventato”, prosegue Ellen, “il matrimonio era considerato una specie di sindacato per la donna, una sorta di tutela contro il maschio sessualmente nomade. Ma questo maschio sessualmente nomade dov’è finito?”. Ai tempi dei nostri genitori, a 45 anni gli uomini si facevano la Porsche rossa e piantavano la famiglia per la segretaria giovane e sexy. “Ron al massimo scende nel suo studio e accende il computer”, spiega Ellen. “Ha messo un sito porno tra i preferiti”. “Ian ci ha messo il sito di Cook’s Illustrated”, le fa eco Rachel, “e quello del club maschile degli amanti del basilico”.
Di noi quattro, quella che è più su di giri è Renata. Continua freneticamente a digitare sms. Noi stiamo lì a immaginare la fila di uomini adoranti dietro di lei. “Il mio problema è che sono un tipo a dopamina!”, sbotta Renata agitando le mani in aria. “Capito? Dopamina!”.
“Helen Fisher!”, esclama allora Ellen puntandole un dito contro. Helen Fisher è un’antropologa, una vera e propria figura di culto per il movimento femminista americano. Da anni sostiene che l’innamoramento e il disamoramento sono fenomeni che rientrano a pieno titolo nella nostra evoluzione biologica, e che gli esseri umani non sono programmati per la monogamia a vita, ma per la monogamia seriale. Per la precisione, in cicli di quattro anni, cioè circa il tempo che occorre per svezzare un bambino e traghettarlo sano e salvo al nido.
Nel suo Why him? Why her?, Fisher spiega quali sono le forze ormonali che scatenano l’attrazione romantica verso una persona piuttosto che un’altra: un fenomeno documentato anche nel mondo animale. La tesi è che ognuno di noi, mentre è ancora nell’utero materno, assorbe diversi livelli di ormoni che da grandi ci spingeranno in braccio a uno di questi quattro tipi fondamentali di personalità.
L’esploratore: personalità avventurosa e creativa, mossa da una robusta libido, che agisce sull’impulso del momento. Agente neurochimico corrispondente: dopamina.
Il costruttore: personalità molto più tranquilla, che ha “valori tradizionali”. È anche il tipo che “preferisce gli amici fedeli agli amici interessanti”: abitudinario, attribuisce grande priorità alla cura dei suoi oggetti personali. Neurotrasmettitore corrispondente: serotonina.
Il dirigista: personalità incline al pensiero analitico e logico. È il tipo che non disdegna una discussione accesa e si dedica con tenacia a scoprire tutte le funzioni della sua nuova macchina fotografica o del suo nuovo computer. Ormone corrispondente: testosterone.
Il negoziatore: personalità incline alla comunicazione “a pelle”, incline a immaginare che possano capitargli cose meravigliose, ma anche cose orribili. Ormoni corrispondenti: prima estrogeni e poi ossitocina.
Nel suo libro Fisher analizza dati sulla personalità ricavati dai 39.913 appartenenti alla comunità di Chemistry.com. Il campione è risultato composto per il 26 per cento da personalità del tipo esploratore, per il 28,6 per cento da costruttori, per il 16,3 per cento da dirigisti e per il 29,1 per cento da negoziatori. Osserva inoltre che gli esploratori sono tendenzialmente attratti da altri esploratori e i costruttori da altri costruttori, mentre i dirigisti sono tendenzialmente attratti dai negoziatori e viceversa.
Brandendo il volume della Fisher, Ellen grida: “Ecco perché il mio matrimonio è morto da quindici anni! Sono un’esploratrice sposata a un costruttore!”. La combinazione esploratore-esploratore tende a essere una delle più instabili, mentre Fisher sospetta che “nel mondo, la maggior parte dei matrimoni che durano cinquant’anni è composta da costruttori sposati ad altri costruttori”.
In cerca degli uomini veri
Secondo uno studio della Rutgers University, negli Stati Uniti solo il 38 per cento dei coniugati si definisce felice. Eppure continuiamo a sposarci e a restare sposati per una serie di ottime ragioni. Per esempio perché in caso contrario non potremmo permetterci la proprietà di un immobile. Oppure per competizione con la generazione degli anni sessanta e settanta, quella dei nostri genitori, che in fatto di matrimonio hanno combinato dei bei pasticci. Inoltre, nel frenetico mondo digitale di oggi, il matrimonio stile anni cinquanta è tornato attraente.
Nel suo Generazione ex, Karen Karbo scrive: “Al volgere del millennio, i nostri matrimoni (e secondi e terzi matrimoni) non hanno più quasi niente in comune con le unioni di una volta, quelle in cui l’uomo portava i soldi a casa e la donna serviva i cocktail. Quei matrimoni stabili e tranquilli, che a noi sembravano tanto monotoni e sessisti, sono diventati emblemi di un tempo meno complicato. Quello che solo quindici anni fa ci appariva noioso e opprimente, ora ci sembra un lusso”.
Negli Stati Uniti c’è chi resta sposato perché il matrimonio standard con due genitori è un valore da tramandare ai figli insieme alle scuole private, alle lezioni di taekwondo, ai cibi biologici e alle ricette casalinghe. Altri rimangono sposati perché qual è l’alternativa? Un appartamento solitario con un forno a microonde?
Detto questo, è evidente che le donne sono insoddisfatte: infatti sempre più spesso sono le mogli ad avviare le pratiche per il divorzio. Se il matrimonio è il vecchio mondo e quello che si estende oltre i suoi confini è il nuovo mondo, gli unici abitanti del vecchio sono gli uomini in apparenza equilibrati (che si sentono a loro agio nel loro studio postfemminista, con Cook’s Illustrated e i siti porno). Le donne delle cene fra donne sono le vere creature del nuovo, le vere pioniere. Sono loro che meglio incarnano quello che Tocqueville chiamava l’inquiétude du caractère, il temperamento irrequieto dell’America.
Secondo la rivista EnlightenNext risulta nell’Europa del nord ci sono donne che, piuttosto che con i loro maschi progressisti, preferiscono uscire con i musulmani perché li percepiscono come “uomini più veri”. E si capisce: lavorare, fare le mamme, sbrigare le faccende domestiche, programmare “seratine intime”, solo per sentirsi rimproverare da bisbetiche cuoche in pantaloni, e per giunta vedersi ignorare in camera da letto, è troppo! E ci si mettono anche le riviste femminili, sempre lì a predicarci di riaccendere la scintilla romantica. Avete mai visto una rivista maschile che invita gli uomini a fare altrettanto?
A questo punto, ecco alcune modeste proposte. Dagli studi emerge chiaramente che la cosa migliore per i figli è la stabilità domestica, il non essere costretti a stringere legami con patrigni e matrigne sempre nuovi. Allora perché non accettiamo il matrimonio semplicemente come un accordo per pagare il mutuo a metà?
Come suggeriva Helen Fisher, riaccendere il fuoco romantico per molte di noi è biologicamente innaturale, soprattutto dopo che sono nati i figli. Se le donne in carriera sono sessualmente frustrate, meglio un sistema dove possano avere due uomini: dentro casa, il bravo papà postfemminista che fabbrica i pensili e cucina la bouillabaisse ma le ignora; fuori, l’amichetto con cui spassarsela occasionalmente senza che i figli lo vedano mai. In alternativa, se entrambi i coniugi trovano che la vita è già abbastanza stressante così com’è, si risparmino di correre dietro a sottane e pantaloni. Mariti e mogli di lungo corso sottoscrivano un civile accordo: siamo amici, la sera scaldiamo la camera da letto accendendo ciascuno il suo computer senza darci fastidio. Oltre a garantire l’isolamento dal resto del mondo, un accordo del genere potrebbe rivelarsi anche il modo perfetto per essere lasciati in pace.
Per quanto riguarda i figli, poi, ci sarebbe il sistema tribale, che è perfettamente naturale nell’evoluzione non solo dei primati, ma anche degli umani. I piccoli da uno a cinque anni vengono allevati in un nucleo domestico fatto di madri e loro parenti di sangue femmine, e gli uomini/mariti/amichetti possono venire in casa una o due volte a settimana: a costruire pensili, cucinare la bouillabaisse o offrire servigi sessuali. Ma l’ideale è che, una volta superato lo stadio dell’allattamento e del gattonamento, quei bravi superpapà così materni assumano direttamente la custodia dei figli. Le mamme potranno continuare ossessivamente a lavorare, firmare assegni e dimenticare di dare la pappa al cane. E i papà, se vorranno, potranno cacciare di casa quelle sciattone di madri che lavorano e prendere in mano la gestione domestica con la massima efficienza, anche assumendo, se occorre, personale qualificato.
In fondo, in parte è vero che oggi gli uomini ci vedono più chiaro su quel che serve per crescere i figli nell’era moderna. E poi, tanto per dirne una, non hanno l’ambivalenza e la viscosità emotiva della donna che lavora. In ogni caso, il mio ultimo consiglio è: evitate il matrimonio. Altrimenti anche voi rischiate di provare sulla vostra pelle la sofferenza, l’umiliazione e le difficoltà logistiche (per non parlare delle spese) a cui si va incontro quando un’unione durata a lungo si spezza nell’età critica della vita per colpa di una cosa notoriamente effimera come l’amore.
Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2009 nel numero 809 di Internazionale.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it