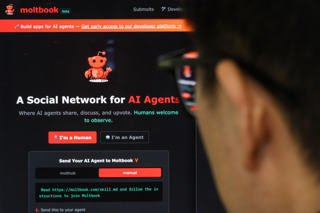La prima volta che andò a vedere un concerto di Bob Dylan era il 6 giugno del 1991. Non solo non aveva mai visto dal vivo l’autore di Blowin’ in the wind, ma non era mai stato a Roma. La sua ignoranza di sedicenne gli impediva perfino di dare un significato a quell’acronimo (Eur) posto in rilievo sul biglietto. Il concerto si sarebbe tenuto al Palaeur. Lui non aveva neanche idea di quanto fosse lontano dalla stazione dei pullman. Aveva viaggiato per tutta la notte, superando il Tavoliere e poi l’Irpinia, sbattuto in fondo a questo veicolo scomodo e puzzolente, consapevole che per guadagnarsi quel disagio (biglietto del pullman più concerto) era stato sufficiente vendere a un appassionato la sua vecchia console Intellivision. Non sapeva neanche lui molto bene perché stava andando tutto solo a quel concerto.
Le sue motivazioni ribollivano nella rabbia e nella confusione. Aveva litigato mortalmente con suo padre a fine maggio e tanto gli era parso sufficiente. Era partito senza dire niente ai genitori. Morissero di preoccupazione. La sua piccola protesta giovanile, riteneva, non poteva trovare migliore occasione in quel cantante. Dylan, che lui non conosceva affatto. Gli unici dischi di Dylan che aveva mai ascoltato – presi a coppia in edicola grazie a una vendita promozionale – erano The freewheelin’ Bob Dylan e The times they are a-changin’. Canzoni come Masters of war, o la stessa The times they are a-changin’ gli erano sembrate perfette, credeva rispecchiassero il suo disagio in un rapporto quasi di uno a uno.
Peccato che sulla vera natura dei nostri disagi non sappiamo mai un bel niente.
Solo a un sedicenne si può perdonare l’illusione di conoscere se stesso. Peccato, dunque, che le sue sicurezze siano state distrutte nel giro di dodici ore.
Un’idea sbagliata di Dylan
Il primo errore fu ascoltare nel walkman, durante il viaggio in pullman, l’audiocassetta che un amico (un altro amico, non l’amante delle console) gli aveva regalato come viatico soltanto il giorno prima. Sono state scritte centinaia di pagine su quel colpo di rullante iniziale, non potrò dire meglio ciò che altri hanno scritto in modo egregio. Sta di fatto che i primi dieci secondi di Like a rolling stone furono sufficienti a fargli capire che di Dylan non aveva capito proprio niente. Su Queen Jane approximately ebbe addirittura la sensazione di sperimentare cosa significasse fare l’amore con una ragazza, perderla di vista, ricevere da lei una lunga lettera molti anni dopo. La lettera era gonfia di rimpianto. Ma una ragazza, all’epoca, lui non l’aveva mai neanche baciata.
Ecco dunque, pensò, che stava andando a vedere un cantante molto diverso da quello la cui immagine si era costruito con pazienza nei mesi precedenti. Impiegò le ultime ore del viaggio in pullman per sostituire dentro di sé la vecchia idea di Dylan con quella nuova.
Ovviamente anche questo si dimostrò un errore.
Quando arrivò al Palaeur subì ciò che nella sua vita adulta avrebbe purtroppo imparato a chiamare “shock culturale”. Che brutta espressione. Forse sarebbe più corretto parlare di “sauna finlandese”. La sensazione fu quella di restare alcuni minuti chiusi in una stanza a ottanta gradi centigradi e poi essere scaraventati nella neve. Prima suonò questo Van Morrison, che lui non sapeva chi fosse. Poi arrivò il turno dell’autore di Masters of war che in realtà era l’autore di Queen Jane approximately. In realtà non era neanche quello. Lo vide. Applaudì. Vide che su di lui si accendevano e si spegnevano le luci colorate.
Al terzo pezzo arrivò alla conclusione che quello lì non era Bob Dylan. Cioè, era ovvio che fosse Dylan, eppure non era lui
Ascoltò con curiosità il primo pezzo. Seguì con difficoltà crescente il secondo pezzo. Al terzo arrivò alla conclusione che quello lì non era Bob Dylan. Cioè, era ovvio che fosse Dylan, eppure non era lui. Le canzoni erano quelle ma erano diverse. La faccia del cantante era come se l’era immaginata (cercando di invecchiarla rispetto alle foto di copertina) e tuttavia completamente un’altra faccia. La voce non ne parliamo. Aveva, come abbiamo detto, solo sedici anni. Troppo giovane per sospettare che siamo noi e non siamo noi per tutta la durata della vita.
Al quinto o sesto pezzo, in preda a una sorta di terrore infantile, fu attraversato dalla più umiliante delle sensazioni. Voleva tornare a casa. Voleva far pace con suo padre, farsi abbracciare da sua madre. Sua madre e suo padre, le persone che meno al mondo avevano informazioni precise sulla propria stessa identità.
La terza volta che vide un concerto di Bob Dylan era il 5 luglio del 1996. Il concerto si sarebbe tenuto a Ferrara, in piazza del Municipio. Lui ci arrivò su una Renault stipata di amici. Dentro, c’era anche la sua ragazza di allora. Non credeva di sapere tutto della vita, ma perlomeno si era convinto di aver imboccato la strada giusta. La via maestra dell’esperienza e della vertigine. Non solo conosceva meglio la discografia di Dylan, ma molta storia del rock non gli era ignota. Amava gli Ozric Tentacles e anche i Jane’s Addiction. Aveva dormito molte volte per strada. Adesso condivideva un bilocale con due tipacci che si svegliavano alle tre del pomeriggio e potevano trascorrere ore a cercare di convincerti che Master of puppets era il più grande album di tutti i tempi. “Master of che?”, chiedevi tu. “I Metallica, stronzo”, rispondevano loro.
Diffidava delle droghe pesanti (alcuni suoi amici erano o erano stati degli eroinomani), ma riteneva che tutta quella faccenda sulle porte della percezione fosse sacrosanta. Dopo un viaggio di psilocybe cubensis con il suo miglior amico e la sua migliore amica, aveva avuto la dimostrazione pratica che in uno stato non alterato di coscienza utilizziamo solo il 25 per cento del nostro cervello, e che i restanti tre quarti (se stimolati nel modo giusto) sono consacrati all’amore e alla pace universale.
Questa storia della sperimentazione a tutti i costi gli aveva creato comunque qualche guaio. Complice Henri-Pierre Roché (la lettura di Jules e Jim dell’anno prima) aveva voluto provare l’ebbrezza di condividere la sua ragazza con un altro. Tutti e tre d’accordo. Era finita molto male. E adesso, con la sua ragazza che andava a vedere insieme a lui il concerto di Bob Dylan a Ferrara, stava cercando faticosamente di recuperare. O forse era lei, che stava cercando di recuperare qualcosa con lui.
Dylan era obliquo. Ed era imprendibile. Si lanciava a capofitto in una direzione, e te lo ritrovavi già da un’altra
A ogni modo il concerto, perlomeno all’inizio, non gli diede grandi sorprese. Brani come Lay lady lay, All along the watchtower, Just like a woman non avevano per lui grandi misteri. Dylan era obliquo. E Dylan era imprendibile. Si lanciava a capofitto in una direzione, e te lo ritrovavi già da un’altra. “Roba da fisica quantistica”, si ritrovò a pensare subito dopo una sessione di salvia divinorum mentre lo stereo diffondeva Vision of Johanna.
E tuttavia anche inseguire il mito di una vita stregolata può diventare un rifugio molto comodo.
Così, a Ferrara, subito dopo Just like a woman, arrivò il turno di Watching the river flow. La quale Watching the river flow, se pure non è proprio l’archetipo del blues, ha un incedere sufficientemente blues da poterti trascinare, sempre che tu lo voglia, sulle rive del Mississippi, e magari (sempre che la tua immaginazione sia abbastanza prensile) dalle parti del delta del Mississippi. Il problema è che il delta del Mississippi è insieme il triangolo delle Bermuda e lo specchio di Alice.
È un posto talmente magnetico, nel suo essere gravido di tradizione, da farti salpare le vele (pur rimanendo per esempio a Ferrara, in piazza del Municipio) verso un viaggio molto più intenso, commovente, doloroso, magico di quello offerto da qualunque droga. Se ti concentri, e poi smetti di concentrarti, potresti magari sentire dentro di te il fantasma di Robert Johnson. Colui che forse inventò il blues. L’uomo che a un crocicchio incontrò il diavolo e gli vendette l’anima ricevendone in cambio la magia nelle dita alle prese con una chitarra. Non esistono strade maestre. Neanche quella della vertigine lo è. Siamo sempre davanti a un crocicchio. C’è sempre il diavolo che sventola un contratto.
La decima, o forse trentesima, o forse quindicesima, o forse novantanovesima volta che vide suonare Bob Dylan, era il 16 luglio del 2006. Un posto qualunque in Italia. Erano successe molte cose nella sua vita, nel frattempo. Per esempio si era sposato. E poi aveva divorziato. Per esempio aveva perso il lavoro. E poi ne aveva trovato un altro. Aveva incontrato un’altra ragazza, e magari l’avrebbe sposata. Per tutta la durata del concerto, gli sembrò di vedere solo il cielo, il cielo sopra Duluth, un cielo rosso ruggine, magnetico, carico di bauxite. Quel cielo era il cielo sopra ogni città, vale a dire su nessuna. Gli sembrò di non essere più niente. Polvere alla polvere. In fondo lui chi era? Come scrisse uno scrittore italiano che amava molto, non era forse “come tutti quelli che erano spariti prima di lui e come tutti sognava di sognare una casa dove tornare”?
La citazione finale è tratta da Lo spazio sfinito di Tommaso Pincio.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it