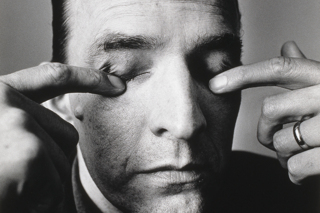Dalle tragedie peggiori è doveroso trarre insegnamenti. Il massacro antisemita di Sydney, in Australia, fa giustamente parte della categoria: niente lo può giustificare se non un odio allo stato puro. Gli ebrei praticanti che celebravano la festa religiosa di Hanukkah a Bondi beach sono stati uccisi in quanto ebrei: questa è la definizione primaria dell’antisemitismo.
Eppure, laddove sarebbe stato lecito aspettarsi una condanna comune e un atto di solidarietà nel rifiuto dell’antisemitismo, insieme al rispetto per le vittime, subito è scoppiato il furore della polemica, come un riflesso pavloviano in questi tempi di grandi cambiamenti e spaccature dovute alla rabbia.
Gli scambi delle ultime 48 ore tra il primo ministro australiano Benjamin Netanyahu e quello australiano Anthony Albanese si riducono a uno scontro verbale, quando avrebbero dovuto concentrarsi sulle vittime e sul cordoglio.
Il 14 dicembre il primo ministro israeliano ha accusato il capo del governo australiano di aver “gettato benzina sul fuoco dell’antisemitismo”, riconoscendo a giugno lo stato di Palestina, insieme alla Francia e ad altri paesi. Il 16 dicembre Albanese ha respinto al mittente le critiche, preferendo ricordare che questo momento dev’essere dedicato all’unità tra gli australiani.
Questo scambio è prima di tutto politico: Netanyahu, malgrado le circostanze tragiche, non si è fatto sfuggire l’occasione per tirare acqua al suo mulino e attaccare chi lo ha abbandonato sulla questione della Palestina. Ma accusare queste persone di essere complici dell’antisemitismo è uno sbaglio, oltre a rappresentare un danno alla lotta contro l’antisemitismo.
Ritroviamo l’eco di questa tensione anche nel dibattito politico francese, con le dichiarazioni del ministro Aurore Bergé che in tv ha accusato tutti quelli che hanno parlato di “genocidio” a Gaza di aver “armato i terroristi di Sydney”. È un’accusa che risulta ancora più vergognosa alla luce di ciò che sappiamo sugli assassini di Bondi beach.
Uno dei terroristi, infatti, era stato notato già diversi anni fa dai servizi di sicurezza australiani a causa dei suoi legami con il gruppo Stato islamico (Is), dunque la sua radicalizzazione non è legata alla tragedia di Gaza o alle critiche nei confronti di Israele. L’Europa conosce bene l’ideologia dell’Is fin dagli attentati del 2015. Parliamo di un gruppo jihadista radicale che non ha alcun interesse per i nostri dibattiti interni.
Quali insegnamenti possiamo trarre da quello che è successo? Il primo è che il ritorno dell’antisemitismo nel mondo è una questione che non va strumentalizzata. I morti di Sydney obbligano tutti i protagonisti del dibattito pubblico ad agire in modo responsabile davanti a questo flagello che avanza ovunque. A prescindere dall’appartenenza politica e dall’opinione sul conflitto israelo-palestinese, nessuno ha il diritto di usare l’odio nei confronti degli ebrei, o di qualsiasi altro popolo, per una battaglia di parte.
La stessa responsabilità ricade anche sui leader israeliani, che a forza di considerare qualsiasi critica alle loro azioni come antisemitismo, a cominciare dalle condanne per ciò che fanno i coloni in Cisgiordania, finiscono per banalizzare il problema. Esistono abbastanza antisemiti reali, non serve aggiungerne di fittizi.
La seconda lezione è che non ci siamo ancora liberati dell’Is, organizzazione di cui vediamo i tentativi di rinascita in Siria e che continua a fare proseliti fino in Australia. È una minaccia che riguarda la società intera, di cui l’Is evidenzia la vulnerabilità, sfruttandone le divisioni.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it