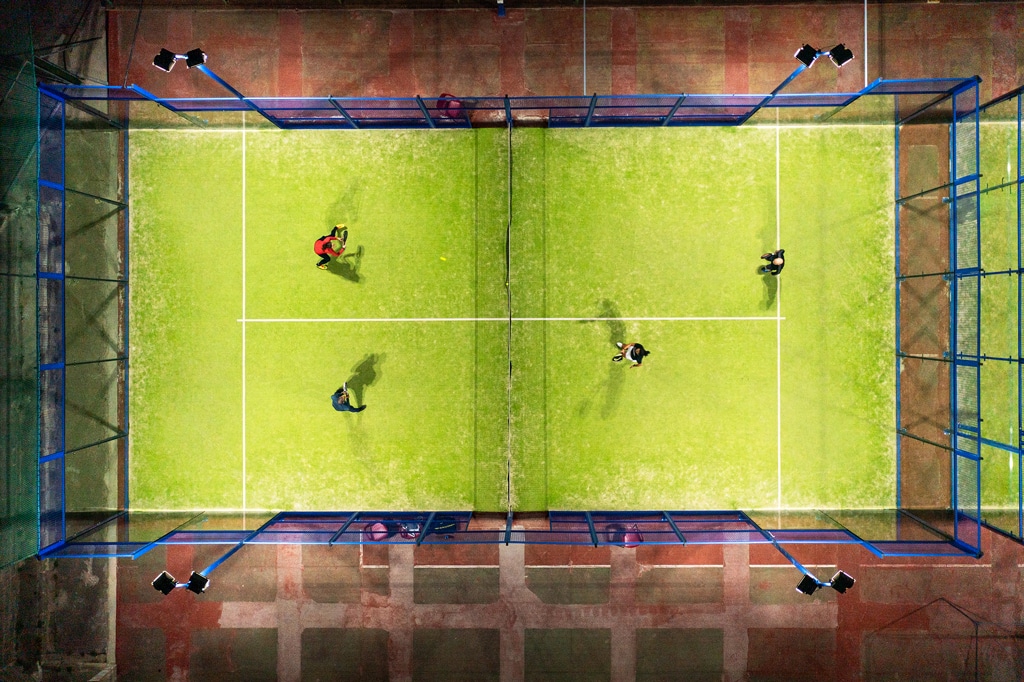Anche nell’epoca di internet, le conferenze rimangono la linfa vitale della scienza. I giovani più dinamici possono incontrare i vecchi baroni e fare pressione per ottenere un lavoro. Ci si possono scambiare idee sapendo che non si lascerà alcuna traccia digitale che in futuro potrebbe esserci rinfacciata. E i giornalisti possono presentarsi, raccogliere alcune storie interessanti e, con un po’ di fortuna, aggiornare i loro lettori e spettatori sugli sviluppi del tema della conferenza, qualunque esso fosse.
Le conferenze internazionali sull’aids, la prima delle quali fu organizzata ad Atlanta 35 anni fa, hanno svolto egregiamente tutti questi compiti. Ma ne hanno avuti anche altri due: hanno suonato un campanello d’allarme per ricordare al mondo che l’aids continua a essere un flagello per l’umanità, il che spiega la particolare benevolenza con cui sono accolti i giornalisti; e hanno fatto incontrare esperti e attivisti di paesi ricchi e poveri per migliorare lo scambio su problemi e soluzioni. Buona parte di questi incontri è costituita da colloqui faccia a faccia nella speranza che ne scaturisca qualcosa di buono. È quindi significativo che una delle conseguenze di un’altra pandemia virale, quella di covid-19, sia stata che gli organizzatori abbiano deciso di non tenerla più a San Francisco e di trasferirla nello spazio digitale.
Uno dei paradossi dell’aids è che sia uscito dal radar di molte persone proprio perché la risposta alla malattia ha avuto un grande successo. Questo rischia di far sottovalutare il problema, il che a sua volta rischia di provocare un riacutizzarsi della malattia. Unaids, l’agenzia delle Nazioni Unite incaricata di combattere la pandemia di hiv, ha diffuso il suo ultimo rapporto il 6 luglio, il giorno in cui si è aperta la conferenza. A prima vista sembrerebbe una lettura triste. Anche se i margini d’errore sono ampi, nel 2019 ci sono stati circa 1,7 milioni di nuovi casi d’infezione e 690mila persone sono morte. Alla fine dell’anno le persone positive e ancora in vita erano 38 milioni, di cui 25,4 milioni assumono farmaci antiretrovirali (arv) per mantenere sotto controllo la loro carica virale. Ma nonostante si tratti di numeri elevatissimi, la direzione intrapresa è quella giusta.
La recessione economica provocata dal nuovo ceppo di coronavirus potrebbe far perdere all’hiv il suo statuto prioritario
La comunità mondiale che si occupa di aids si sta avvicinando al traguardo che si era autoimposta, noto come 90-90-90. Ovvero identificare il 90 per cento delle persone infettate, curarne il 90 per cento e ridurre fino a farla diventare impercettibile la carica virale del 90 per cento dei pazienti curati. L’obiettivo, stabilito dall’Onu nel 2014, doveva essere raggiunto entro la fine di quest’anno. È sempre sembrato un traguardo ambizioso, ed è molto improbabile che sia effettivamente raggiunto. Alla fine del 2019 le stime medie in questione erano rispettivamente dell’81, 82 e 88 per cento.
Ma anche qui le cose si stanno muovendo nella direzione giusta. Quattordici paesi, tra cui Botswana, Cambogia, Ruanda, Zambia e Zimbabwe, riferiscono di aver raggiunto l’obiettivo 90-90-90. Due, Svizzera ed Eswatini (l’ex Swaziland), riferiscono di aver raggiunto il 95-95-95, che è in realtà l’obiettivo per il 2030. Nonostante l’Eswatini sia un piccolo paese, ha la più alta diffusione dell’infezione del pianeta (il 27 per cento delle persone tra 15 e 49 anni). La notizia deve quindi essere accolta come un successo.
Rimangono varie preoccupazioni. Il denaro disponibile per la lotta contro l’hiv in paesi a reddito medio-basso, quelli cioè dove è più diffuso, è in calo da un paio d’anni. Si tratta di un problema serio, poiché una delle spese fondamentali – quella per fornire antiretrovirali per cui sono vitali – aumenta inevitabilmente con il successo della lotta al virus, poiché ogni vita salvata dev’essere sostenuta da farmaci a tempo indeterminato.
Un’altra preoccupazione è legata agli effetti del covid-19. La recessione economica provocata dal nuovo ceppo di coronavirus potrebbe far perdere all’hiv il suo statuto prioritario agli occhi dei ministri delle finanze. Più nell’immediato, inoltre, il covid-19 minaccia d’interrompere la catena d’approvvigionamento dei farmaci arv. Il 1 luglio 36 paesi avevano segnalato all’Organizzazione mondiale della sanità dei disagi nei servizi di fornitura di questi farmaci.
In quegli stati vivono in tutto 11,5 milioni di persone che usano gli arv, circa il 45 per cento del totale mondiale. In 24 di questi, dove vivono 8,3 milioni di utenti, le scorte residue hanno raggiunto livelli definiti “pericolosamente bassi”. Unaids ha avvertito a maggio che, se nell’Africa subsahariana le cure con antiretrovirali dovessero subire disservizi per sei mesi di seguito, potrebbero morire circa mezzo milione di persone.
Con un po’ di fortuna, il covid-19 sarà solo un problema temporaneo. Sul lungo periodo, tuttavia, continua la ricerca di metodi migliori sia per curare le persone infettate dall’hiv sia per evitare che ce ne siano altre.
Un vaccino sembra più lontano che mai, e dalla conferenza sono emerse poche novità in merito.
Esiste tuttavia un altro mezzo di prevenzione che avanza con rapidità impressionante. Si tratta di una tecnica chiamata profilassi pre-esposizione (prep). Funziona offrendo preparati di antiretrovirali su misura per le persone che presentano un alto rischio di contrarre l’hiv.
La versione consolidata della prep usa una combinazione di due farmaci, emtricitabina e tenofovir, noti congiuntamente come Truvada. Secondo Unaids quasi seicentomila persone (per lo più uomini omosessuali) hanno assunto il Truvada almeno una volta nel 2019. Come spesso accade con i nuovi farmaci, dato il costo elevato molte di queste persone vivono in paesi ricchi.
Oggi tuttavia il Truvada viene impiegato anche nei paesi poveri. Secondo PrEPWatch, uno sportello senza scopo di lucro che fornisce informazioni sulla prep, ad aprile di quest’anno circa 56mila persone in Kenya stavano assumendo questa combinazione di farmaci, poco meno della metà dell’obiettivo fissato per questo paese dal Pepfar, l’organismo che eroga gran parte degli aiuti esteri degli Stati Uniti legati all’aids.
Nuove opportunità
E la prep sta migliorando. Un farmaco chiamato cabotegravir è attualmente oggetto di test clinici a questo scopo. Il cabotegravir è un inibitore dell’integrasi, cioè agisce impedendo all’hiv di copiare il suo genoma nei cromosomi delle sue cellule ospiti, una fase importante nel suo ciclo vitale. A differenza del Truvada, che dev’essere assunto quotidianamente per via orale, il cabotegravir profilattico viene somministrato sotto forma di iniezione una volta ogni due mesi.
Il cabotegravir sembra inoltre essere più efficace del Truvada. Una sperimentazione su 4.600 volontari (uomini omosessuali e donne transgender) in vari luoghi di Africa, Asia, Nordamerica e Sudamerica ha avuto un successo tale da essere interrotta a maggio, con 22 mesi di anticipo. Una sperimentazione parallela su donne volontarie, cominciata più di recente, viene oggi monitorata da vicino per capire se sta avendo un esito altrettanto positivo.
Le iniezioni periodiche, rispetto all’assunzione quotidiana di pillole, potrebbero essere una soluzione anche per la cura delle persone già infette. Anche in questo caso è previsto il ricorso al cabotegravir. Due test resi pubblici nel 2019, che prevedevano una combinazione di quello e di un altro antiretrovirale, la rilpivirina, suggeriscono che questa formula sia altrettanto efficace, se iniettata una volta al mese, dei normali farmaci assunti per via orale quotidianamente.
I progressi nella prevenzione e nel trattamento, quindi, sono chiaramente una possibilità. Uno degli annunci più interessanti della conferenza, tuttavia, è stato quello sulla possibilità di una cura.
Finora si pensava che solo due persone fossero guarite dall’aids. In questo caso parlare di guarigione significa che un paziente può smettere di prendere gli arv senza che il virus emerga dai cromosomi in cui si era nascosto. Ricardo Diaz dell’Università federale di São Paulo, in Brasile, pensa che ora possa esistere un terzo caso.
I due pazienti precedenti – ancora conosciuti perlopiù come “i pazienti di Berlino e Londra” – avevano subìto un trapianto di midollo osseo per curare i tumori del sangue da cui erano affetti. Con il consenso dei riceventi, il trapianto era stato fatto da donatori che avevano una rara mutazione genetica che rende immuni alle infezioni da hiv. Tuttavia si tratta di una procedura che non può, realisticamente, diventare un trattamento di routine, perché troppo pericolosa e costosa. Ma quella usata con il paziente di São Paulo potrebbe esserlo. La speranza del dottor Diaz è che quest’uomo sia guarito grazie all’uso di farmaci ordinari.
Il metodo usato dal dottor Diaz è chiamato “kick and kill” (attiva e distruggi). La prima parte consiste nell’attivare tutte le cellule con i geni dell’hiv integrati nei loro cromosomi, al fine di rendere attivi quei geni e trasformare così le cellule in fabbriche del virus. Le cellule con geni hiv integrati sono invisibili al sistema immunitario. Quelle in cui l’hiv è attivo invece no, e vengono ricercate e distrutte: è questa la seconda parte del trattamento.
Ingannare il virus
Il trucco sta nel trovare una combinazione adatta di molecole per procedere all’attivazione senza che il virus vada fuori controllo. La miscela del dottor Diaz è costituita da una coppia di potenti antiretrovirali chiamati dolutegravir e maraviroc, e da un derivato della vitamina b3 chiamato nicotinamide. Il medico ha somministrato dolutegravir, maraviroc e nicotinamide a un gruppo di cinque volontari per 48 settimane, nel quadro di un più ampio studio sui possibili trattamenti per l’hiv. I risultati provenienti da uno di questi volontari suggeriscono che il trattamento potrebbe aver funzionato, e il paziente ha smesso del tutto di assumere farmaci contro l’hiv nel marzo 2019. Il suo sangue è ancora privo di tracce di virus.
Ma la prudenza, in questo caso, è d’obbligo. Il dottor Diaz non ha prelevato campioni di tessuto solido, come i linfonodi, dove l’hiv tende a nascondersi, e la sua affermazione che il sangue del paziente sia privo di virus non è stata verificata in modo indipendente. Ma se arrivasse la conferma, e il paziente continuasse a star bene, si tratterebbe di un risultato importante. Un’alternativa sicura e permanente all’assunzione di arv per tutta la vita sarebbe una cosa meravigliosa.
Possiamo quindi dire che il trasferimento forzato della conferenza nello spazio virtuale abbia funzionato? Una tantum, certamente. Più di ventimila persone si sono registrate, un numero simile a quello dei precedenti incontri, e le diverse tavole rotonde hanno visto una buona partecipazione. Quanto ai partecipanti, Gopal Shrestha, un nepalese che è stato il primo sieropositivo a scalare l’Everest, ha dichiarato di aver trovato proficuo l’incontro. E Mark Dybul, capo fondatore di Pepfar, pur dispiacendosi per la difficoltà di collegamento a distanza, ha osservato che le future conferenze potrebbero ottenere i massimi risultati combinando la partecipazione fisica a quella virtuale. Se ciò accadrà, quella che è stata una decisione obbligata potrebbe aver prodotto qualche risultato positivo.
(Traduzione di Federico Ferrone)
Questo articolo è stato pubblicato dall’Economist.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it