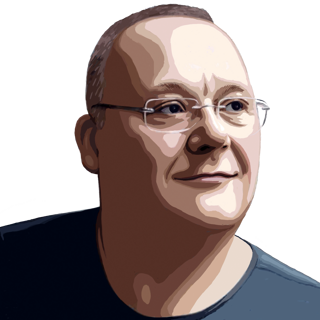Una strana nazione sta nascendo in Europa. Una nazione di “eterni” senza casa. Giornaliste afgane, professori iraniani, poete siriane, dottori yemeniti e molti altri il cui paese è così in rovina che non è possibile neppure averne nostalgia. Dal 25 aprile, come molti altri turchi costretti a vivere all’estero, mi chiedo se i dissidenti del mio paese non siano i nuovi cittadini di questa nazione ferita. Quando il tribunale di Istanbul ha emesso il suo ignobile verdetto al processo per le proteste del parco Gezi del 2013, la domanda “quando potrò tornare a casa?” si è trasformata in “ci sarà una casa in cui tornare?”. Non è stata solo la sentenza a scatenarla, ma il punto di rottura al quale è arrivata la Turchia.
Osman Kavala, imprenditore, attivista per i diritti civili e mio caro amico, è stato condannato all’ergastolo, e altri sette imputati a 18 anni di prigione, senza prove – se si escludono le registrazioni audio acquisite illegalmente – e con un’accusa insensata. I giudici però non si sono vergognati di fare quello che il presidente Recep Tayyip Erdoğan chiede da quattro anni: non avere pietà per i disobbedienti. Alla lettura della sentenza, una delle imputate, l’architetta Mücella Yapıcı, che ha dedicato la vita a difendere lo spazio pubblico dall’avidità dei ricchi e dei potenti, ha alzato il pugno destro e ha detto: “Sono morti sei ragazzi durante le proteste del parco Gezi. Diciotto anni in prigione non sono niente in confronto! Non me ne frega niente!”. Uno di quei ragazzi, Berkin Elvan, è morto dopo essere stato colpito da un lacrimogeno della polizia mentre andava a comprare il pane. Aveva quindici anni. Sua madre era nell’aula del tribunale e abbracciava un altro imputato, Can Atalay, un avvocato che si occupa di diritti civili. Atalay teneva il braccio di Yapıcı durante il suo ultimo discorso agli amici, mentre la polizia li spintonava: “Non cederemo a quest’oppressione. Resisteremo!”.
I giudici del tribunale di Istanbul non si sono vergognati a fare quello che il presidente Erdoğan chiede da quattro anni: non avere pietà per i disobbedienti
Çiğdem Mater, una produttrice incriminata per un film mai girato, è tornata dalla Germania, dove vive, per partecipare all’udienza, convinta che sarebbe stata assolta. Come altri è stata accusata di aver cercato di “rovesciare il governo”. Mentre i loro volti sconvolti sparivano dietro la folla di poliziotti, un gruppo di avvocati e amici ha cercato di lanciare un messaggio fuori dall’aula. L’ex giornalista e deputato del Partito dei lavoratori, Ahmet Şık, ha preferito mostrare rabbia invece che tristezza quando si è rivolto alle tantissime persone che hanno manifestato al parco Gezi nel 2013 ma non si sono presentate in aula. “Guardatevi allo specchio e chiedetevi: ‘Che persona sono?’”. Le parole di Şık hanno raggiunto chi su Twitter scriveva usando l’hashtag #WeWereAllThere (eravamo tutti là). Ironia della sorte, nelle stesse ore in cui Elon Musk ha fatto l’offerta per comprare il social network, hanno ricordato le proteste del 2013, cominciate proprio su Twitter, vergognandosi della loro assenza in tribunale.
Io sono una di quelle persone che avrebbero dovuto essere lì. Ho lasciato il paese nel luglio 2016, dopo uno strano tentativo di colpo di stato militare, quando sono cominciate le epurazioni di Erdoğan contro l’opposizione. Ero spaventata e arrabbiata. Essere etichettata come oppositrice del regime m’impediva di fare il mio lavoro di analista politica. Anche se rifiuto il termine, dal 2016 per molti occidentali la parola “esiliata” è diventata l’elemento più attraente della mia biografia. Negli ultimi sei anni, anche se le cose in Turchia sono peggiorate, ho sperato di tornare a casa. Ma il 25 aprile i miei amici in patria mi hanno ripetuto: “Il paese che ti manca non c’è più”. È la naturale conseguenza degli ultimi vent’anni di autoritarismo e dell’oppressione degli ultimi sei. Molti se ne sono andati, alcuni sono in carcere, e tanti altri sono scoraggiati dopo aver affrontato la repressione del governo nel 2013. Come se non bastasse ci sono la pandemia e una grave crisi economica.
Per questo la Turchia è piombata in un ostinato silenzio, il sogno di qualsiasi dittatore. Eppure la rabbia è ancora lì. Ecco perché sia Erdoğan sia i partiti dell’opposizione cercano di gestire a modo loro la tempesta in corso. Il verdetto sulle proteste del parco Gezi ci fa capire che il paese andrà alle elezioni nel giugno 2023 in preda a una repressione ancora più dura. Erdoğan non farà neanche più finta di allentare la sua presa per attirare qualche moderato. L’opposizione spera di gestire l’indignazione generale in un’elezione anticipata, incanalando l’energia politica verso le urne.
Nel frattempo molti in Turchia si chiedono se scendere in piazza ora o stringere i denti e aspettare il voto, che sicuramente non sarà regolare. Il punto di rottura è vicino, ma non è chiaro quali saranno le conseguenze. La mia unica speranza è il pugno destro stretto di Mücella Yapıcı. È l’unica cosa che mi ricorda la mia casa, quella che ancora mi manca. ◆ ff
Ece Temelkuran
è una giornalista turca che vive in Croazia. Il suo ultimo libro uscito in Italia è La fiducia e la dignità (Bollati Boringhieri 2021). Ha scritto questa column per Internazionale e per la versione inglese del quotidiano online turco Duvar.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1459 di Internazionale, a pagina 44. Compra questo numero | Abbonati